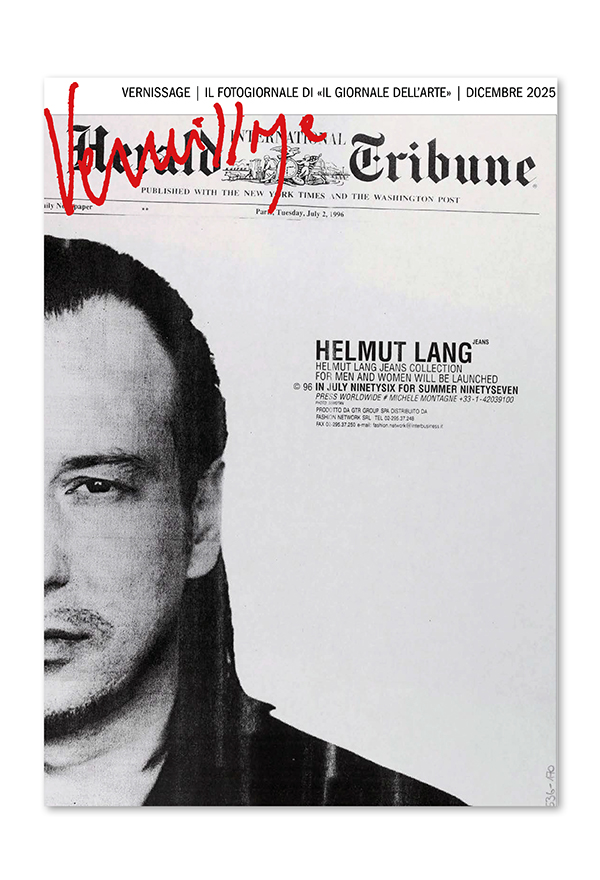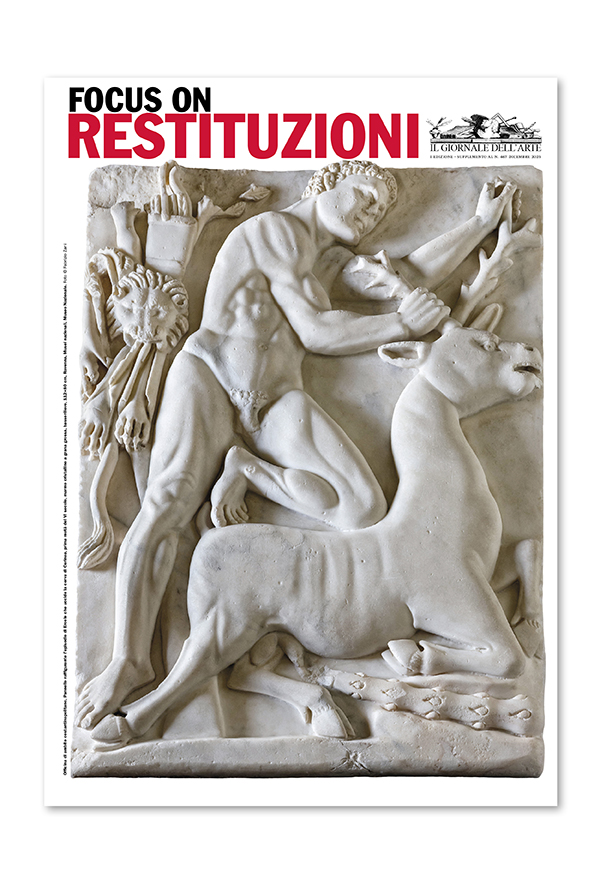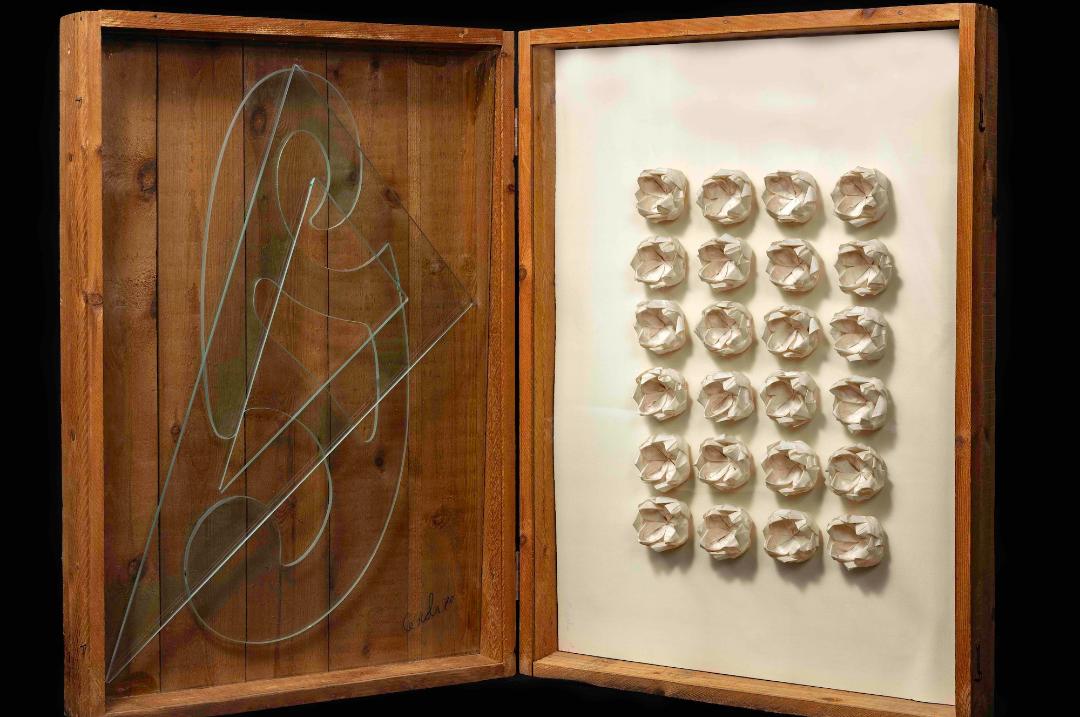Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Franco Fanelli
Leggi i suoi articoli«Parteggio per una storia dell’arte che finisce per attribuire forse troppa centralità alla figura del curatore»: con questo avviso ai naviganti Massimiliano Gioni, curatore di penultima generazione (ha 51 anni) guida il lettore attraverso 14 edizioni della Mostra Internazionale d’arte della Biennale di Venezia. Gioni intervista i suoi colleghi e avendo egli stesso curato una Biennale nel 2013, per raccontarla si affida alle domande di un predecessore, Robert Storr (Biennale 2007), mentre è toccato a Jean Hoffmann, che magari in futuro occuperà lo stesso ruolo, rimediare allo smarrimento della registrazione delle dichiarazioni di Harald Szeemann (curatore nel 1999 e nel 2001). Se questa iterata serie di confronti con consanguinei non produce esiti patologici è solo perché tutti gli intervistati si sforzano di limitare al massimo derive teoriche e di ripercorrere, attraverso le loro risposte, un pezzo di storia della più celebre mostra d’arte al mondo.
Si parte con Achille Bonito Oliva (curatore nel 1993) e si finisce con Adriano Pedrosa, che ha firmato l'edizione attualmente in corso. Sono i trent’anni in cui la Biennale di Venezia ha conosciuto quello che sinora è il suo massimo sviluppo in termini di area espositiva (con l'inglobamento di tutto il complesso dell’Arsenale), di pubblico, di artisti e di Paesi partecipanti. È la conseguenza della parallela crescita economica, sociale e geografica dell’arte contemporanea. La cui storia, beninteso, non è fatta solo dalle mostre, mentre resta aperto l'interrogativo su quanto le idee e le teorie elaborate o abbracciate da quell'ibrida figura, il curatore (critico, manager, impresario, teorico, comunicatore, demiurgo), andata via via consolidandosi in questo trentennio possano incidere sulla vita professionale degli artisti, se non addirittura sul loro modo di «pensare l’arte».
Se così fosse si potrebbe spiegare un paradosso: l’estrema eterogeneità formale e disciplinare che caratterizza l’arte d’oggi non elimina la sensazione di una sconcertante omologazione rispetto a un modo codificato di «fare l’arte». Il libro induce il suo lettore ideale, un cinquantenne (come minimo) che abbia per ragioni anagrafiche potuto visitare con cognizione di causa tutte le Biennali raccontate, a riflettere su quali edizioni e quali opere abbiano lasciato un segno nella sua memoria. Manca quella del 1997 (Celant morì prima che Gioni riuscisse a intervistarlo), ma le altre? Quella di Francesco Bonami (2003) fu davvero, come lui stesso la definisce, «l’ultima vera Biennale», spettacolarmente «catastrofica» e l’unica degna erede di quella grandiosa festa dell’arte offerta da ABO nel 1993? O anche: perché dopo Jean Clair, che curò tra non poche polemiche l’edizione del centenario, nel 1995, nessun presidente della Biennale osò chiamare un «eretico» rispetto al sistema contemporaneistico? Oppure: perché, di Harald Szeemann, sono passate alla storia la Documenta di Kassel del 1972 o, tre anni prima, la mostra «When Attitudes Become Forms» alla Kunsthalle di Berna, ma non le sue due Biennali di Venezia?
Quello raccontato dagli intervistati è anche il trentennio delle «prime volte»: del primo direttore straniero (Jean Clair), ad esempio, mentre 10 anni dopo María de Corral e Rosa Martínez, in tandem, furono anche le prime donne al timone della mostra. Robert Storr è stato il primo curatore americano e Bice Curiger, nel 2011 ha sdoganato in maniera clamorosa, con Tintoretto nel Padiglione Centrale, la presenza dell’arte antica in una mostra sino ad allora sempre più protesa al presente. Sta di fatto che da allora in poi il numero di artisti se non antichi quanto meno defunti è andato via via aumentando nella mostra centrale. Quella curata da Cecilia Alemani è stata invece la prima ad esporre, in misura schiacciante, più artiste che artisti. Okwui Enwezor (nel 2015) e ora Pedrosa hanno impresso un segno marcatamente politico, sociologico e antropologico alle loro curatele, ma la Biennale di Venezia, a parte questi due momenti di particolare prossimità con le ultime edizioni di Documenta, non ha mai derogato da una identità che abbraccia alcuni aspetti tradizionalmente impliciti all’arte visiva: la visionarietà, ad esempio, o la sperimentazione formale, il puro piacere estetico. In questi trent’anni sono stati piuttosto i sempre più numerosi padiglioni nazionali a farsi portatori di istanze ed emergenze politiche, economiche, ambientali e identitarie.
Perché le Biennali sono sempre due: quella del curatore in capo che con i suoi collaboratori e artisti pasteggia al caffè «Paradiso» all’ingresso dei Giardini e quella dei paesi partecipanti. Ecco perché una storia della Biennale raccontata soltanto attraverso le mostre centrali rischia di essere, oltre che parziale, vagamente «colonialista».
Caffè Paradiso
di Massimiliano Gioni, 295 pp., Johan & Levi, Milano 2024, € 23,00

La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria
Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca
Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?
Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai