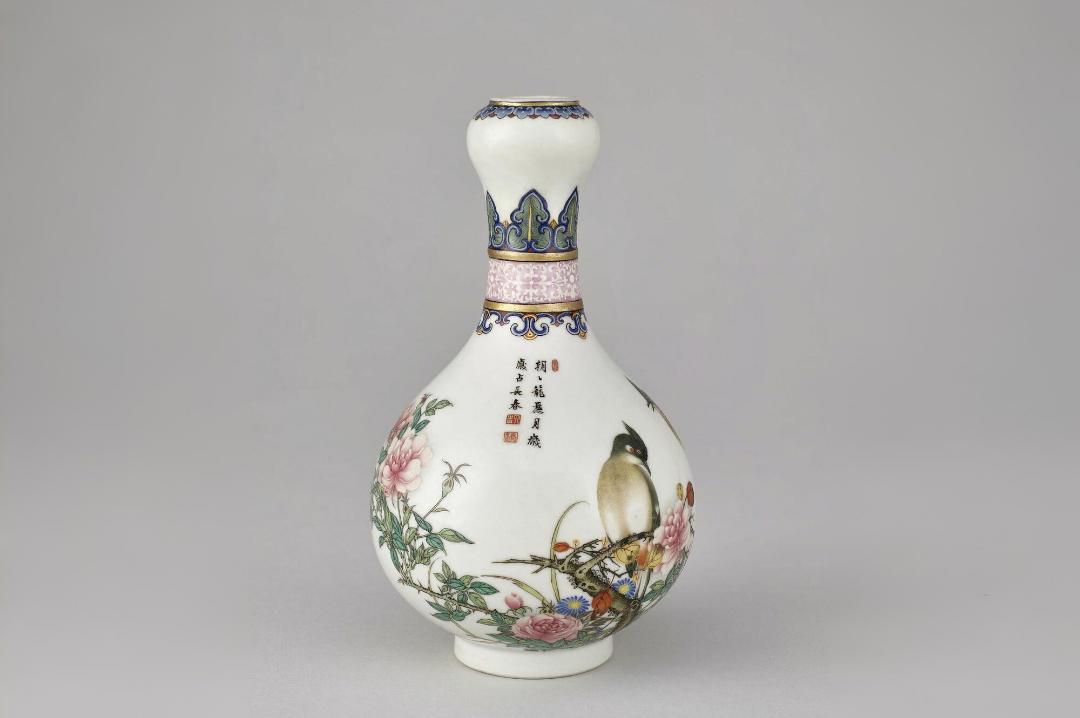Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliParigi. Giorgio de Chirico raggiunse il fratello Alberto a Parigi nella notte del 14 luglio 1911. Aveva solo 23 anni, ma nei primi lavori metafisici che presentò al Salon de l’Automne nel 1912 si trovavano già quegli elementi che sarebbero diventati centrali nella sua opera: il contrasto tra luce e ombra, la presenza di figure enigmatiche, la sensazione del tempo sospeso. A Parigi il suo stile singolare colpì il poeta Guillaume Apollinaire che lo aiutò a esporre alla galleria Paul Guillaume. De Chirico visse nella capitale francese fino al 1915, anno in cui partì a Ferrara per arruolarsi.
A questo «incontro» tra de Chirico e Parigi, e agli anni «dell’invenzione» dell’arte metafisica, il Musée de l’Orangerie ha voluto dedicare una mostra, «Giorgio de Chirico. La pittura metafisica», la cui apertura, in programma dall’1 aprile al 13 luglio, era attesissima ma che a causa della crisi sanitaria è rimasta in sospeso. Né a questo stadio si sa se potrà aprire una volta passata l’emergenza Coronavirus: molte opere non sono mai arrivate a Parigi e una tappa è prevista ad Amburgo, alla Hamburger Kunstalle, dal 28 agosto al 13 dicembre.
Oltre ai prestiti dall’Italia, dalla Fondazione Cerruti di Rivoli e dalla Collezione Guggenheim di Venezia tra gli altri, il Musée de l’Orangerie (che non possiede opere di de Chirico nella sua collezione) avrebbe presentato anche lavori importanti della Tate, del MoMA, del Metropolitan Museum of Art, della Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf e del Centre Pompidou. Il curatore della mostra è Paolo Baldacci dell’Archivio dell’Arte Metafisica.
Professor Baldacci, che cosa ci insegna di nuovo su de Chirico la mostra di Parigi?
Le mostre insegnano come capire un artista. Arrivando a Parigi nel luglio del 1911, de Chirico aveva già perfettamente chiara una nuova e rivoluzionaria concezione artistica, espressa nei quattro piccoli quadri che portava con sé e messa per iscritto negli appunti del 1911-12 che sono la base per conoscere la teoria della metafisica. Ma come pittore risentiva ancora della scuola tedesca in cui si era formato e gli mancava quel forte contatto con la modernità che ebbe invece a Parigi, girando per mostre e gallerie e assorbendo tutto ciò che poteva servirgli, da Gauguin fino a Matisse e Picasso. Ciò fece di lui un grande pittore capace di esprimere ciò che voleva con un impatto visivo straordinario. Ma ciò non significa che a Parigi si sia trasformato in un pittore modernista. Gli appunti teorici e i quadri rivelano una concezione artistica che non è antimoderna ma va «oltre» il moderno aprendo la strada a Dadaismo e Surrealismo. Come tutti i grandi, utilizzò quel che vedeva ma rimase sé stesso, e nel 1914-15, quando inizia la crisi del modernismo, la sua individualità artistica non ha confronti, tanto che lo stesso Picasso guardò a lui per traghettarsi verso la classicità. Anche il periodo ferrarese ha un taglio inedito che per la prima volta illustra l’influsso sull’iconografia metafisica degli arredi e degli apparecchi ospedalieri, oltre che della produzione di protesi per mutilati, documentando la presenza in quella pittura degli orrori «ortopedici» della guerra poi rifiutati da Roberto Longhi.
La mostra si sofferma anche sugli anni ferraresi (giugno 1915-dicembre 1918).
Anche per il periodo ferrarese è stata adottata una prospettiva relativamente nuova. Grazie alle ricerche di Federica Rovati si è potuta capire e illustrare qui per la prima volta l’influenza sull’iconografia di de Chirico, Carrà e persino Morandi, delle apparecchiature e degli arredi ospedalieri, oltre che dell’ampia produzione di protesi per mutilati, documentando in quella pittura una presenza degli orrori «ortopedici» della guerra che non fu estranea alla famosa stroncatura di Roberto Longhi, intitolata appunto «Al dio ortopedico».
Quale è stato il suo approccio all’opera di de Chirico?
Sono stato affascinato dalla ricchezza culturale del personaggio. De Chirico è una sfida continua e per raccoglierla è necessario avere le basi culturali giuste, cosa che è mancata alla stragrande maggioranza di chi lo ha studiato. Credo che aver rivoltato come un calzino tutto ciò che si credeva di sapere su di lui sia una delle maggiori conquiste della storiografia artistica dell’ultimo secolo e la si deve a noi dell’Archivio dell’Arte Metafisica. Nessuno, in Europa e nel mondo, può fare oggi a meno del nostro lavoro, che trova il suo coronamento nell’edizione del Catalogo Ragionato dell’opera dell’artista che pubblichiamo con Allemandi.
Che cosa vedrà il visitatore? Saranno presenti inediti?
Continuiamo a sperare che si possa aprire, ma sembra sempre più difficile. Se si potrà visitare si vedranno i principali esempi delle tre fasi della metafisica parigina: quella dei miti identitari (Torino, Arianna, la Grecia); quella della «solitudine dei segni»; e quella dell’«arte veggente», che esplora i confini tra visione profetica e follia. E quel che ho detto del periodo ferrarese. Inediti metafisici di de Chirico non ce ne sono: i quadri «scomparsi» sono molto pochi, di alcuni sappiamo che sono andati distrutti in un incendio, altri sono stati riutilizzati dal pittore tra il 1919 e il 1920. Che si trovi qualcosa è quasi impossibile.
Altri articoli dell'autore
Esposte al Louvre oltre 170 opere della collezione personale del primo presidente della Terza Repubblica francese
Triplice appuntamento nel centro culturale in Provenza: una collettiva allestita da Tino Sehgal, l’Ong E.A.T e l’opera grafica di Maria Lassnig
Attraverso 260 opere il Louvre traccia il ritratto di una civiltà «rimasta a lungo ai margini degli studi accademici», un popolo di soldati, ma anche di commercianti, architetti, scienziati e artisti
A quarant’anni dalla pubblicazione, le fotografie raccolte nel libro «In the American West» vengono esposte, per la prima volta in Europa, alla Fondation Henri Cartier-Bresson