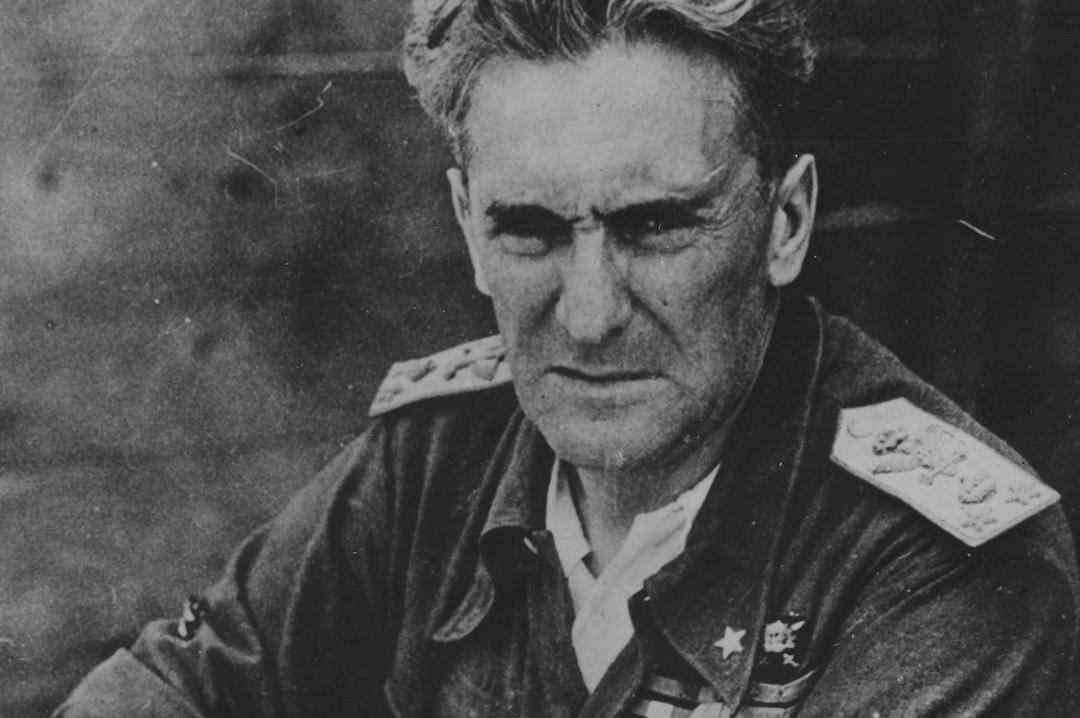Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliAbbiamo leggi inadeguate per reprimere e punire i reati contro il patrimonio culturale: pene risibili, impostazione obsoleta. Basta pensare alla anomalia più clamorosa: il reato di «furto d’arte» non è previsto. Per la legge è uguale rubare un Raffaello o un’auto usata. Tra i delitti più comuni contro i beni culturali è lo scavo clandestino di reperti archeologici, piaga gravissima, attività fiorente, spesso collegata al crimine organizzato, che porta con sé altri reati: esportazione e commercio illecito di reperti. Rari gli arresti (solo in flagranza) per queste attività criminali che valgono molte decine di milioni di euro all’anno e sono distruttive per l’archeologia e per la sua conoscenza.
Scavare illegalmente è di per sé considerato un reato, ma «residuale». Il Codice dei Beni culturali (art. 175) prevede la condanna massima a un anno di detenzione e una ammenda da 310 a 3.099 euro con attenuanti e distinguo «salvo che il fatto non costituisca più grave reato». Chi, scavando, trova e si impossessa di un bene archeologico (sempre di proprietà statale) rischia in teoria fino a tre anni di carcere: la multa va da 31 a 516 euro (art. 176 del Codice dei Beni culturali).
Altro esempio. Chi distrugge o danneggia un’opera d’arte o distacca un affresco, non è punito per questo, ma per la mancanza di autorizzazione a farlo: è un reato amministrativo. E se, senza autorizzazione, un ente pubblico vende un bene culturale è condannato a un’ammenda da 1.549 a 77.500 euro: perché diventi reato penale (arresto fino a un anno) deve essere dimostrato il dolo.
I progetti più recenti per cambiare la situazione sono dei ministri dei Beni culturali Giuliano Urbani (2003) e Giancarlo Galan: nel 2011 il successo sembrava vicino, il Consiglio dei ministri approvò un disegno di legge delega per contrastare i reati contro il patrimonio culturale. Poi il Governo Berlusconi cadde e non se ne fece più nulla. Finora tutti i tentativi sono falliti.
Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis