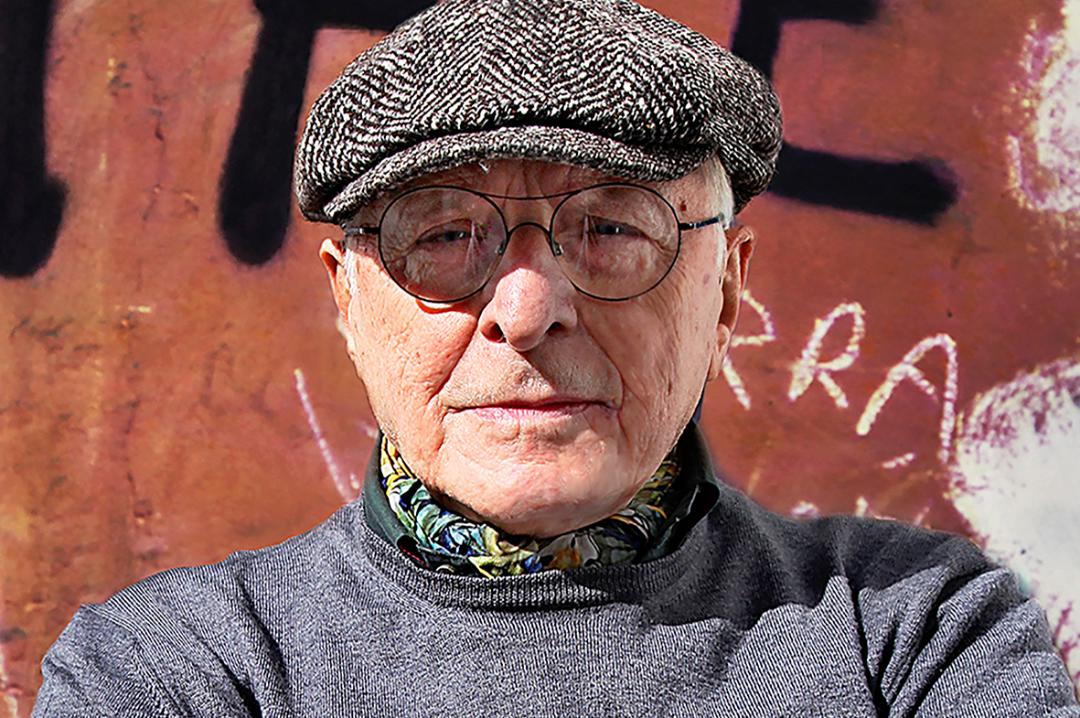Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Valeria Tassinari
Leggi i suoi articoliApre la 19ma edizione della Biennale Architettura (fino al 23 novembre), e di nuovo la scena internazionale si presenta a Venezia portando le istanze di un mondo cambiato e in rapido cambiamento, da raccontare e, possibilmente, trasformare. La volontà di fare di Venezia un simbolo di vulnerabilità, ma anche un luogo chiave per la riflessione su come reagire in maniera proattiva o emergenziale agli sconvolgimenti planetari, quest’anno appare particolarmente evidente. Visitando la Biennale Architettura 2025, infatti, si ricava immediatamente l’impressione di un’edizione particolarmente coesa e coerente con il progetto curatoriale di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e urbanista, che l’ha nitidamente intitolata «Intelligens. Natural. Artificial. Collective», un titolo programmatico, scritto con la sottolineatura della parola latina «gens», che indica un’identità collettiva che si riconosce in un’origine comune.
La grande manifestazione si espande, tra le sedi istituzionali e in quelle collaterali della città lagunare, tenendo saldamente al centro di ogni progetto la vocazione a proporre ipotesi e esperienze su forme multiple di intelligenza, cercando non solo di additare le criticità politiche, ambientali e economiche che affliggono il pianeta, ma anche di segnalare l’urgenza e la possibilità di attivare nuove sinergie, e nuove gerarchie, per reagire agli sconvolgimenti che agiscono a livello globale. Con 300 contributi progettuali di più di 750 partecipanti (architetti e ingegneri, naturalmente, ma anche numerosi matematici e climatologi, scienziati, filosofi e artisti, cuochi e codificatori, scrittori e intagliatori, agricoltori, stilisti, artigiani, e numerose creature vegetali e animali) anche questa Biennale, come quelle che l’hanno preceduta negli ultimi anni, si propone come sociale e corale, ma meno antropocentrica e più trasversale, nell’indicare vie di interazione tra il naturale e l’artificiale che comprendono risorse, organismi, modalità di elaborazione radicalmente differenti con un approccio davvero aperto a nuove visioni, che a volte attingono all’ancestrale, altre al futuristico, ma cercando modelli attuabili.
Numerosi i nuclei tematici, tra i quali dieci sono esplicitati dal curatore, per facilitare i visitatori nell’attraversare e cucire a distanza percorsi tra gli eventi collaterali, le partecipazioni nazionali (quest’anno sono 66) e i numerosi progetti selezionati, ma lasciando spazio aperto anche ad altre risonanze tra le diverse progettualità. Il range è ampio, si va da «Città in rete: IA, nuove energie e tecnologia digitale» a «Architettura oltre gli architetti: reti per la progettazione partecipata», o alla solo apparente polarizzazione high-tech e low-tech tra «Costruzioni robotiche: nuove alleanze uomo-macchina» e le «Materie circolari: alta e bassa tecnologia per il recupero e il riutilizzo». In generale sul piano estetico alcuni aspetti sono particolarmente ricorrenti come «Tree Tech: Architetture che imparano dalla natura», un paradigma che si incontra diffusamente tra i Giardini e l’Arsenale, attraverso la presenza di piante e specie arboree viventi o prese come modello; tra i padiglioni, insiste su questi aspetti quello del Belgio con Building Biospheres, un laboratorio di ricerca in tempo reale condotto dall’architetto paesaggista Bas Smets e il biologo climatologo Stefano Mancuso, che per i sei mesi di apertura della manifestazione intendono studiare il comportamento di un insieme di piante subtropicali poste all’interno, esplorando un rapporto tra natura e architettura in cui gli edifici siano microclimi artificiali in cui le piante possono purificare l'aria e rinfrescare.

Padiglione del Messico, Chinampa Veneta. Courtesy of La Biennale di Venezia

Padiglione del Belgio, «Building Biospheres». Courtesy of La Biennale di Venezia
«Alleanze per il Chthulucene: costruire per gli esseri umani e oltre» si ispira alla definizione coniata dalla filosofa Donna Haraway (Leone d’Oro alla carriera), e indica come in un tempo tormentato e disturbato si possa creare tra le specie una kinship (parentela) come «una strategia per la coesistenza e la resilienza»; suggestiva a questo proposito l’Elephant Chapel (menzione speciale della Giuria della Biennale) di Boonserm Premthada, architetto fondatore del Bangkok Project Studio, che con materiali tradizionali promuove empatia e rispetto per gli elefanti.
«Rifugi radicali: architetture di speranza in un clima difficile» è un tema tanto sensibile quanto sentito ovunque, perché riferibile a crisi climatiche, politiche, sistemiche nel mondo; nel Padiglione della Germania il progetto Stresstest, un’ambientazione immersiva spettacolare che ha coinvolto numerosi progettisti, propone una riflessione sugli effetti del calore e della crisi climatica nelle città. Tema che troviamo anche nei percorsi «Staying cool: negoziazioni tra sole e ombra» e «Troppa acqua, troppo poca: progettare tra gli estremi», che ci porta a scoprire la particolare tecnica di coltivazioni galleggianti della Chinampa Veneta nel Padiglione del Messico, un sistema agricolo sinergico che ha quattromila anni di storia.
E se non sorprende che a Venezia si parli di acqua, l’obiettivo è guardare oltre, nelle implicazioni politiche e sociali della relazione con le identità territoriali, come nel progetto sulle comunità idriche di Water Parliaments: Projective Ecosocial Architectures presentato dalla Catalogna tra gli eventi collaterali, e l’allestimento in grande scala di Terræ Aquæ, il densissimo Padiglione Italia curato da Guendalina Salimei che rende omaggio al rapporto tra l’Italia e l’intelligenza del mare con una (molto) vasta selezione di progetti, immagini, dati, documenti e visioni, incentrati sulla rilevanza delle coste marine, che nel nostro Paese sono estese per oltre 8.000 km.
Ma ci sono anche luoghi da esplorare chiudendo gli occhi: per il tema «Fuori dal mondo: il design negli spazi speculativi» - che raccoglie progetti fondati sull’intreccio tra scienza e design immaginativo per pensare futuri in habitat extraterrestri o immaginari - scegliamo di metterci in ascolto per poter immaginare. Si entra così nella città suggerita da Oxyville, la coinvolgente composizione di sound-design del pioniere della musica elettronica e multimediale Jean-Michel Jarre, che con Maria Grazia Mattei e Meet Digital Culture Center ha messo a punto un progetto di interazione, che offre l’occasione di concedersi una pausa in un ambiente vuoto illuminato di blu, dove sedersi per abbandonarsi all’esplorazione del rapporto tra suono e spazio architettonico, e provare a capire come questi ci risuonano dentro.

Elephant Chapel. Photo: Marco Zorzanello. Courtesy of La Biennale di Venezia

Padiglione Italia «Terræ Aquæ. L’Italia e l’intelligenza del mare». Courtesy of La Biennale di Venezia
Altri articoli dell'autore
Il 24 febbraio l’«Apparizione di san Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua» di Giuseppe Avanzi, non più visibile dal bombardamento del 1944, sarà ricollocata sulla parete del presbiterio della Chiesa di San Cristoforo alla Certosa
Una mostra nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra un maestro della fotografia italiana attraverso una serie di scatti a colori del 1972
Mentre il museo della manifattura è in ristrutturazione, alcune opere trovano il modo di essere esposte nell’istituzione, casa della ceramica, in provincia di Ravenna
A Firenze è in corso il primo ciclo di lezioni ideato dal noto coreografo e destinato a operatori e curatori museali, per imparare ad «abitare» il museo attraverso il corpo