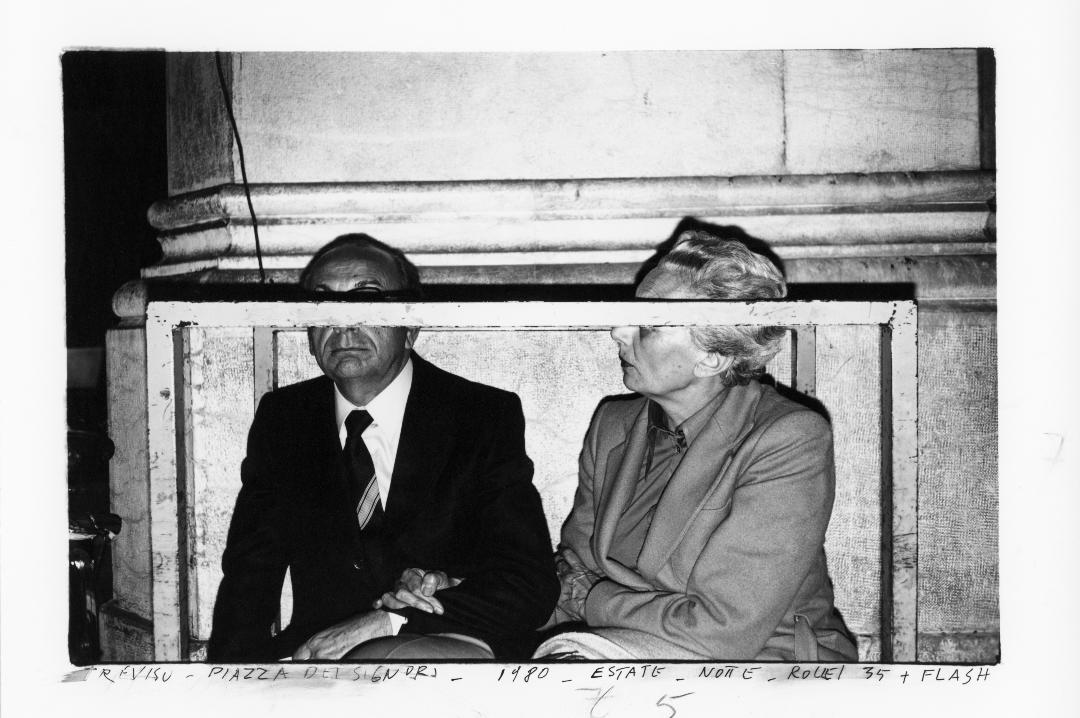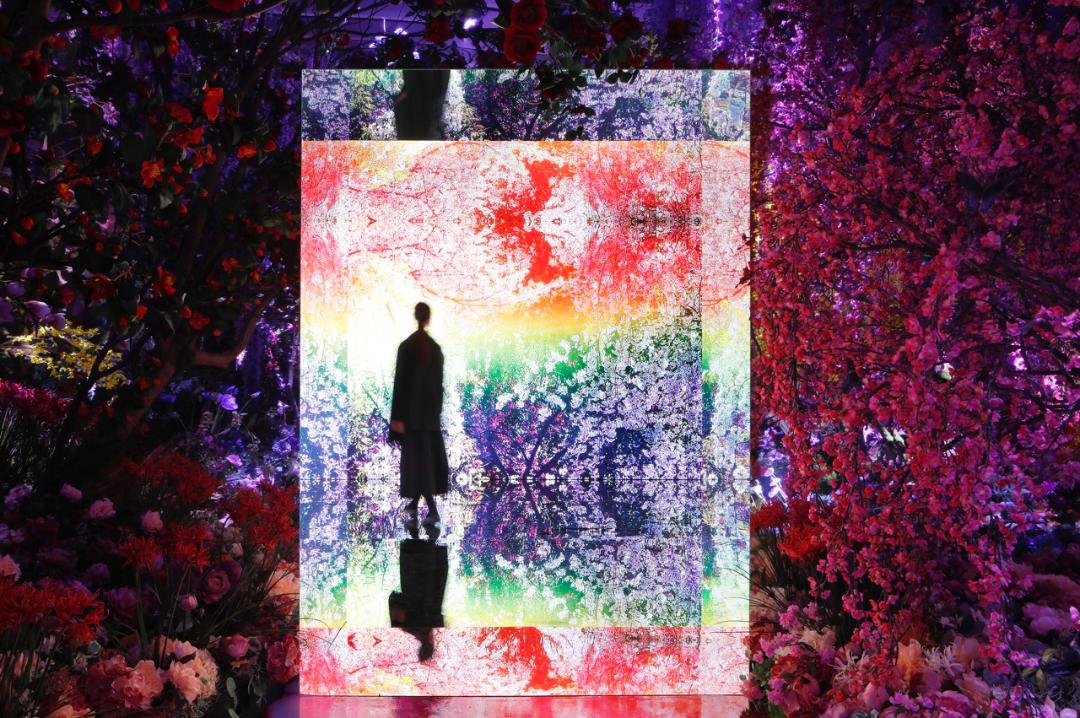Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Un fresco neologismo si è materializzato nel vocabolario inglese: «Bregret», fusione di Brexit e regret, cioè rimpianto, rincrescimento. Come ha dichiarato di recente (era il 13 gennaio) Sadiq Khan, sindaco laburista di Londra, facendosi interprete di sentimenti sempre più diffusi nell’opinione pubblica verso la «Hard Brexit» voluta dai Tories, oggi «la Brexit non funziona; ha inflitto un danno enorme al Paese: ha indebolito la nostra economia, lacerato l’unione interna fra le nazioni del Regno, sminuito la nostra reputazione». Danni diffusi che hanno toccato anche il mercato dell’arte, di cui Londra è stata negli ultimi decenni la capitale inscalfibile. Ora non lo è più, a tutto vantaggio di Parigi, che ha saputo muoversi per tempo con una tassazione agevolata, ritrovando così il ruolo centrale in questo mercato che aveva avuto in passato.
Solo negli ultimi tempi «sono state cancellate tre fiere: Masterpiece di Londra, Art & Antiques for Everyone di Birmingham e l’edizione estiva di Art & Antiques Fair Olympia», e si è assistito a una fuga generalizzata, con poche eccezioni, delle numerose gallerie europee che, per gli evidenti vantaggi fiscali ora del tutto vanificati, avevano aperto lì delle loro sedi e che ora hanno preferito rientrare nei Paesi d’origine o in Svizzera. Molte sono italiane e «Il Giornale dell’Arte» ha chiesto loro di spiegare le ragioni che le hanno spinte a questo passo.
Il primo a risponderci è Matteo Lampertico a Londra dal 2015 con ML Fine Art, rientrato a Milano nel 2020: «Londra era lo hub di tutto il mercato, mentre ora per gli europei ha perso ogni convenienza, a causa delle complicazioni doganali e delle spese, raddoppiate se non triplicate, rispetto al pre Brexit: oggi si paga infatti una tassa per l’importazione all’ingresso dell’opera, e una all’uscita. Se poi si vende a un italiano (e gli italiani erano la maggioranza dei nostri collezionisti) si deve aggiungere il 10% di Iva (detta paradossalmente «agevolata»), mentre per i francesi e i tedeschi, che hanno una tassazione più favorevole, il valore si attesta sul 5%. Ogni Paese, infatti, ha conservato la propria tassazione, e quella italiana è la più elevata. Non va poi dimenticato che molti collezionisti, che avevano casa a Londra, l’hanno lasciata e si sono trasferiti in Italia, anche per effetto della tassa fissa di 100mila euro all’anno sui redditi prodotti all’estero per chi si trasferisce o, nel caso degli italiani, per chi ritorna in Italia (dopo almeno nove anni di residenza all’estero, Ndr). Oggi Londra può funzionare solo per chi ha una clientela americana o asiatica, non per noi europei».
ConcordaLuca Gracis, una lunga consuetudine con la Gran Bretagna («Iniziai là nel 1987, da antiquario di arti decorative inglesi, sebbene avessi anche una galleria a Milano, con cui comunque avevo attivato collaborazioni con gallerie inglesi»), che dal 2015 al 2020, con ML Fine Art, ha operato continuativamente a Londra: «Tutto, all’inizio, era molto agevole per noi, che potevamo usufruire di un bacino di opere in Italia e potevamo portarle in Inghilterra per mostrarle ai collezionisti. Ma, anche per effetto della pandemia, con la Brexit si è giunti alla consapevolezza che bisognava lasciare Londra. È stata una grande tristezza ma non aveva più senso tenere aperta a Londra una galleria, che ha costi elevatissimi, quando c’erano tutti questi ostacoli. Oggi, per fare affari con gli inglesi, bisogna espletare una procedura estremamente complicata, il che crea una forte deterrenza. L’arte italiana oggi non si compra più a Londra ma, se mai, a Parigi, che è diventata la piazza internazionale europea. Le stesse Italian Sales sono state spostate a Parigi e questo è un segno eloquente del fatto che Londra sarà abbandonata dagli europei».
Anche Stefano Cortesi, fondatore e patron di Cortesi Gallery, ha lasciato Londra dopo sei anni di permanenza: «È stata un’esperienza molto positiva per la grande visibilità che ci ha portato ma, come per la maggioranza degli operatori, anche per noi il 90% del lavoro riguardava clientela europea e arte europea. Quando, con Boris Johnson, è stato chiaro che si sarebbe attuata una “Hard Brexit”, abbiamo rapidamente lasciato Londra e puntato da un lato su Lugano, città dove per altro io risiedo, che è sì fuori dall’Unione Europea ma che ha regole e procedure chiarissime e collaudate (mentre così non era nel Regno Unito), dall’altro su Milano, che è sempre più internazionale e sempre più attrattiva per gli stranieri. Per ora non può far ombra a Parigi, ma gioca un ruolo crescente, sebbene le nostre leggi creino ostacoli: l’Iva è la più elevata d’Europa, l’applicazione del diritto di seguito (il diritto dell’artista, e dei suoi eredi fino a 70 anni dalla morte dell’artista stesso, di riscuotere una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima, Ndr) è la più penalizzante, la burocrazia è un freno e la movimentazione fuori d’Italia delle opere, anche per chi, come noi, tratta l’arte del dopoguerra, è punitiva. Tuttavia siamo felici di questa scelta, perché Londra è ormai una città d’inglesi, arabi e asiatici, poco interessati alla nostra arte. Va però aggiunto che alla Brexit si sono sommati gli effetti del Covid e della crisi energetica: nel 2022 i costi di shipping e handling, a parità di volumi, sono cresciuti ovunque del 50% almeno».
Dopo quasi dieci anni a Londra (dal 2012 al 2021), anche Repetto Gallery si è trasferita, dall’ottobre scorso, a Lugano. E Carlo Repetto conferma che sulla decisione di aprire la sede a Londra, oltre all’argomento stringente dell’«efficienza ed effettività delle regole doganali e fiscali», aveva avuto molto peso anche il fatto che, proprio per ragioni fiscali, «Londra era allora altrettanto attraente per gli imprenditori europei: c’era un pubblico che trovavi solo lì e che, venuti meno con la Brexit i vantaggi, si è trasferito altrove. Pesantissimi, poi, erano diventati i costi doganali e dei trasporti, mentre i tempi per la movimentazione delle opere si erano enormemente dilatati: è accaduto più d’una volta che la merce rimanesse ferma in dogana per intere settimane, anche a causa del fatto che le norme non erano chiare per nessuno. Perché abbiamo scelto Lugano? Perché vivevamo tutti lì dal 2012 (e la nostra non è una multinazionale ma una family gallery) e perché volevamo avere una galleria in Europa (seppure fuori dall’Ue), realtà con cui dalla Svizzera è comunque molto più agevole operare. Una scelta di cui siamo pienamente soddisfatti».
Anche per chi, come la galleria Lorcan O’Neill di Roma, che rappresenta in maggioranza artisti inglesi, ha scelto di rimanere in Uk, la Brexit ha creato alcuni danni. Laura Chiari, direttore e partner della galleria, sottolineando che nel loro caso «la rotta Regno Unito-Italia è sempre stata la più percorsa», segnala che «l’attuale regime dell’importazione in Italia rappresenta un costo enorme e crea vincoli quasi incompatibili con l’attività di una galleria d’arte che opera tra questi Paesi. Tanto che dal 2020 non abbiamo ancora fatto mostre in Italia di artisti inglesi. Va detto però che c’è anche qualche vantaggio: per i collezionisti inglesi ora conviene di più acquistare opere d’arte in Europa che farlo in Inghilterra, e si è anche aperta la possibilità di appoggiarsi al porto franco di Londra. Rendere più facile agli inglesi acquistare in Europa e più difficile agli artisti inglesi fare mostre in Europa mi pare però l’esatto opposto degli obiettivi dichiarati dell’uscita dell’Inghilterra dall’Europa. Un tradimento completo delle promesse fatte agli inglesi. Come galleria europea legatissima al Regno Unito, noi bilanciamo strategicamente vantaggi e svantaggi. Ma, per l’affetto che ho per gli inglesi, è un grande dispiacere: qualcosa d’inutile per tutti…».
Fra chi resta comunque a Londra, c’è Angelica Pediconi, restauratrice e Fine Art Advisor lì attiva da molti anni, che pure non nasconde gli ostacoli sopraggiunti dopo la Brexit: «Dal gennaio 2021, data di esecuzione effettiva della Brexit per quel che riguarda la libera circolazione di oggetti, commenta, la nostra collaborazione con i clienti Europei si è notevolmente ridotta. All’inizio abbiamo registrato effettivi problemi dovuti alla totale incertezza delle nuove regole sul trasporto e la circolazione delle opere d’arte. Passavamo la maggior parte del tempo a cercare di risolvere quesiti doganali piuttosto che al microscopio o al cavalletto! Nonostante oggi ci sia maggiore chiarezza su regole e requisiti (non insormontabili) per la circolazione di dipinti verso e dall’Europa, la Brexit ha però fatto allontanare parte della nostra clientela europea e soprattutto quella italiana, forse più sull’onda di un impatto emotivo che strettamente logistico».
Resta a Londra anche Massimo De Carlo che anzi, dopo 13 anni e 90 mostre nella sua prima sede al 55 South Audley Street, a ottobre 2022 si è spostato al 16 Clifford Street, nel cuore di Mayfair: «Londra, chiarisce, è un’eccellenza nel mercato dell’arte da tempo immemorabile e indipendentemente dalla sua adesione all’Unione Europea. Ha una sorta di autorevolezza storica che negli ultimi anni si è rafforzata attraverso le istituzioni le fiere e le case d’asta che tuttora esprimono notevoli energie. Per chi è rimasto a Londra non ci sono particolari cambiamenti e, anzi, vi sono nuovi importanti iniziative e nuovi spazi a Cromwell, Notting Hill e Hyde Park Gate, che testimoniano lo sviluppo costante dell'arte contemporanea in tutto il Regno Unito, in modo decentralizzato e alternativo».
E resta a Londra, a dispetto delle complicazioni, anche Robilant+Voena, che là ha aperto la galleria nel 1990 e che è una delle realtà più importanti su quella piazza (cui si aggiungono le sedi di Milano, Parigi, New York e St. Moritz). Ma Edmondo di Robilant rileva che chi, come loro, «ha gallerie a Londra (dove per altro non ci sono grandi collezionisti: la clientela delle gallerie qui è sempre stata internazionale) e in altri Paesi, deve poter muovere agevolmente le opere da una sede all’altra. Un tempo, previa licenza d’esportazione, tutto avveniva in due giorni e con una spesa di 200-300 euro. Oggi invece, per spostare le opere, occorre una “temporary admission”, che richiede tempo e che ha costi aumentati di quasi dieci volte. Senza contare le difficoltà insorte per assumere dipendenti provenienti da Paesi Ue, che richiede procedure lunghe, complesse e costose, per il datore di lavoro e anche per il lavoratore. Un modo evidente per scoraggiare l’assunzione di persone esterne all’Uk. Del resto, i tre quarti delle gallerie che sono venute a Londra nel 2010-2012 si sono trasferite altrove. Una prova evidente della difficoltà di questo mercato».
Spese lievitate, dunque, ma anche pesanti difficoltà doganali e, almeno nei primi tempi post Brexit, totale assenza di una chiara regolamentazione riguardo al movimento delle opere: il baricentro del mercato dell’arte si è quindi spostato nuovamente sull’antica «capitale» di questo settore, Parigi. Dove, tra l’altro, operano i due più grandi collezionisti europei, Arnault e Pinault (quest’ultimo anche proprietario di Christie’s). E Milano? Può ambire ad aumentare il suo peso? Potrebbe, ma perché si possa affiancare a Parigi (è questa l’opinione condivisa, seppure con qualche sfumatura, da tutti gli intervistati), è indispensabile che s’intervenga sulle norme relative all’esportazione delle opere d’arte: «I collezionisti temono l’Italia, a causa dei veti non sempre comprensibili emessi dalle Soprintendenze».
Fra gli attori del mercato internazionale dell’arte non ci sono però i soli galleristi (e ovviamente le case d’asta) ma anche le società di servizi per l’arte che, proprio per il loro ruolo, sono punti d’osservazione privilegiati su questi fenomeni sovranazionali.
Alvise di Canossa, fondatore di Arterìa, leader in Italia nel trasporto, imballaggio, movimentazione e installazione di opere d’arte, e della più recente Art Defender, società di servizi integrati per l’art collection management, condivide la diagnosi sullo spostamento dell’asse da Londra a Parigi ma alla Brexit, in un’ottica generale, non addebita solo danni: «Il mercato dove per trent’anni sono passate tutte le operazioni più importanti, che era quello inglese, oggi è finito. La Francia ha colto la palla al balzo e ha ridotto immediatamente l’Iva, ma anche l’Italia si sta muovendo: con il governo Draghi c’erano stati alcuni cambiamenti, sebbene smuovere un sistema così stratificato (e anche così sensibile agli occhi dell’opinione pubblica) sia davvero difficile. Ora ci auguriamo che il nuovo Governo imprima un’accelerazione, anche perché non si tratta d’intervenire sul piano legislativo ma solo su quello dei regolamenti, per togliere i paletti d’inefficienza formale e funzionale che ci hanno lungamente puniti. Gli effetti sarebbero straordinari sul fronte commerciale ma, paradossalmente, metterebbero in sicurezza la sopravvivenza stessa dell’arte italiana, che rischiava di morire d’inedia. La Brexit? Ha certo spezzato abitudini consolidate nella movimentazione delle merci in generale e anche delle opere d’arte ma, a livello aziendale, per noi non ha inciso in maniera sostanziale: se mai, siamo stati chiamati a fornire consulenze su situazioni prodotte dalla Brexit, da cui poi sono derivati anche dei depositi. Ciò che, piuttosto, la Brexit ha prodotto, è una diversa consapevolezza negli investitori, il che ha accresciuto la richiesta di supporto fiscale e commerciale. Oggi c’è una nuova generazione d’investitori (più che di collezionisti), che è più attenta a queste problematiche e anche, necessariamente, a una maggiore trasparenza del mercato».
Erede della storica Frigoriferi Milanesi e leader nei servizi integrati per l’art collection management, Open Care, al contrario, come dichiara Edoardo Gnemmi, responsabile Art Advisory del moderno e contemporaneo, «negli anni post Brexit ha avuto un incremento notevole di clienti stranieri: latinoamericani, europei, ma anche italiani che vivevano in Inghilterra e che sono rientrati. Al momento dell’entrata in vigore della Brexit, Open Care ha avuto vantaggi immediati, specie per lo stoccaggio, i servizi e il magazzinaggio. Certo, ha inciso anche la concomitanza di questioni fiscali come la tassa fissa di 100mila euro per gli stranieri che trasferissero qui la residenza o per gli italiani che rientrassero in patria (e i collezionisti avevano tutti casa a Londra), ma l’Italia, e Milano soprattutto, potrebbero avere numeri ben più alti se le leggi fossero meno punitive. E anche, aggiungo, se Milano avesse il tanto atteso museo d’arte contemporanea. I numeri ci dicono che Londra ha avuto una contrazione dei fatturati del 20-30%, tanto che gallerie come Hauser&Wirth e Zwirner hanno spostato l’attenzione su Parigi. E la stessa Momart, un autentico colosso dei trasporti, stoccaggio e movimentazione delle opere d’arte, ha sofferto pesantemente. Ma non tutto può essere addebitato alla sola Brexit: la pandemia, la guerra e la crisi finanziaria hanno mescolato le carte e hanno un po’ nascosto le vere cause di questa situazione. Certo è che Parigi si è mossa per tempo, l’Italia no».

Tempo burrascoso in arrivo? Dopo la Brexit, l’importazione e l’esportazione di opere d’arte sono diventate più complicate e acquirenti e venditori devono far fronte a tasse più elevate. © Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
Altri articoli dell'autore
10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare
Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate
Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur
A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese