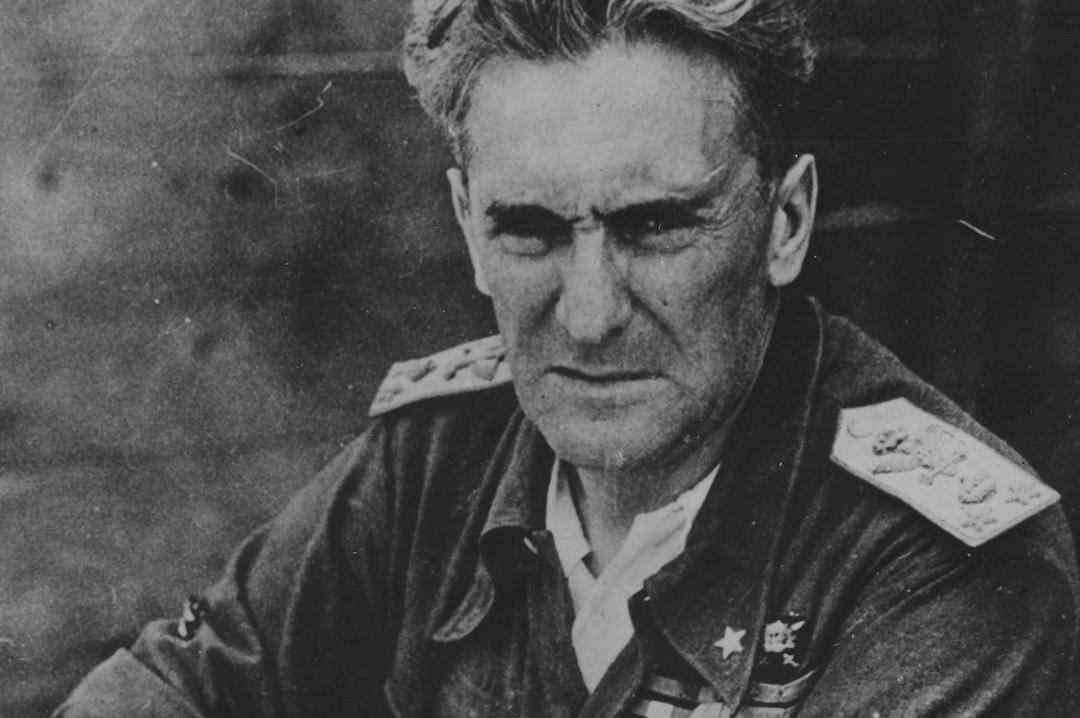Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliCaserta. Sono ripresi a gennaio e dovrebbero concludersi entro un paio d’anni, i grandi lavori di restauro della Reggia di Caserta. È un’impresa ciclopica e assai costosa, iniziata nel 2014, che dovrà risanare il più spettacolare palazzo reale del nostro Paese con il museo che contiene e l’immenso parco decorato da sculture, vasche e cascate. Sito Unesco dal 1997, da trent’anni in crisi di manutenzione e di visitatori, la Reggia è rinata ed è stata rilanciata come meta turistica solo negli ultimi anni grazie anche al forte slancio impresso dal suo primo direttore della «nuova era autonoma» dei musei, Mauro Felicori, sostituito nel 2019 dall’attuale direttrice Tiziana Maffei.
Oggi Caserta è stata riscoperta: nel 2018 era al sesto posto per numero di visitatori tra i grandi musei statali (senza contare Colosseo, Pompei e giardino di Boboli) con un picco di 845mila ingressi, dopo il record negativo di 428mila nel 2014. Nel 2019 c’è poi stato un calo a 720 mila soprattutto a causa della stretta sulle domeniche gratuite. Del resto nel 2014 la mancata manutenzione, frutto di decenni di incuria e carenza di investimenti, aveva portato la Reggia a una condizione di grave degrado.
La continua caduta di intonaci e cornicioni aveva reso insicuro anche un normale flusso turistico. Il colpo più duro arriva alla fine del 2013: crolla il tetto della preziosa Cappella Palatina con danni importanti anche all’interno della chiesa. Un’offesa incompatibile con la qualifica di sito Patrimonio dell’Umanità.
La svolta è arrivata proprio nel 2014 con la decisione di avviare un progetto di restauro radicale di tutta la Reggia. Nel 2016 erano già terminati i lavori sulle facciate esterne, quella anteriore all’ingresso, lunga 250 metri, e l’altra posteriore verso il parco. Il progetto prevede un forte impegno finanziario: 60 milioni di euro in totale assicurati dal fondo per lo Sviluppo e Coesione del Piano Cultura e Turismo 2014-20.
L’attuale intervento diviso in tre lotti dovrebbe concludersi entro l’anno in corso. Prevede il restauro delle facciate non toccate dai lavori ultimati nel 2016, il rifacimento dei tetti per evitare le attuali infiltrazioni d’acqua e il restauro della Cappella Palatina. Il secondo lotto è destinato alle opere d’arte e alle decorazioni delle sale e comprende anche i marmi dello scalone d’onore e i due letti monumentali di Gioacchino Murat e di Francesco II.
Il terzo lotto affronterà i problemi del parco, oggi parzialmente chiuso al pubblico: saranno restaurate la Palazzina e il Giardino inglese, la grande cascata e la peschiera. Spesi tutti i 60 milioni disponibili, ha dichiarato la direttrice Tiziana Maffei, avremo però risolto appena «il 40% delle esigenze del palazzo reale più grande d’Europa». Servirebbero insomma altri 80 milioni per completare i lavori necessari.
Intanto, altri 7 milioni sono stati stanziati per la sicurezza anticrimine di tutto il parco che prevede, spiega Tiziana Maffei, «un sistema tecnologico avanzato che ci permetterà anche di gestire il problema dei visitatori in notturna». Adesso gli incassi della Reggia dovrebbero comunque permettere di programmare finalmente quella manutenzione ordinaria troppo a lungo mancata. Al degrado, ai trent’anni di paralisi e di abbandono, al blocco di ogni iniziativa, aveva contribuito anche la presenza nel palazzo di una quantità di uffici pubblici con compiti diversi.
Basti pensare che, oltre alla Soprintendenza, le 1.200 stanze dell’edificio ospitavano la Scuola per specialisti dell’Aeronautica Militare, i Corpi speciali dei Ross e dei Nas, la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, il rettorato della Seconda Università di Napoli, l’Ente provinciale per il Turismo ecc. Deboli i tentativi di sfrattare gli inquilini, restii a occuparsi dei tanti problemi del palazzo e del parco, compresi quelli della sicurezza dei visitatori.
Ogni proposta si arenava di fronte a ostacoli burocratici e politici insormontabili. Finalmente nel luglio del 2014 una legge promossa dal MiBact ha deciso la «delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso», cioè il ritorno dell’intera Reggia «alla sua destinazione culturale e museale». Adesso si sta facendo ordine e la Reggia riconquista una magnificenza che aveva perduto, degna di essere parte del Patrimonio mondiale Unesco.
Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis