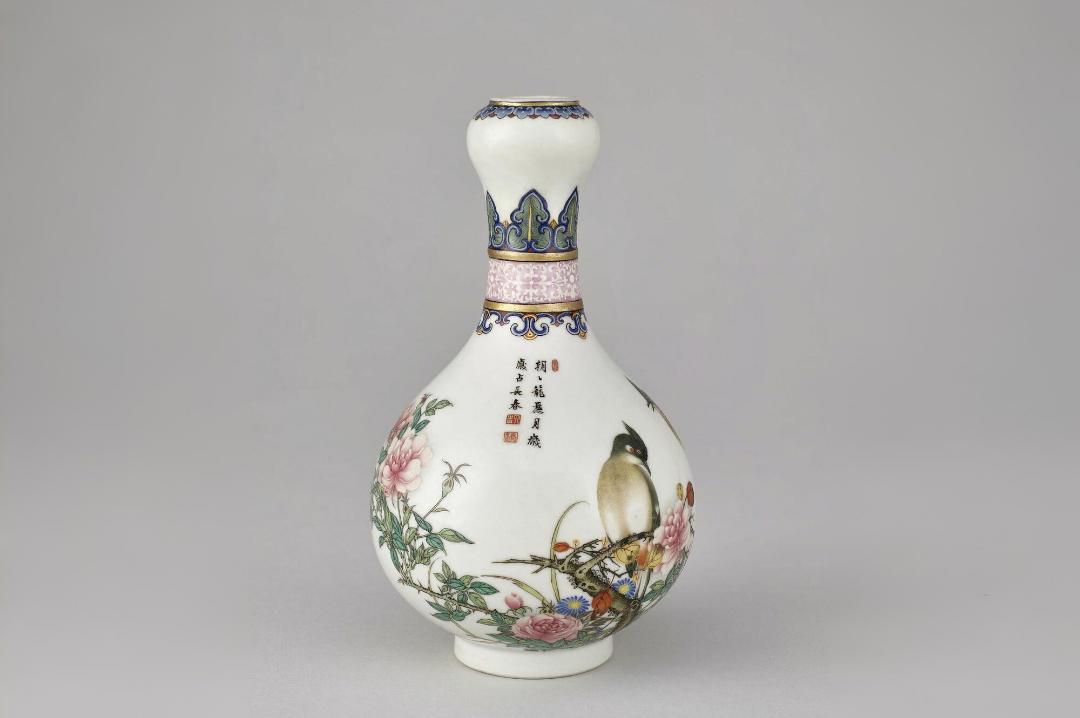Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliNel febbraio 2022, il British Museum aveva negato il permesso di realizzare degli scanner 3D dei marmi del Partenone, conservati a Londra dal 1917. La richiesta proveniva dall’Ida, Institute of Digital Archaeology, un laboratorio fondato da ricercatori delle Università di Oxford e Harvard, specializzato nella conservazione digitale dei beni culturali. In collaborazione con Atene, l’Ida progettava di creare i cloni perfetti di 32 sculture del Partenone, utilizzando la tecnologia dello scanner laser 3D e della scultura robotica, con obiettivo di fare pressione su Londra e riportare i celebri marmi in Grecia, che ne reclama da anni la restituzione. Il museo londinese rispose picche e negò l’accesso.
Ma gli esperti dell’Ida riuscirono di soppiatto a procurarsi le immagini digitali di un frammento esposto a Londra, quello del Cavallo di Selene, e a replicarlo in un atelier della TorArt, un’azienda high tech di Carrara. La copia fu poi esposta in novembre al Freud Museum di Londra. La vicenda del British Museum è particolare perché si inscrive nella storica disputa tra Atene e Londra sul ritorno in Grecia dei marmi di Elgin. Ma ha aperto anche una pagina nel dibattito attualissimo sulla gestione delle scansioni 3D dei beni culturali, strumenti a cui sempre più i musei si affidano per le loro enormi potenzialità in materia di studio e conservazione delle opere d’arte e che potrebbero svolgere un ruolo, per esempio, nella questione delicata della restituzione di opere trafugate. Ma l’accesso ai contenuti 3D e la loro stampa, in un contesto di opacità giuridica, pongono ancora diversi problemi in materia di rispetto dei diritti d’autore, dei rischi di contraffazione e dei falsi artistici, con i quali il British Museum non è il solo museo a essersi confrontato.
In Francia è in corso da anni una battaglia giudiziaria tra il Musée Rodin di Parigi e Cosmo Wenman, un operatore statunitense del mercato delle riproduzioni e attivista per la libera circolazione dei diritti di riproduzione. Wenman ha intentato una causa contro il museo parigino presso il Tribunale amministrativo di Parigi per costringerlo a fornirgli le scansioni 3D delle sculture di Auguste Rodin, che il museo rifiuta di cedere. Nel frattempo Wenman ha ottenuto l’appoggio di Wikimédia France, Communia e La Quadrature du Net, difensori dell’open data e dei diritti digitali degli internauti, che militano come lui per l’accesso open source agli scanner 3D dei musei.

Cosmo Wenman
La decisione del tribunale parigino è molto attesa. Se fosse a suo favore, rappresenterebbe un precedente per tutti i musei francesi. Il braccio di ferro con il Musée Rodin è iniziato nel 2017. Quell’anno Wenman contattò il Baltimore Museum of Art (Bma) per ottenere la scansione de «Il pensatore» di Rodin realizzata dalla società statunitense Direct Dimensions. Ma il Bma rinviò la richiesta al museo parigino, che possiede i «diritti morali» sull’opera di Rodin.
Wenman precisò al Rodin che le scansioni gli servivano a scopi commerciali, che le riproduzioni in bronzo delle opere sarebbero state fabbricate e vendute al di fuori dalla Francia e che non sarebbero state presentate come originali ma come copie. Il Musée Rodin rifiutò di consegnarle. Wenman non si arrese e, nel 2018, si rivolse alla Commission d’Accès aux Documents administratifs (Cada), che fornisce consulenza al Governo francese sulle questioni di libertà e circolazione di informazione. Nel 2019, la Cada ha confermato che i file digitali sono documenti amministrativi a tutti gli effetti e che quindi «in principio possono essere comunicati a chi ne fa domanda. Il museo, era precisato, dovrà far rispettare il diritto morale dello scultore e garantire il rispetto della sua opera».
Le dichiarazioni della Cada però non sono vincolanti e il Musée Rodin ha ribadito che non avrebbe consegnato i file perché questo avrebbe avuto «conseguenze disastrose» sul suo modello economico. Il 30-35% del budget del museo (poco meno di 10 milioni di euro nel 2021) proviene infatti dalla riedizione e dalla vendita dei bronzi. L’operazione è strettamente regolamentata dalla legge: il museo ha diritto di vendere come originali per ogni opera un massimo di 12 bronzi realizzati a partire dal calco originale dello sculture. Per «Il pensatore», ad esempio, i 12 bronzi sono già stati realizzati e ogni nuova riproduzione deve essere venduta come «copia».
Il museo, che si autofinanzia, ha subìto gli effetti della pandemia di Covid-19 tra chiusure e calo della frequentazione. Nel 2021 ha ottenuto una sovvenzione eccezionale dello Stato di circa 8 milioni di euro per realizzare dei lavori nei suoi depositi. In gennaio ha però dovuto abbandonare il progetto di aprire una sede a Santa Cruz de Tenerife: la città delle Canarie avrebbe acquistato 83 sculture di Rodin, di cui 68 copie di piccole e medie dimensioni, per circa 16 milioni di euro. Ma il progetto solleva da mesi l’opposizione locale.
La vicenda resta dunque sospesa alla decisione del tribunale parigino. Wenman è fiducioso. Nel 2019 ha già vinto una battaglia legale durata tre anni contro il Neues Museum di Berlino per ottenere l’accesso alla scansione 3D del busto di Nefertiti. Il museo tedesco alla fine ha dovuto cedere e consegnare in una chiave Usb le immagini 3D dell’opera, che Wenman pubblica in accesso libero sul sito da novembre 2019. A luglio 2022 Wenman ha avviato un’altra battaglia, questa volta contro la Réunion des Musées nationaux (Rmn), uno dei maggiori operatori culturali pubblici in Francia, che ha in gestione il Grand Palais, si occupa dell’acquisizione di opere d’arte, organizza mostre e gestisce i bookshop dei musei, ma che è anche editore e agenzia fotografica.
L’Agence Photo della Rmn ha sviluppato da qualche anno un «polo 3D» che, si legge sul sito, «mette a disposizione più di 800 riproduzioni 3D di opere di diversi musei nazionali». Alla Rmn Wenman ha reclamato la scansione 3D della «Pantera che cammina» (1904 ca), opera in bronzo di Rembrandt Bugatti conservata al Musée d’Orsay. Anche questa volta un’opera di dominio pubblico e che quindi dovrebbe poter essere riprodotta liberamente. Sul suo sito web cosmowenman.com, dove pubblica gli scambi di mail con i musei e i documenti in suo possesso, Wenman dichiara di aver chiesto alla Rmn le royalty da pagare spiegando che avrebbe utilizzato lo scanner 3D a scopi personali di studio.
Come il Musée Rodin, anche Rmn ha rifiutato di condividere i file, spiegando in una mail di non avere «l’autorizzazione dei musei partner di trasmettere ai privati i modelli 3D in alta definizione delle opere». Wenman ha di nuovo fatto appello alla Casa. Sul sito lascia intendere che sta preparando altre operazioni dello stesso tipo, una delle quali riguarderebbe il «David» di Michelangelo del Museo dell’Accademia di Firenze (cfr. articolo in pagina).
Il caso delle scansioni 3D del «Pensatore» ha spinto il Governo francese ad accelerare la regolamentazione del settore. Già nel 2015, il Ministero della Cultura aveva incaricato il Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique (Cspla) di riflettere sulle questioni economiche e giuridiche legate alla stampa 3D. Nel 2016, il Cspla aveva consegnato un rapporto in cui spiegava che anche il file 3D è protetto dal diritto d’autore «se reca l’impronta della personalità del suo autore e può quindi essere visto come un’opera originale». Di conseguenza anche l’oggetto stampato a partire da quel file è protetto. L’autore «può quindi agire contro la persona che realizza direttamente e senza autorizzazione la riproduzione».
Il Cspla spiegava inoltre che «l’applicazione dei principi del diritto comune sulla proprietà intellettuale e artistica permette già di sanzionare la contraffazione tramite stampa 3D», ma che il modo migliore per evitarla sarebbe «sviluppare un’offerta legale di stampa 3D» coinvolgendo tutti i professionisti del settore. Nel 2018, nel pieno della battaglia legale sull’opera di Rodin, il Governo aveva di nuovo sollecitato il Cspla perché riflettesse su una «Carta di buona condotta relativa all’uso dei dispositivi di digitalizzazione e di stampa tridimensionale finalizzata a evitare gli usi illeciti delle opere».
La «Charte Impression 3D» per il rispetto della proprietà intellettuale delle opere è stata finalmente pubblicata a marzo 2022. Agli operatori del settore delle riproduzioni viene chiesto per esempio di indicare «in modo visibile e indelebile»su ogni opera riprodotta la menzione «prototipo», di aggiungere nei file e sulla riproduzione un «numero di identificazione unico», di conservare i dati del cliente e di assicurare un «alto livello di sicurezza all’accesso dei file 3D». L’adesione alla Carta dà diritto ad un marchio di qualità «3D-Art-Confiance».
© Riproduzione riservata
Altri articoli dell'autore
Esposte al Louvre oltre 170 opere della collezione personale del primo presidente della Terza Repubblica francese
Triplice appuntamento nel centro culturale in Provenza: una collettiva allestita da Tino Sehgal, l’Ong E.A.T e l’opera grafica di Maria Lassnig
Attraverso 260 opere il Louvre traccia il ritratto di una civiltà «rimasta a lungo ai margini degli studi accademici», un popolo di soldati, ma anche di commercianti, architetti, scienziati e artisti
A quarant’anni dalla pubblicazione, le fotografie raccolte nel libro «In the American West» vengono esposte, per la prima volta in Europa, alla Fondation Henri Cartier-Bresson