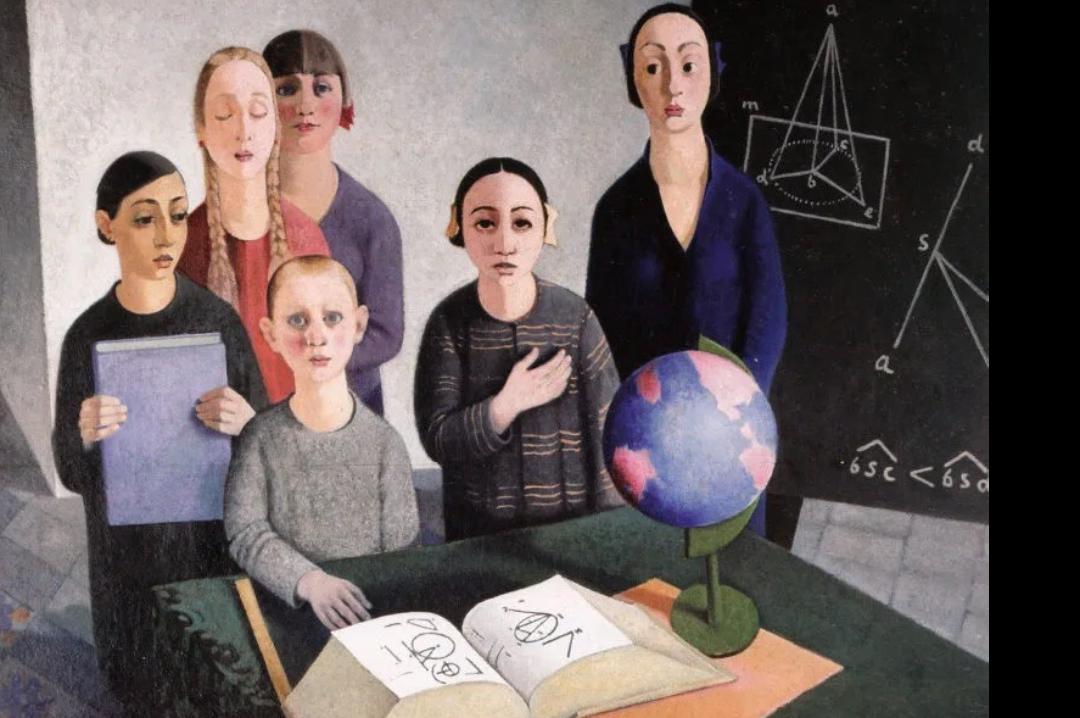Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliQuesto è uno dei non pochi libri pubblicati senza clamore, non alla moda, talvolta editati benissimo che sembrano destinati all’immobilità perpetua negli scaffali in cui vengono collocati ma che invece passano di mano in mano costantemente consultati da studenti e storici dell’arte. La giovane studiosa Benedetta Ciuffa ha dedicato la sua ricerca a François Spierre (Nancy, 1639-Roma, 1681), incisore lorenese che nel Seicento divenne famoso a Roma dove era approdato. Abbiamo intervistato l’autrice per capire la genesi di questo singolare volume.
Come mai ha deciso di scrivere un libro su Spierre, artista conosciuto solo dagli esperti?
L’idea di scrivere un libro su Spierre è maturata molto lentamente. Il mio primo incontro con il mondo delle stampe è iniziato nel 2005, quando in occasione della tesi di laurea mi fu chiesto di studiare la fortuna di Gian Lorenzo Bernini attraverso le stampe di traduzione, un argomento che contrariamente a quanto ci si aspetta non era mai stato affrontato in maniera sistematica nell’ambito della critica berniniana. La vastità del materiale avrebbe scoraggiato chiunque ma la passione ha iniziato velocemente a prendere il sopravvento, anzi direi il volo.
E così è iniziata la mia avventura nelle principali biblioteche di Roma, Firenze, Parigi e queste stampe non smettevano di sorprendermi perché ogni volta che pensavo di essere arrivata a un punto continuavo a fare delle nuove scoperte, alcune apparentemente insignificanti altre straordinariamente importanti: così senza accorgermene ho messo in piedi un catalogo ampio che è poi diventato il libro Bernini tradotto. Già in questa occasione, iniziai a rendermi conto che alcuni degli incisori che incontravo erano poco noti, altri erano totalmente caduti nel dimenticatoio. Negli anni successivi ho avuto l’opportunità di fare uno stage presso l’Istituto Nazionale per la Grafica e di lì a poco si è presentata l’occasione di una più lunga collaborazione con l’istituto che ha implementato le mie conoscenze e competenze.
Era infatti in programma la riedizione del Catalogo di matrici incise della Calcografia romana del Petrucci e io fui coinvolta nel progetto editoriale. Quella fu per me un’esperienza importante: potevo scendere nella Calcoteca, potevo maneggiare le matrici antiche e prendere dimestichezza con i segni che componevano quelle splendide immagini, ma anche con gli errori, i ripensamenti degli incisori stessi, o le censure postume. E’ come se toccare quei rami mi mettesse in contatto con quella fiorente e complessa industria del passato. Non nego che nel redigere il catalogo su Bernini, le stampe di Spierre mi avevano colpito per la loro bellezza.
Ma Spierre non era l’unico a spiccare. Il vero motore che ha acceso in me il desiderio di occuparmi di questo incisore è stato l’incontro con Evelina Borea che, nel 2015, ha tenuto una conferenza su Spierre dal titolo «Conversazione su François Spierre» in cui lamentava un inspiegabile disinteresse verso questo incisore lorenese. Filippo Baldinucci, che lo conobbe di persona, lo apprezzò al punto di includerlo nel Cominciamento fra i diciotto artisti che, a suo avviso, a partire da Dürer, avevano portato l’incisione a competere con la pittura, ossia elevarla al massimo grado dell’arte. Eppure, al di fuori di un vecchio studio di Frauke van der Wall e dei più recenti articoli di Bénédicte Gady, davvero poche erano state le penne che avevano sprecato inchiostro per omaggiare questo giovane e promettente incisore.
E così è iniziata la mia avventura che non voleva limitarsi a ricostruire il catalogo (già elaborato da van der Wall) ma voleva far rivivere quel graveur strappato alla vita a soli 42 anni. Aveva più o meno la mia età quando è morto e già aveva conquistato il cuore di Pietro da Cortona e Bernini, divenendo in pochi anni l’incisore più pagato di Roma. E più guardavo le sue stampe più apprezzavo la sua maniera pittorica: nessun incisore aveva mai saputo cogliere, con tanta sensibilità, l’ineffabile tenerezza della pittura correggesca o la potenza di quella del Cortona. E’ davvero sorprendente il potere delle incisioni, quello di creare capolavori unici in esemplari multipli.
Quanto tempo ci ha messo considerando la quantità di ricerche archivistiche?
La mia ricerca su Spierre è durata più di tre anni: iniziata nel 2016, in occasione del dottorato di ricerca che mi ha permesso di dedicarmi a tempo pieno a questo artista, si è protratta anche dopo la discussione della tesi perché la cosa entusiasmante di studi come questi è che sono sempre ricchi di sorprese! La prima preoccupazione è stata quella di redigere un catalogo il più completo possibile, andando alla ricerca dei diversi stati dei rami, delle matrici e dei disegni preparatori, soprattutto di quelli non noti alla critica.
Nei primi mesi ho organizzato il materiale facendo tesoro di quello già catalogato da Frauke van der Wall. Ma mancavano all’appello diverse stampe citate da Baldinucci e dai repertori sette-ottocenteschi, così è iniziata l’avventurosa ricerca delle stampe «perdute» e degli «stati» non noti. E questo percorso di ricerca è stato accompagnato da una guida d’eccezione, Pierre-Jean Mariette, probabilmente il più grande conoscitore di stampe di tutti i tempi, oltre al nostro Baldinucci. Le conoscenze multiple e infallibili, sempre puntuali e raffinate, di Mariette sono apparse il più adatto viatico a una ricerca di questo tipo. Non è un caso, infatti, che il libro contenga anche una trascrizione integrale delle Notes di Mariette, fino ad oggi mai pubblicate, per la cui interpretazione devo molto alla pazienza di Philippe Rouillard. Parallelamente ho iniziato a muovermi in ambito archivistico, spinta dalla curiosità e dal desiderio di trovare qualcosa di nuovo.
La ricerca d’archivio è stata la parte più dura, soprattutto quella condotta a Parigi, perché, si sa, è facile incappare in momenti di stallo. Si passa da giornate in cui si fanno grandi scoperte a giornate in cui non si cava un ragno dal buco: e così è stato anche per me. Ma alla fine tutto si è ricomposto come in un magnifico puzzle. Sono emersi il contratto di apprendistato presso Nicolas (e non François) de Poilly, ma anche tutti quei certificati di matrimonio e battesimo che hanno permesso di dare un nome ai suoi fratelli, due dei quali morti molto piccoli, nonché numerose mogli del padre, rimasto più volte vedovo. Sì perché man mano che la ricerca avanzava emergevano nuovi dettagli, nuovi nomi, come la misteriosa sorellastra e quel fratellastro premostratense, citati nel testamento, che alla fine sono stati identificati.
Roma e Firenze sono state ancor più generose di Parigi e Nancy per quanto riguarda i documenti: dal testamento, al certificato di morte di Spierre, ai permessi ottenuti per la pubblicazione del Breviario, alla querela contro François Chéron, alla lettera tra Alessandro Rimbaldesi e Leopoldo de’ Medici che spiega tanti retroscena, al conto in banca dell’incisore che non registra i grandi guadagni riferiti da Baldinucci. Sì, ci sono voluti tempo e fatica, ma questo scandaglio sembrava doveroso: il volume non sarebbe stato lo stesso senza questo immenso sforzo, uno sforzo che è stato alleviato dall’affetto e dall’aiuto di tanti amici studiosi, da Simonetta Pprosperi Valenti Rodinò a Maria Barbara Guerrieri Borsoi, a padre Sandro Corradini, a Maxime Préaud, punti di riferimento inestimabile di questi anni.
Perché proprio Spierre e non uno dei tanti altri incisori che lavorano in Roma?
Perché Spierre aveva lavorato per Bernini, anzi fu scelto personalmente da Gian Lorenzo per tradurre i suoi disegni. Se consideriamo che Bernini rimase sempre estraneo alla riproduzione grafica delle sue opere e che non strinse mai sodalizi con gli incisori, se non in rarissime occasioni, ci rendiamo conto che Spierre aveva un quid in più rispetto agli altri intagliatori della sua epoca. Molto probabilmente, agl’occhi di Gian Lorenzo, erano uno dei pochi, se non l’unico, ad essere all’altezza di questo arduo compito. La qualità dei suoi intagli doveva essere dissotterrata, riportata alla luce, come è accaduto per un altro incisore che mi piace molto, Mellan (anche lui particolarmente amato da Gian Lorenzo) da cui, non a caso, non si discosta molto per la perizia tecnica.
Perché le incisioni sono così importanti per la storia dell'arte?
Perché, se ci pensiamo bene, le stampe (oltre ad essere «lo specchio dell’arte») sono il «fondamento dell’arte», per usare una locuzione nota. Oggi basta digitare il nome di un artista o il titolo di un’opera su Google e subito ci appaiono centinaia di immagini, ma un tempo non era così. Per vedere le opere dei grandi artisti bisognava mettersi in viaggio verso Roma. Le stampe sono state una grande rivoluzione, hanno divulgato le opere dei più grandi artisti facendosi foriere della loro maniera, delle loro idee e del loro stile: sono state la scuola per giovani artisti in erba, volenterosi di imparare.
E a proposito mi torna in mente il caso di un apprendista (il cui contratto di apprendistato è stato rinvenuto e pubblicato da Maria Barbara Guerrieri Borsoi), il diciassettenne Carlo Pattone, mantenuto a Roma da un suo parente che a un certo punto, in luogo delle lezioni private, per ridurre le spese compra per il ragazzo delle stampe da imitare tratte da opere d’autore, acquistabili per 10 centesimi, con l’intenzione di fornire dei buoni modelli a costi contenuti. E sì perché la rivoluzione delle stampe la spiega bene Baldinucci quando ci dice che queste hanno reso le opere dei grandi artisti «comunicabili a tutto ‘l mondo», grazie alla maneggevolezza e ai costi contenuti. C’è ancora molto da studiare sulle stampe: come scrive De Piles, si poteva fare un uso molto variegato di quell’enorme patrimonio, talmente esteso e diversificato da essere ancora oggi conosciuto solo parzialmente.
C’è però da dire che queste stampe non sono solo state foriere di modelli, ma hanno contribuito, direttamente e non, a diffondere la fortuna di alcune opere piuttosto che altre, non senza censure e contraffazioni che hanno pesato sulla reputazione di un artista e sulla fortuna delle loro opere. Ci sono artisti che hanno incentivato la riproduzione dei propri capolavori, altri che ne sono rimasti fuori, come Bernini, divenendo spesso vittima delle logiche dell’industria editoriale. E non è un caso che l’andamento della produzione di stampe di un determinato periodo ci rivela cambiamenti del gusto e della sensibilità critica. Siamo abituati a leggere e cercare le testimonianze «scritte» del passato per ricostruire la vita e la produzione degli artisti, eppure alla loro gloria hanno contribuito non solo le penne dei sostenitori o detrattori ma anche la circolazione delle stampe, una sorta di «istantanee del passato» in grado di raggiungere «le più lontane nazioni» e un pubblico meno colto.
Quante persone pensa potranno leggere un libro così sofisticato come il suo? Siamo in un mondo di incolti digitalizzati.
Forse poche, ma sicuramente sarà letto da storici dell’arte e amanti della grafica e questo è quello che conta. Il mio intento era quello di portare un contributo di conoscenza su questo campo che ormai mi appartiene e ridare visibilità a Spierre. Il digitale aiuta ma non sostituisce la profondità di un libro.
Lei è conscia del fatto che questo suo libro resterà alla faccia di tutti quelli che di fronte a questo tipo di pubblicazioni storcono il naso perché non le capiscono?
Sì, ma non lo vivo come un problema. Mi sono dedicata per anni a fare ciò che mi piace e la pubblicazione del libro su Spierre, come di quello su Bernini, è stata prima di tutto un regalo che ho fatto a me stessa perché conosco bene la fatica e i sacrifici che stanno dietro ad uno studio come questo e sarebbe stato un lavoro vano se non avesse visto la luce. Non è un libro per tutti ma per pochi esperti, curiosi, o semplicemente appassionati, ma è comunque un tassello che si aggiunge alla cultura artistica del Seicento.
Prossimo libro?
Il prossimo libro sarà sicuramente su un altro incisore francese, un incisore poco studiato (come Spierre) che ha prodotto capolavori che necessitano di essere rispolverati e catalogati, sto pensando a Benoit Thiboust o Jean Baron. Sicuramente un bulinista francese perché la tecnica del bulino, molto più difficile dell’acquaforte, la trovo più magnetica. La ricerca delle stampe mi diverte e mi dà grande soddisfazione, rimarrò nell’ambito della grafica del XVII secolo. E mentre penso al mio futuro libro, aspettiamo il prossimo volume della collana Segni e impronte che la casa editrice Artemide ha pensato insieme a Giorgio Marini, direttore della collana, e al Centro studi sulla cultura e immagine di Roma, per riscattare l’arte grafica dalla perifericità cui è stata sempre relegata.
Perché un ragazzo di oggi che studia storia dell'arte dovrebbe leggere il suo libro e studiare il mondo delle stampe antiche?
Perché, come dice Giuseppe Avigliano, «i libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami», in questo caso tra vite del passato, storie, opere, committenti. Il mio libro su Spierre non sarebbe esistito se anche io non mi fossi nutrita degli studi degli altri storici dell’arte, del presente come del passato. E poi potrebbe essere lo spunto per qualche ricerca, visto che alcuni aspetti, come quello dello Spierre pittore, sono ancora sfuggenti.
Credo che quello che più potrebbe piacere ad un ragazzo che si avvicina a questa materia, tralasciando il corposo catalogo, sia proprio lo scandaglio delle vicende umane e professionali di Spierre, le connessioni con le persone e le vicende di quegl’anni: dalla numerosa famiglia di Spierre affranta da tante perdite, alle condizioni in cui viveva nella bottega del Poilly durante il breve apprendistato, alla rissa scoppiata in una delle osterie romane che frequentava, alla stridente povertà che emerge dall’arredo della sua ultima dimora, etc.
Ma il libro traccia anche un’accurata evoluzione stilistica, che un buon storico dell’arte non deve trascurare, e si pone tante domande sul rapporto tra artista e committente, perché nel caso di Spierre sembra particolarmente evidente che in più di qualche occasione il suo «acceso desiderio d’inventare» sia stato forzatamente messo da parte. Quanto davvero un incisore era libero? E poi le stampe restituiscono pezzi del passato, per questo sono fondamentali: ci danno la possibilità di guardare opere andate perdute (ne è un esempio La Trinità e San Michele che lotta contro il drago del Berrettini) o che, nel corso dei secoli, hanno subito delle censure. Le incisioni sono dei documenti visivi fondamentali per chi lavora in questo campo.
Credo infine che, al di là del tema che può interessare o meno, questo libro (come molti altri che si nutrono di ricerche d’archivio) abbia il potere di insegnare una cosa agli studenti: la pazienza, la dedizione, la meticolosità, l’idea che senza fatica non viene nulla. Mi capita sempre più frequentemente di vedere i miei studenti avere un approccio frettoloso con i libri, con lo studio. Spero che questo volume trasmetta almeno la serietà e il piacere della ricerca.
E perché un antiquario o un esperto d'arte dovrebbe possedere il suo libro?
Il libro apporta un contributo di conoscenza significativa al mondo della grafica per la dovizia di informazioni, si pensi ad esempio all’identificazione dei vari stati dei rami che un esperto dovrebbe saper riconoscere, soprattutto gli stati di prova particolarmente rari e ambiti dai collezionisti. Le prime tirature, a prescindere dal loro valore estetico, sono preziose perché testimoniano il tipo d’intervento eseguito dall'artista per portare a compimento l'opera, compresi i ripensamenti. Tra le stampe di tiratura che anticamente non venivano numerate, è evidente che vengano considerate di maggior pregio le prime stampate, in quanto sono le più fresche e ben incise. Più la tiratura procede più le stampe risulteranno stanche e sbiadite, segno del declino della matrice a causa dello schiacciamento subito dalla pressione dei torchi. I collezionisti del passato erano disposti a tutto pur di avere queste primizie, e leggendo le Notes manuscrites si percepisce l’orgoglio con cui Pierre-Jean Mariette annotava che la stampa da lui posseduta era «très rare» perché senza lettere, senza firma dell’incisore, o con uno stemma differente. E ovviamente conoscere gli stati della matrice consente di datare con maggiore precisione un esemplare rispetto ad un altro.
François Spierre. Un incisore lorenese nella Roma barocca,
di Benedetta Ciuffa, 424 pp., ill., Artemide Edizioni, Roma 2022, € 50

«Ciro e Pantea» di François Spierre da un originale di Berrettini Pietro detto Pietro da Cortona (sec. XVII)

Un particolare di «Atena sul carro trainato da leoni» (1660) di François Spierre da un disegno di Ciro Ferri
Altri articoli dell'autore
A che cosa serve la giornata indetta dall’Unesco e dedicata a celebrare i libri? A far venire voglia di leggerli, of course
Anche i poveri hanno bisogno di arte e ora che Bergoglio non c’è più siamo tutti più poveri
Ma se volete vedere la bella stagione (quella vera) o sentir parlare di lei, andate nei musei o cominciate a leggere un libro di mitologia
Nella Mole Vanvitelliana sono presentati i restauri delle opere di chiese e musei danneggiate dai sismi del 2016-17 e del novembre 2022