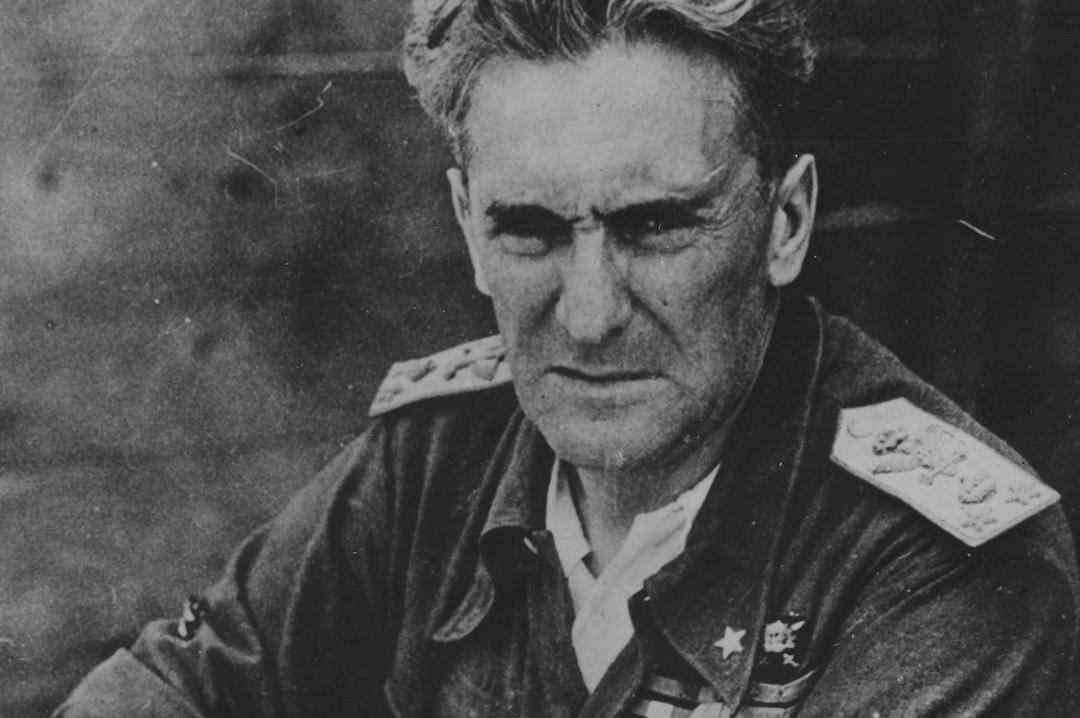Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliOrmai non ci sono che elogi per Massimo Osanna, il soprintendente che sta facendo rinascere Pompei. Durante la sua ultima visita ispettiva, lo scorso 9 febbraio, la commissaria europea per le politiche regionali Corina Cretu ha definito il lavoro svolto e i risultati raggiunti nel sito archeologico di Pompei «un modello per l’Europa». In tre anni, dal 2014, i lavori conclusi comprendono tra l’altro la messa in sicurezza delle Regiones IV, V, VI e IX, la sistemazione dei problemi idrogeologici, 30 domus aperte e restaurate e parzialmente anche la famosa Casa dei Vettii, mentre presto partiranno i lavori nella Casa dei Casti Amanti. Per la sicurezza: in funzione l’impianto di videosorveglianza e wifi in tutti gli scavi; importante anche il grande Piano della Conoscenza con la realizzazione di quello che Osanna definisce «un grande archivio informatico, uno strumento straordinario. Adesso abbiamo i rilievi, la fotogrammetria di ogni muro, di ogni singolo elemento della città per programmare la manutenzione e gli interventi di restauro».
L’impegno di Osanna è cominciato a marzo 2014 quando fu chiamato dal ministro Massimo Bray alla Soprintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia. Allora un documento firmato da 70 soprintendenti aveva definito quella decisione «una mortificazione delle professionalità interne» del Ministero. Osanna veniva infatti da fuori, dall’Università della Basilicata, dove era direttore della Scuola di specializzazione in Archeologia a Matera. Ma già nel 2007 c’era stata per lui una parentesi con il salto dall’insegnamento al Ministero: vinto il concorso, per più di un anno aveva retto la Soprintendenza archeologica della Basilicata prima di tornare all’Università. Osanna tiene molto a dirsi «uomo del Sud». È nato proprio in Basilicata, a Venosa, patria di Gesualdo e di Orazio, ricca di memorie classiche e di resti archeologici e dove ha sede la Osanna Edizioni, casa editrice della sua famiglia, nata negli anni ’80. «La mia passione è nata lì e si è rafforzata all’Università di Perugia dove ho avuto due maestri importanti e molto stimolanti: Mario Torelli e Filippo Coarelli. Devo moltissimo a Torelli, voglio ricordarlo, sempre». La professione di archeologo era poi iniziata ancora in Basilicata dopo la laurea nel 1985: «Abbiamo cominciato a scavare a Policoro proprio con Torelli, fu un periodo molto formativo», ricorda. Dopo, Osanna ha insegnato anche a Heidelberg, a Berlino, ha condotto scavi in Grecia, in Turchia, a Creta. «È in Basilicata anche l’Università dove ho insegnato fino a quando, con la nomina a Pompei, mi sono trasferito a Napoli, alla Federico II, dove il primo marzo comincio un nuovo corso. Ora abito a Napoli, città che adoro, disastrata e maltrattata e forse anche per questo più amata». Oggi, inserito nel meccanismo ministeriale, forte della conferma a Pompei fino al 2019, con i poteri e l’autonomia di direttore generale del sito, spetterà a lui completare il Grande Progetto.
Arrivando a Pompei nel 2014 lei ha abbandonato la politica ministeriale seguita negli anni precedenti per inaugurare una nuova strategia: non più soltanto difesa del sito archeologico contro il degrado.
È stato possibile anche perché, e questo è stato merito del ministro Bray, il Mibact aveva cambiato rotta. Non si trattava soltanto di cambiare la governance del sito e di avere un nuovo soprintendente. Bray ha creato una speciale diarchia che è stata fondamentale per il successo del Grande Progetto Pompei: Soprintendenza da un lato e dall’altro una Direzione generale affidata al generale Giovanni Nistri con compiti ben distinti. Una formula vincente, fondamentale anche per assicurare la legalità di tutte le procedure. Adesso siamo in una fase nuova, i grandi problemi sono stati risolti, si tratta di concludere quello che è stato iniziato e di impostare il futuro di Pompei: finalmente la «manutenzione programmata» e una nuova vita per la città che deve confrontarsi con un numero crescente di visitatori, non previsto in queste dimensioni. Quando arrivai l’obiettivo era di 3 milioni, ma l’anno scorso sono stati già 3,3 milioni e a gennaio 2017 eravamo al 10% in più dello stesso mese del 2016. Quindi bisogna pensare anche a nuove biglietterie, nuove strutture di accoglienza.
Fino a che punto è sopportabile questa crescita?
Dobbiamo prevedere un turismo sostenibile anche per la specificità di Pompei, un sito enorme con seri problemi di sicurezza che abbiamo già affrontato. Tra gli obiettivi c'erano togliere le transenne e rendere accessibile tutta la rete stradale della città. Siamo a tre quarti del lavoro.
Tutto questo pone nuovi problemi di controllo e qui entra in gioco il ruolo negativo di alcuni sindacati minori, Unsa e Flp che, lei ha dichiarato, «tengono sotto ricatto Pompei». A che punto siamo?
L’ultima provocazione rischiava di avvenire proprio durante la visita della commissaria europea Cretu: era annunciata un’assemblea che avrebbe bloccato gli scavi. Alla fine è arrivata la revoca e c’è stata solo una manifestazione all’ingresso, molto ridotta, con alcuni striscioni e un tentativo non riuscito di agganciare il ministro Franceschini.
Quali sono i problemi reali dietro a queste contestazioni?
Intanto quello delle sedi: siamo ancora nelle strutture provvisorie create dopo il terremoto del 1980. Sono già cominciati i lavori di ristrutturazione degli edifici demaniali davanti al Teatro Grande, dove si trasferirà tutta la Soprintendenza.
I sindacati lamentano la carenza di personale di custodia e i pesanti turni di lavoro, soprattutto notturno.
Sono problemi che francamente non capisco. Il lavoro notturno va in gran parte eliminato. Adesso abbiamo un sofisticatissimo sistema di videosorveglianza collegato con la nostra sala regia e i Carabinieri. La presenza di notte, come una volta, di una ventina di guardie non ha più senso. I custodi protestano perché la notte è pagata di più e si recupera anche con giorni di riposo. La videosorveglianza ha liberato energie per i turni di giorno. Più sacrificati dei custodi sono, per esempio, gli architetti, sempre nei cantieri di fronte a scelte spesso complesse e cruciali. Del resto questo è l’organico del personale e per adesso non ne avremo altro.
I custodi sono in tutto circa 115, bastano a svolgere il servizio?
Ne abbiamo altri 50 dalle convenzioni con Ales, la società del Mibact. Le unità di personale da Ales sono in tutto 116, compresi amministrativi, informatici, avvocati, addetti all’accoglienza e poi una ventina di operai, 7 restauratori, 2 assistenti e 2 archeologi che hanno iniziato la «manutenzione programmata». Le strade di Pompei non sono mai state così ben tenute. Alla Soprintendenza abbiamo oggi 430 persone. Con quelle di Ales arriviamo a 546.
Fin dall’inizio le carenze erano concentrate nello staff tecnico. È ancora così?
Mancano architetti e archeologi, diminuiti soprattutto per pensionamenti e trasferimenti: dopo 5 anni di lavoro a Pompei tornano a casa. Segnalo sempre questo problema: se vogliamo continuare a mantenere il ritmo che abbiamo impresso ai lavori questa continua emorragia non è sopportabile.
Quando verrà completato il piano del Grande Progetto Pompei?
Sarà tutto finito entro il 2018. Per il 2019 rimarranno un paio di cantieri come quello del fronte di scavo, un’impresa complicata per la quale ci vorranno almeno due anni. Dopo tanti anni apriremo scavi nuovi, una cosa molto bella anche per la ricerca. Ci aspettiamo sorprese importanti. Verrà liberata un’intera insula, mai scavata, nella Regio IX. Nel riconfigurare il fronte di scavo c’è una specie di penisola ancora intatta. Siamo nel cuore della città, con dimore di rilievo. Il lavoro comincerà nelle prossime settimane, gli appalti sono pronti. Fa parte di un intervento per 14 milioni di euro che deve rimodellare tutta la sagoma dei fronti di scavo per renderli sicuri. Lo scavo avviene su terreni già demaniali ma ne stiamo acquisendo altri lungo il perimetro di Pompei dove sono rimaste piccole proprietà private.
In origine, nel 2014, c’erano solo i 105 milioni messi a disposizione del Grande Progetto Pompei dall’Europa e dallo Stato italiano, ma siamo già ben oltre questa cifra. Quanto si spenderà in tutto?
Oltre ai 105 milioni iniziali abbiamo quelli risparmiati con i ribassi delle gare d’appalto: si arriva a circa 150 milioni. Altri 40 milioni sono arrivati dal Cipe per completare alcuni lavori non compresi nel Grande Progetto, per esempio il fronte di scavo meridionale, una zona molto fragile dove ci fu un crollo nel 2015. È il fronte scosceso un tempo affacciato sul mare dove le domus hanno due piani inferiori rispetto a quello di calpestio della città.
Quanti soldi servono ancora per gli interventi straordinari, oltre il Grande Progetto?
Quelli che abbiamo ora ci bastano. Non tutta Pompei è restaurata, ma è messa in sicurezza. Abbiamo restaurato una ventina di case importanti; ne restano altre, come quella di Giulio Polibio in situazione precaria. L’abbiamo inserita in un nuovo progetto di restauro sponsorizzato con oltre 5 milioni da un gruppo di privati francesi e prevede interventi su 30 domus tra cui quelle del Centenario, di Giulio Polibio e degli Opliti. Domus importanti, già in sicurezza ma che richiedono interventi anche su mosaici e pitture prima di essere riaperte.
La manutenzione programmata pone nuovi problemi. Finiti i fondi straordinari, è sufficiente il personale disponibile oggi?
La chiave è lì. Per evitare che ci voglia tra dieci anni un altro Grande Progetto bisogna rafforzare il gruppo di lavoro. I 20 operai e i 7 restauratori di oggi sono troppo pochi. Comunque penso che quando non ci saranno più i grandi lavori, potremo anche aumentare il gruppo della manutenzione.
Basteranno per il futuro, senza più l’aiuto dell’Europa, i 27 milioni incassati nel 2016?
Con la crescita dei visitatori avremo un incremento notevole dell’incasso e io vorrei anche aumentare il costo del biglietto da 11 a 13 euro. Sicuramente avremo in cassa alcuni milioni in più. La riforma del Ministero ci crea un vantaggio. Non dobbiamo più pensare poi a Ercolano che ha un nuovo direttore e una sua autonomia. I soldi incassati saranno per Pompei e anche per Oplonti, Stabia e Boscoreale che hanno bisogno di cure.
Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis