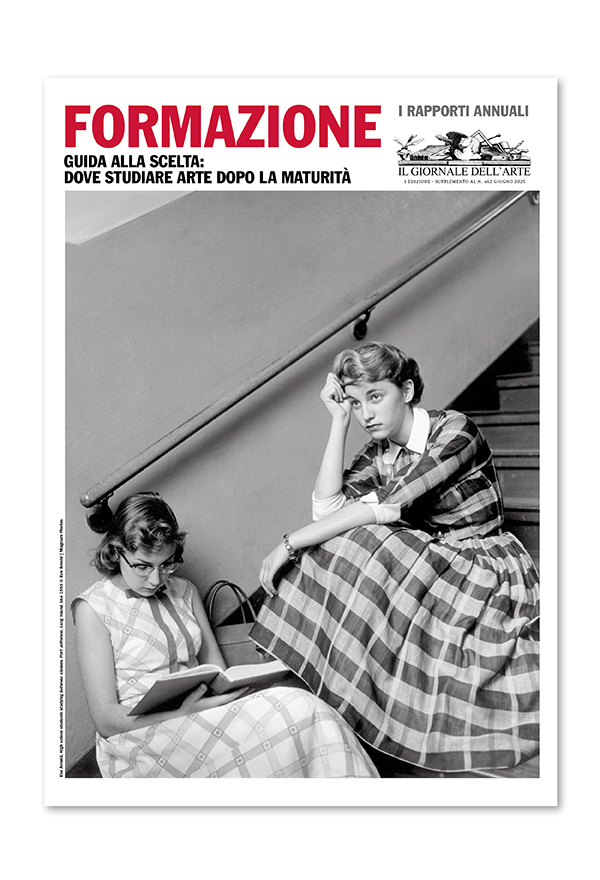Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Il 28 aprile 1925, cent’anni fa, s’inaugurava a Parigi l’Exposition internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, atto non tanto di nascita quanto piuttosto di battesimo di quel gusto che di lì a poco, in tutto il mondo, si sarebbe chiamato appunto Art Déco. E cento anni fa nasceva Rossana Bossaglia (1925-2013), la grande storica dell’arte che avrebbe esplorato da maestra, e riportato alla luce, il Liberty e l’Art Déco, due fenomeni lungamente banditi dalla storia dell’arte: «Sono queste le ragioni», ci spiega Valerio Terraroli, curatore della mostra «Art Déco. Il trionfo della modernità», dal 27 febbraio al 25 giugno a Palazzo Reale a Milano, «per cui, a soli otto anni dalla rassegna sullo stesso tema che ho curato a Forlì, ho pensato fosse opportuno ridiscutere la questione anche alla luce di nuove riflessioni su che cosa sia stata esattamente questa formula, che è l’interfaccia fintamente ottimista di un’Europa che cercava sì un risarcimento psicologico dopo la Grande Guerra ma covava anche in sé le ragioni che portarono alle dittature. Continuiamo a chiamarli “anni folli”, “anni ruggenti”, ma in realtà furono anni attraversati da molte contraddizioni». Eppure, in quegli anni s’impose un gusto fatto di glamour e di oggetti lussuosi destinati alle élite, ma diffuso da cinema e pubblicità anche nel grande pubblico, che non smette di attrarre.
Organizzata con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore, Valerio Terraroli ha limitato i confini temporali della mostra al decennio 1920-1930 e l’area geografica alla Francia, sede della storica esposizione, e all’Italia, che lì ottenne un grandissimo successo. Con rari e mirati contrappunti austriaci e tedeschi. L’abbiamo intervistato.
Professor Terraroli, come si sviluppa la mostra?
Fulcro del percorso è il 1925, quando si tiene anche la seconda Mostra internazionale delle arti decorative di Monza (istituita come biennale nel 1923, divenne triennale dal 1930 e nel 1933 fu spostata a Milano, nel Palazzo dell’Arte, dove ha sede tuttora, Ndr), ma il percorso si apre con gli antefatti, con opere degli anni tra il 1919 e il 1923 di Mario Cavaglieri, Anselmo Bucci, Adolfo Wildt, Galileo Chini, Ivan Meštrović e Libero Andreotti, che già annunciano un’aria nuova. Al 1925, e ai pezzi della grande mostra parigina e della Biennale di Monza di quell’anno, abbiamo destinato un salone, con una parata di lavori esemplari come le meravigliose ceramiche di Gio Ponti per Richard Ginori, gli argenti di Renato Brozzi, orafo amatissimo da Gabriele D’Annunzio, i vetri di Vittorio Zecchin per Cappellin, e le opere degli artefici francesi.
Stiamo parlando di arti decorative, ma in questa sezione ha inserito anche dipinti e sculture?
Pochi, per la ragione che ho appena detto, tra i quali non poteva però mancare il grande «Ritratto di Wally Toscanini» di Alberto Martini, esattamente del 1925. Di qui in poi la mostra cambia il passo e procede per sale monografiche, illustrando i temi allora più diffusi, dal mito della natura selvaggia, esotica e brutale (c’è un grande mosaico di Paul Jouve con una pantera nera e un pitone che lottano) alla questione del colonialismo, che alimenta un’immagine dell’Africa oggi inaccettabile (pensiamo a Joséphine
Baker con il gonnellino di banane); dall’esotismo «domestico» del «Corteo orientale» in maiolica di Francesco Nonni, premiato a Parigi nel 1925 e nel 1927 a Monza, al mito di Diana, che conobbe una fortuna iconografica enorme, fino a una nuova immagine del femminile attraverso la lente dell’antichità, di cui Gio Ponti è il maestro. Una sala Wunderkammer, con numerose opere in pietre dure, argento, oro, è dedicata all’orafo Alfredo Ravasco, poi la stagione del Déco si chiude con le sue ultime gemme, fra le quali il magnifico centrotavola di Gio Ponti per le ambasciate italiane, del 1927. Nell’ultima sala, proprio per marcare i confini cronologici, ci sono invece esempi di ciò che Déco già non è più, come le ceramiche monumentali, alla Arturo Martini, di Angelo Biancini per la manifattura di Laveno, o i vasi rossi di Ponti, Biancini e Andlovitz, del 1931-35: rossi perché l’autarchia impediva d’importare gli altri colori e quello era l’unico a disposizione dei maestri italiani.
Gli anni Trenta non rientrano, dunque, nell’Art Déco. Che fu, però, uno stile o un gusto?
Il Déco fu un gusto più che uno stile perché, al contrario dell’Art Nouveau, non fu mai codificato. Fu un modo di sentire comune, codificato a posteriori, ma che si suole anche definire «Stile 1925». A tumularlo fu la grande crisi del 1929, che colpì ferocemente il mercato americano (dove nel frattempo l’Art Déco era sbarcata in forze, specie attraverso la Francia) ma anche l’Europa. C’erano però già stati in Italia segnali di stanchezza, come lo slittamento della quarta Biennale di Monza dal 1929 al 1930, l’uscita di Margherita Sarfatti dall’orbita di Mussolini e l’imporsi del più magniloquente «stile Novecento».

Galileo Chini, «Allegoria della Primavera», 1919, studio preparatorio per le pitture murali dello scalone d’onore delle Terme Berzieri a Salsomaggiore, collezione privata