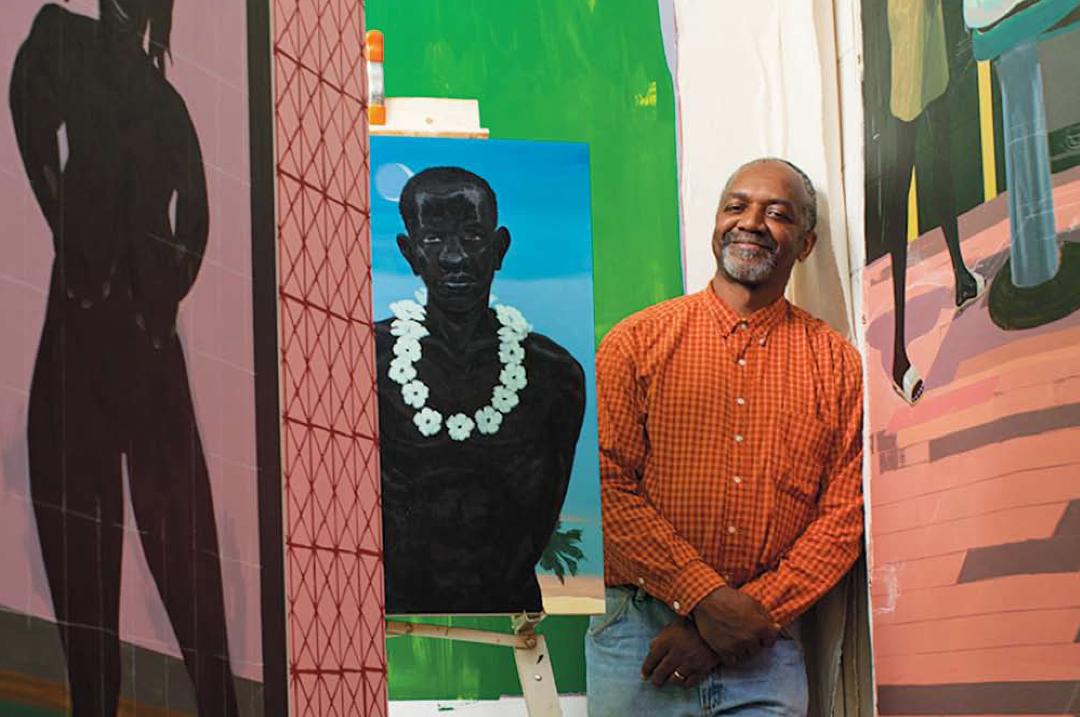Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Franco Fanelli
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
Ripubblichiamo l’intervista rilasciata da Giancarlo Politi a Franco Fanelli nell’aprile 2024.
Si apre un nuovo capitolo nella lunga storia di «Flash Art». Gea Politi, figlia di Giancarlo Politi, che nel 1967 ha fondato una delle prime riviste italiane interamente dedicate all’arte contemporanea, dopo essere succeduta al padre alla direzione nel 2015, passa il testimone a Cristiano Seganfreddo. Continua dunque la conduzione in famiglia (Seganfreddo è il marito di Gea Politi) di una rivista a diffusione internazionale. Ma, come già annunciato, la grande novità è che, come spiega il nuovo direttore, «nel 2024 l’edizione italiana passerà da trimestrale ad annuale. Un numero unico con maggiore foliazione che racconterà le prospettive dell’arte in Italia. Mentre l’edizione internazionale continuerà con le uscite stagionali, “Flash Art” Italia concentrerà gli sforzi sul cartaceo annuale che diverrà un vero e proprio approfondito strumento di lettura. Al numero speciale ne seguiranno altri tematici e geografici. Verrà nel frattempo rafforzato il ruolo digitale con il sito web e i social network, mentre il nostro spazio milanese, Casa Flash Art, ospiterà incontri e lezioni sull’arte. “Flash Art” Italia sarà più sostenibile e accessibile».
In questa intervista, Giancarlo Politi, nato 87 anni fa a Trevi, in provincia di Perugia, ripercorre le vicende della sua rivista e della sua casa editrice.
Qual è stata la sua formazione prima dell’attività professionale?
Io sono un autodidatta nell’arte. Come Achille Bonito Oliva e Germano Celant. Laurea in legge il primo, maestro elementare il secondo, sino a età matura. Dunque solo la passione smisurata ci ha guidati. Anche perché ai nostri tempi non esistevano Facoltà universitarie specializzate in arte contemporanea. Mi sembra che negli anni ’60 la sola facoltà di arte moderna fosse a Roma, sotto la direzione di Giulio Carlo Argan. Ma di contemporaneo non aveva nulla. Credo che i suoi corsi si fermassero all’800. C’era qualcosa con Eugenio Battisti a Genova, ma non proprio arte contemporanea. Io frequentavo prima a Perugia poi a Roma i corsi di economia e come docenti, tra gli altri, ho avuto Amintore Fanfani e Aldo Moro, molto bravi e umani. In una lezione Fanfani ci disse: «Se io fossi stato uno stradino» (oggi operatore ecologico, credo) «sarei il primo stradino d’Italia. Umile ma determinato e autoritario». Non l’amai molto, seppure bravissimo, perché lui cambiò, a progetto ultimato, il percorso dell’Autostrada del Sole che in un primo tempo prevedeva di passare per Perugia, la mia città, mentre Fanfani impose la deviazione per Arezzo, la sua città. Non gliel’ho mai perdonato. Per il resto era una persona eccezionale. Tra i suoi uomini di fiducia c’erano il grande Ettore Bernabei, direttore della Rai come nessun altro, e Sergio Lepri dell’Ansa. Quest’ultimo fu il mio riferimento nel giornalismo d’arte. Più tardi, negli anni ’70, quando il Fanfani pittore (e si prendeva molto sul serio) fece una mostra alla Galleria Editalia a Roma, presentato da Giovanni Carandente, volli intervistarlo, curioso di conoscere la sua opinione sull’arte. Io ero amico di sua figlia Cecilia, allora fidanzata con il gallerista Cleto Polcina che io frequentavo. La mia richiesta fu accolta da Fanfani con entusiasmo ma quando arrivò da me la Digos (o forse Sid allora) per farmi delle domande e pormi delle condizioni prima di andare allo studio del maestro Fanfani, declinai la proposta, perché capii che non avrei dovuto intervistare un pittore ma un potente personaggio politico. Così non conobbi mai le sue opinioni sull’arte. E di questo mi rammarico un po’. Gli avrei posto qualche domanda spinosa.
È noto il suo amore per la poesia. Può approfondire questo aspetto?
Effettivamente l’amore per la poesia ha preceduto quello per l’arte. Non so come nacque perché io ero figlio di un operaio e di una casalinga, persone incredibili ma non acculturate: primi libri che ricordo in casa furono Pinocchio e una biografia di Santa Rita da Cascia. Rammento però che in seconda elementare la nostra maestra ci lesse la poesia di Carducci «Alle Fonti del Clitunno», anzi «Clitumno» (a due passi da quella che allora era casa mia e dove io mi recavo spesso per sguazzarci dentro) e ne rimasi folgorato. Iniziai subito a scrivere poesie molto carducciane. Poi passai a Pascoli e a D’Annunzio e già alle scuole medie leggevo Corazzini (che aveva studiato a Spoleto) e Gozzano. E Sandro Penna (di Perugia) e poi, non so come, scoprii Dino Campana che diventò il mio mito. La passione per la poesia diventò un’ossessione onnivora e ricordo che alle scuole superiori, studente svogliato, io sotto il banco leggevo Ungaretti, Quasimodo, Montale, Saba e addirittura Ezra Pound. Con risultati scolastici ovviamente scadenti. Questa mia passione mi portò a un’ottima conoscenza della poesia italiana di quei decenni, a tal punto che a 18 anni scrissi una cartolina a Mike Bongiorno per essere invitato a «Lascia o Raddoppia», proponendomi per la poesia italiana contemporanea.
E come andò?
Con mia grande sorpresa fui subito chiamato. Alla prova di ammissione con me c’era anche John Cage che, non avendo mezzi per tornare negli Stati Uniti, fu sollecitato dagli amici italiani a partecipare alla trasmissione come esperto (quale era) di funghi per potersi pagare il viaggio. Più tardi Umberto Eco, funzionario Rai in quegli anni e che aveva collaborato a formulare molte domande, mi confessò che Mike Bongiorno, da italoamericano e felice di sfoggiare il suo perfetto inglese in tv, voleva che John Cage vincesse i 5 milioni, allora cifra astronomica per me e dunque credo sia stato agevolato. Io sbagliai una delle ultime domande perché mi chiesero dei versi di Danilo Dolci, che stava alla poesia come Fanfani alla pittura. Ma tant’è, tornai a casa con una cifra per la mia famiglia cospicua (lo stipendio di circa due anni di mio padre) felice e contento. Assaporai anche le gioie e i dolori dello star system. Per alcuni mesi, forse anni, fui assalito da fan che mi chiedevano l’autografo. Figuratevi come poteva sentirsi un impacciato ragazzotto di campagna in quelle circostanze.
C’è una connessione tra la nascita di «Flash Art» e quella dell’Arte povera, una sorta di reciproca consequenzialità? Sul quinto numero della sua rivista Celant pubblicò, nel 1967, il testo «Appunti per una guerriglia», il «manifesto» del Poverismo…
Negli anni 1966-67 io frequentavo molto Torino, in quegli anni forse la città artisticamente più vivace e propositiva d’Italia. La galleria Il Punto, diretta da Remo Pastori, era un guazzabuglio ma anche un riferimento per la contemporaneità, poi subito dopo arrivarono Gian Enzo Sperone e Christian Stein. Più tardi Tucci Russo e Giorgio Persano. E frequentavo un illuminato e stravagante collezionista, Marcello Levi, che ebbe un peso non irrilevante nella nascita dell’Arte povera. Marcello aveva affittato un enorme spazio chiamandolo «Deposito di Arte Presente» (Dap) che fu il vero crogiuolo della sperimentazione artistica torinese e italiana e da cui emersero anche tutti gli artisti dell’Arte povera (ad eccezione, forse, di Penone, arrivato un po’ più tardi perché più giovane). Mi sembra ci fosse anche Gianni Piacentino, bravissimo artista escluso dal gruppo in quanto non in sintonia con Germano Celant, che non apprezzava l’eleganza del suo lavoro. Secondo Celant quella di Piacentino non era Arte povera ma «Arte ricca». Comunque «Flash Art» nacque come specchio della realtà creativa del momento e fu naturale occuparmi di quella situazione che il grande Germano stava cercando di coagulare. E poi selezionò un gruppo che tenne in pugno con la fermezza di un maresciallo di caserma. E questa fu la strategia vincente per lui e per gli artisti che lo seguirono.
Chi furono i suoi primi sostenitori?
In realtà io sono partito da zero e con la modesta liquidazione di tre anni di insegnamento negli Istituti d’arte. Mi sostenni da solo andando nelle gallerie e manifestazioni d’arte a vendere le copie della rivista e qualche rara pubblicità pagata in ritardo o mai. Ma quelli erano i tempi in cui l’arte contemporanea era una nicchia per un’élite molto squattrinata anche se chiassosa, Umberto (Allemandi, Ndr) credo ne sappia qualcosa. E io quando racimolavo il poco denaro per stampare un numero partivo con il successivo, altrimenti aspettavo. Ma i primi veri sostenitori furono degli amici torinesi: Luciano Pistoi e Franco Assetto, il grande gallerista e il pittore farmacista che in cambio di qualche pubblicità mi anticiparono un milione di lire di allora, permettendomi di sopravvivere per quasi un anno. Poi a forza di panini, cene saltate e con la rabbia dell’ultima spiaggia, spostando la redazione dapprima a Brescia, ospite di un amico, poi a Milano, ospite di Achille Mauri (editore e presidente delle Messaggerie Italiane scomparso nel gennaio 2023, Ndr), altro mio grande benefattore, la rivista incominciò ad affermarsi, dapprima presso gli artisti poi anche presso un certo pubblico.
È giusto parlare di «Flash Art» come dell’ultima rivista militante?
Non so. Non mi sono mai sentito un militante. «Flash Art» non ha mai parteggiato per nessuna tendenza ma ha voluto essere un osservatore attento e curioso all’interno del sistema. E sempre in sintonia con gli artisti della mia età e della generazione precedente. In Italia Vedova, Turcato, Dorazio, Schifano, Manzoni. Poi De Dominicis, Cattelan, Vezzoli. Vivevo con loro, avvertivo le loro ansie e condividevo anche la fame e le criticità esistenziali con loro. E così sono andato avanti, sempre sintonizzato sull’attualità e con gli artisti del momento. Sino a quando, con l’età, ho avvertito che questa sintonia si era spezzata e allora ho passato la mano a mia figlia Gea. Che malgrado le grandi difficoltà della carta stampata, con suo marito, Cristiano Seganfreddo, se la sta cavando bene. Soprattutto «Flash Art International», che corre a gonfie vele. Ma questa mia connessione con i tempi (lo Zeitgeist?) l’ho anche pagata. Gli artisti non mi hanno mai perdonato di averli abbandonati per occuparmi della generazione successiva. Per questo conosco tanti artisti ma nessuno è più veramente amico. Kounellis non mi perdonò mai di avere dato spazio e visibilità alla Transavanguardia. E con lui molti altri.

Ritratto di famiglia: Giancarlo Politi, Helena Kontova e Gea Politi fotografati da Maria Mulas a Milano nel 1990. Foto: Maria Mulas
Quante copie stampava all’inizio «Flash Art» e quando ha raggiunto il picco della tiratura?
Sono partito con mille copie, forse ottocento o anche cinquecento (il mondo dell’arte era rumoroso ma limitato: nessun confronto con oggi). Copie che distribuivo e vendevo ad personam nelle gallerie, alla Biennale di Venezia e a Documenta. «Flash Art Italia» ha raggiunto un picco di 20mila copie di tiratura, di cui in abbonamento circa 3mila e in edicola una media di 6mila copie vendute. «Flash Art International» ha superato anche le 30mila copie di tiratura, ma il bacino era molto più ampio: solo negli Stati Uniti la grande catena Barnes & Noble, con oltre mille librerie, me ne acquistava sempre 6-7mila copie. E poi la potente agenzia di distribuzione Eastern News ne distribuiva nei chioschi altre 10mila in tutti gli Stati Uniti e Canada. Un altro grande distributore inglese per l’Europa ne assorbiva parecchie migliaia. E poi l’Asia. Gli abbonati superavano i 5mila. Una grande agenzia di abbonamenti americana, la Ebsco, che riforniva tutti i college e musei americani e canadesi, aveva sottoscritto oltre 1.500 abbonamenti. Una grande risorsa. Quando si entrava nei meccanismi giusti, gli Stati Uniti erano un tritacarne, anche se oltre la metà delle copie andavano al macero. Diciamo che andava a buon fine solo il 40% della tiratura, sia all’estero sia in Italia. Ma era una percentuale di tutto rispetto.
Lei ha incontrato moltissimi artisti: quali sono stati i più significativi per la storia dell’arte recente, e quali le grandi promesse mancate?
Diciamo che, dagli anni Sessanta a oggi, ho più o meno incontrato tutti gli artisti importanti. Viste le frequentazioni ad alto livello, debbo dire che gli artisti italiani dal mio punto di vista hanno avuto la peggio. In Italia ho frequentato a lungo Emilio Villa, un vortice di creatività. E con lui Schifano, Lo Savio, Manzoni. Un artista che mi ha fatto conoscere l’arte programmata e cinetica è stato Getulio Alviani. Con lui ho visitato tutti gli studi degli artisti a lui congeniali in Europa: da Morellet all’olandese Schoonhoven, Cruz Diaz, Soto e molti altri. Ma come restare indifferenti davanti a Beuys, il grande sciamano dell’arte, Walter De Maria, il minimalista asceta, Robert Smithson, Christo che mi ospitava spesso. Con Leo Castelli ho frequentato anche Rauschenberg e Johns. E anche Warhol, ma superficialmente. Direi che Jeff Koons è l’artista a cui sono stato più vicino e che mi ha maggiormente impressionato, per lucidità e visione dell’arte. Lui ancora oggi in molte interviste ricorda che «Flash Art» è stata la prima rivista d’arte a interessarsi a lui e che con la visibilità che gli ha dato ha contribuito alla sua carriera. Mi diceva che le sue opere sono destinate all’immortalità perché sono garantite dalla Nasa per diecimila anni, quindici volte più di Leonardo. E ora ne ha inviata una anche sulla Luna per gli eventuali posteri. Prima, negli anni ’70, ho avuto un rapporto molto amichevole anche con Gerhard Richter, ai tempi di «heute Kunst», la rivista parallela di «Flash Art» in lingua tedesca che allora editavo.
Come vi conosceste?
Ricordo che lui mi chiamò per chiedermi informazioni su un gallerista italiano con sedi a Genova e Milano che gli aveva chiesto una mostra. Io lo rassicurai sulla serietà della galleria, la quale realizzò, con poco successo, la memorabile mostra «L’Annunciazione secondo Tiziano». Forse uno dei momenti più alti di Richter. Qualche mese dopo Richter mi disse che il gallerista era scomparso con tutte le opere. E ricordo, con mio imbarazzo, che l’artista mi disse che non avrebbe mai più esposto in Italia, Paese di ladri. Ma qualche anno dopo, dimentico dell’infortunio, realizzò una bellissima personale da Mario Pieroni a Roma. Così va la vita.
Chissà quante meteore ha incontrato.
Anche i grandi artisti spesso sono come l’araba fenice. Grande attenzione e pressione su di loro, poi il silenzio. Alla fine degli anni ’70 Robert Kushner, protagonista indiscusso della Pattern Painting e della New York dell’arte, da tutti apprezzato e affannosamente cercato, ebbe successo per un paio di anni, poi su di lui calò il silenzio. La Storia dell’arte non ha pietà per nessuno. Ritengo Ben Vautier un grande artista che non ha avuto ancora il giusto riconoscimento. E lui non è meno importante di Yves Klein, a mio avviso. Basterebbe conoscerlo meglio. Ma ce ne sono tanti altri: Siegfried Anzinger, un grande pittore austriaco che dopo una fiammata iniziale è rimasto al palo. E in Italia Gian Marco Montesano, il pittore della storia, relegato in un angolo. L’occhio della Storia dell’arte e del mercato sono spesso distratti e cinici. Lungo il mio percorso ho assistito a centinaia, forse migliaia di successi improvvisi e fugaci e come Giuseppe Ungaretti mi sentirei di dire che è il mio cuore il Paese più straziato.
Dal 1968 a oggi qual è stato il decennio più importante per l’arte italiana e internazionale?
Personalmente ritengo siano stati gli anni Ottanta: un tripudio ovunque. È il decennio dell’affermazione internazionale dell’Arte povera (anche se negli Stati Uniti non è mai stata popolare, anzi, direi un po’ avversata, ma si doveva misurare con la Process Art di Eva Hesse, molto simile e che ebbe notevole fortuna) e dell’esplosione della Transavanguardia: mai visto un successo di quella portata e una calata nel cono d’ombra così repentina, dopo un decennio travolgente, durante il quale gallerie, musei, collezioni private ribollivano di Cucchi, Chia, Clemente, Paladino, De Maria. Gli anni Ottanta sono stati il decennio della speranza, della convinzione che l’espansione del sistema dell’arte e del mercato non si sarebbero mai arrestati. Invece alcuni forti contraccolpi si sono avvertiti e viviamo un presente con qualche incertezza.
Minini, Bonami, Bellini, Gioni e altri ancora. «Flash Art» è stata anche una fucina di talenti, ma a parte Minini tutti gli altri sono diventati curatori. Questo vuol dire che la curatela ha soppiantato la critica?
La critica persiste e oggi ogni critico è curatore. Ma ai grandi livelli sono le gallerie a dirigere il gioco. Nessuno ha la forza contrattuale e di convincimento di Gagosian, Pace, Perrotin, Hauser & Wirth, David Zwirner, White Cube ecc. Queste gallerie sono in grado di determinare il successo di mercato di qualsiasi artista. Come può la critica competere con queste corazzate? Togliamoci ogni illusione, ragazzi. Ma anche nel passato in molti casi fu così: Picasso diceva che non sarebbe stato Picasso senza Vollard. La critica accademica anziché combattere il mercato dovrebbe cercare di capirlo. Provi a citarmi un artista emerso grazie alle Biennali di Venezia o a Documenta. Nessuno. Vuol dire che la maggior parte dei curatori va a caccia di farfalle.
Che cosa accadde esattamente nel 1993, quando pubblicaste il catalogo della sezione «Aperto» della Biennale, scatenando una polemica?
Helena Kontova, mia moglie, era la curatrice di «Aperto 93». Sapendo che la Biennale non avrebbe realizzato un catalogo per questa importante sezione, d’accordo con Achille Bonito Oliva, allora direttore della Biennale, pubblicammo noi un nostro catalogo, con un testo introduttivo dello stesso ABO. Pensavamo che quest’ultimo, in quanto direttore, avesse informato l’istituzione e soprattutto Marsilio, editore del catalogo generale, su una iniziativa da lui caldeggiata. Invece fummo perseguiti per concorrenza sleale. Dopo un paio di anni il Tribunale riconobbe la nostra totale buona fede. Ma il sequestro del catalogo era già avvenuto e le vendite bloccate. Sono gli incerti del mestiere.
La posta dei lettori ha sempre rappresentato uno dei settori più letti della sua rivista. Era tutto autentico ciò che veniva pubblicato o erano lettere in qualche modo sollecitate da lei per attivare una discussione?
Ai tempi di «Lettere al Direttore» la mia rivista era molto popolare. E se nei contenuti redazionali riuscivo a tenere un alto profilo, con le lettere entravo nella pancia dell’arte italiana, tra gli artisti anche bravi e intelligenti ma frustrati, di provincia. E tutti avevano qualcosa da dire. Ricevevo decine di lettere ogni mese, di ogni genere. Purtroppo in quegli anni (oggi non so) gli artisti non volevano ammettere che operare a New York o Londra e, nel loro piccolo, a Milano o Roma o Torino, offriva maggiori opportunità che operare, non so, a Foligno o a Caltanissetta. Molti artisti ancora credono che la Storia dell’arte renderà loro giustizia post mortem. Ma i ripescaggi sono molto rari, quasi come i miracoli e sempre a opera di gallerie blasonate.

Giancarlo Politi con Cecily Brown e Helena Kontova. Foto: Gea Politi
Le opere del Trevi Flash Art Museum sono state acquistate, donate e sono state date in pagamento?
La mia collezione personale, che ormai per necessità si è molto ristretta, è stata frutto di acquisti o di cambi merce con la pubblicità. Ho sempre cercato di evitare omaggi dagli artisti. E le poche volte in cui ho ceduto (Tàpies, Vedova, Richter) è stato quasi un disastro. L’artista si privava sempre delle opere che non riusciva a commercializzare, in poche parole degli scarti. Ricordo invece di avere acquistato da White Cube per 3mila dollari una bellissima opera di Damien Hirst alla sua prima mostra. In un momento di necessità aziendale l’ho messa in asta realizzando oltre 500mila dollari. Rimpiango solo di non aver acquistato un Jeff Koons, un trenino («Luxury and Degradation»), che lui mi avrebbe venduto a prezzo di costo: mi mostrò la fattura della fonderia di 45mila euro. E io, che in quel momento non possedevo tale cifra ma con più coraggio avrei potuto procurarmela, rinunciai. Ho visto poi quell’opera realizzare in asta circa 34 milioni di dollari. Uno dei tanti errori della mia vita, pur essendo stato in genere abbastanza lungimirante. Ho acquisito molte opere offrendo pubblicità a importanti gallerie. In questo modo da Michael Werner di Colonia ho acquisito Baselitz e James Lee Byars, da Marian Goodman due belle opere di Richter (in cambio di pubblicità illimitata), da Persano un Pistoletto, da Toselli due Boetti e così via. Ho posseduto un centinaio di opere di questo livello. La maggior parte le ho dovute alienare per alimentare l’azienda che da un momento all’altro traballò. Ricordo che nel 2008, anno della grande crisi, a maggio, come di consueto, fatturai 150mila dollari di pubblicità sulla sola New York. A settembre dello stesso anno questa cifra era stata ridotta a 8mila dollari. Un disastro. Io avevo un’azienda efficiente ma forse un po’ sovradimensionata di personale. Fra Italia, Londra e New York avevo oltre 30 dipendenti. In questi casi si fa presto ad arrivare alla bancarotta. Insomma era finito il tempo delle vacche grasse. E la collezione mi ha salvato. Ciò che «Flash Art» mi aveva dato nel corso degli anni in poco tempo se lo riprese.
Che cosa ha significato per lei l’incontro con Helena Kontova?
L’incontro con Helena Kontova mi ha dato una bellissima famiglia, ma anche un incontro con la cultura mitteleuropea che mi mancava. Insomma un innesto di energie nuove. E poi c’è stata «Flash Art International» (nata nel 1977, Ndr), che Helena ha diretto con maestria e che ha rappresentato il nostro punto di forza portandoci molto benessere e visibilità.
Tramite «Flash Art», ed escludendo ovviamente sua moglie, c’è stato un incontro che ha cambiato la sua vita?
La mia vita è stata caratterizzata dal lavoro, assiduo e a volte spasmodico. Nemmeno mia moglie ha cambiato la mia vita. Semmai ne ha intensificato l’impegno. Poi ho avuto ogni giorno interessantissimi incontri. Ricordo un pranzo a casa mia con Maurizio Cattelan, il quale ancora agli inizi mi chiese: «Ma che cosa deve fare un artista oggi per affermarsi?». Io gli risposi: «Operare a New York, confrontarsi e cercare di affermarsi attraverso il confronto con i bravissimi artisti che lì lavorano». Maurizio una settimana dopo aveva ideato una borsa di studio per un giovane artista (in realtà per lui stesso) chiedendo 200mila lire ad amici e collezionisti. Raccolse due milioni e andò a vivere a New York, dove inizialmente con vari espedienti e una vita grama (credo che per un periodo vivesse rubando biciclette) riuscì a posizionarsi, aprì una sorta di galleria, The Wrong Gallery, in realtà un pertugio largo e profondo meno di un metro, tra due entrate di altre gallerie. L’idea ebbe una forte visibilità. Ma solo i geni riescono in queste scorribande.
Ha mai avuto la tentazione di fare l’artista?
Ma io ho fatto di tutto. Poeta, da giovane autore di raccolte di poesie (Linea Umbra nel 1964 ebbe un ottimo riscontro tra gli addetti ai lavori), e all’età di 16-17 anni ho avuto anche un’esperienza intensissima e piacevolissima di pittore informale. Anche con qualche credito. Nel 1954, mi pare, ottenni una segnalazione come miglior giovane alla Quadriennale di Roma. Ma fu un fuoco fatuo perché la vita mi impose altre scelte. Fu però un’esperienza molto utile per guardare la pittura dall’interno e non solo in superficie.
In tutti questi anni, c’è stato un episodio per cui si è chiesto: «Ma chi me l’ha fatto fare?»
Ho attraversato tante difficoltà, soprattutto quando risiedevo a Roma dove negli anni ’60 era impossibile lavorare. Ma quando decisi di partire con «Flash Art» tagliai tutti i ponti alle mie spalle e dissi: o questo o niente. Non potevo tornare indietro. Questione di vita o di morte. Questo mi ha dato le energie per la sopravvivenza.
Se il suo nipotino Lev volesse fare l’artista, che cosa gli consiglierebbe?
Lev a due anni sembra multitasking. Strimpella con la chitarra sdraiato a terra come Elvis Presley, canta a suo modo e disegna come Pollock. Sono certo che esploderà nelle sue scelte. Anche perché io, ormai alla fine, non potrò consigliarlo, ma solo godermi ora e per poco i suoi sorrisi e i suoi abbracci.
Online, Intelligenza Artificiale e altro ancora: che cosa attende il mondo dell’arte e dell’editoria d’arte?
Caro Fanelli, io sono un uomo dell’altro millennio. Non mi chieda cose di un mondo che mi inquieta, che non conosco e che non potrei mai gestire. Nella mia vita ho visto di tutto, ma nulla che si possa paragonare ai cambiamenti odierni. Lascio questo compito a mia figlia Gea e a suo marito Cristiano e soprattutto al mio nipotino Lev.
Altri articoli dell'autore
Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne
L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile
Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria
Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca