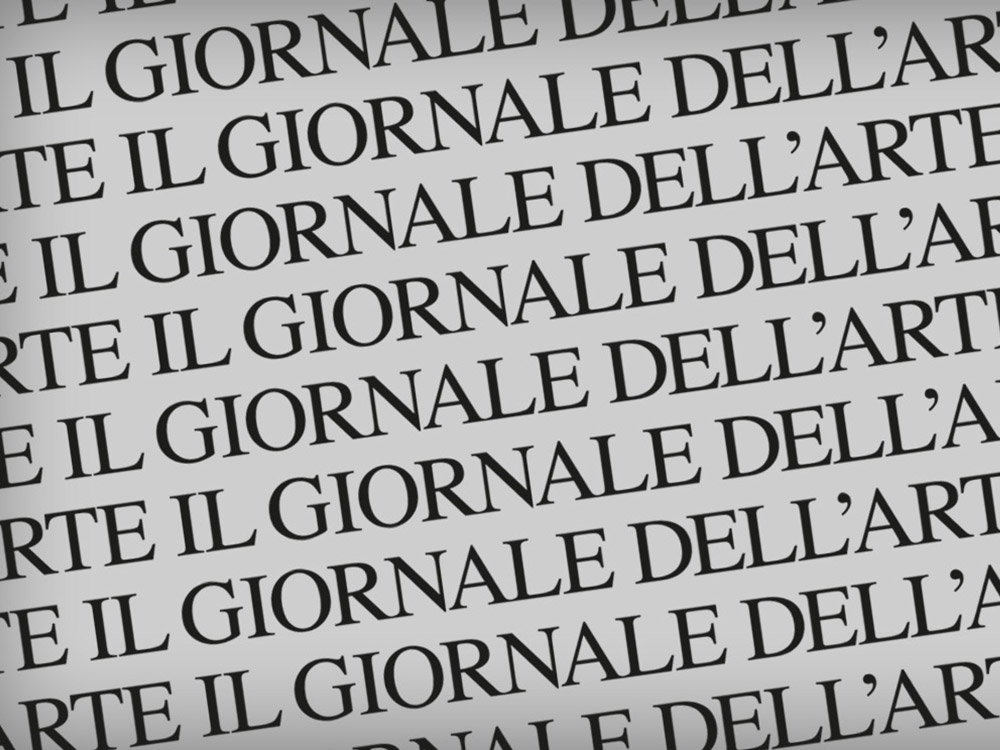Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Andrea Carandini
Leggi i suoi articoliAmbiente, paesaggio, storia e arte: una «cosa» ma due visioni! Da una parte è l’idea che la «cosa» stia al di fuori della vita, fatta quest’ultima sia di alto spirito che di bassa cucina; che essa sia perfetta e pura, come soltanto il sacro, il santo possono essere. Biglietti al Pantheon (come ha appena proposto Franceschini)? Ma è un luogo sacrosanto! Se un giansenista avesse sentito dare del sacro ad altri che a Dio, come a un re o a una chiesa, sarebbe uscito di testa. Nella «cosa» sacrosanta tutto deve ripetersi come un decalogo, un catechismo, un mantra, un rito; quindi scarsa libertà di pensiero. Inoltre per non contaminare questa «cosa» bisogna tenere alla larga i profani e l’esercizio della liturgia ha da essere riservato a sacerdoti, soli a detenere lingua divina, credenze e verità. Insomma, la «cosa» non può essere sfiorata dalle storture della vita, dai problemi pratici di manutenzione e sostenibilità, dalle esigenze legate alla vita quotidiana (il Rinascimento è commercio, banche e arte). In particolare la «cosa» non può essere riformata secondo i principi della visione eterodossa: deve restare come era più di cento anni fa. Un tempo, prima del dominio della tutela «legale», l’intero patrimonio di un popolo era salvaguardato dal popolo medesimo, che spontaneamente lo curava, dal contadino al signore, grazie a una tutela «sociale». Poi questo incanto si è rotto, si è creata una separazione fra popolo e cultura. La cultura è diventata un oggetto protetto dallo Stato, così che di spontaneo e di partecipativo nulla più aveva ragione di essere. Lo Stato, buono, si era sostituito alla società, cattiva, e così non vi era più ragione di coinvolgere e promuovere; solo si dovevano pagare le tasse e con esse conservare la «cosa».
Ma nel frattempo l’idea di paesaggio e patrimonio si è allargato a tutte le testimonianze di civiltà, per cui l’ambiente e l’agricoltura, la cultura materiale e il del costruito storico hanno cominciato a contare quanto il «Tondo Doni». Questo spostamento dell’interesse dalla singola opera d’arte al contesto storico e artistico ha ingigantito l’opera della tutela e dismisura, al punto che nessuno Stato (anche se arrivasse a spendere in cultura quanto la media in Europa) sarebbe più in grado di tutelare e promuovere questa immane e bellissima ricchezza italiana. Infatti tutto il Paese è a rischio idrogeologico, più di due terzi a rischio sismico, gran parte del patrimonio è abbandonata a se stessa e il consumo di suolo ha divorato tutto il divorabile. Serve evidentemente, oltre a istituzioni rinnovate, il sussidio della società civile, la quale però (non più interpellata) si è distratta nelle stupidaggini del consumismo, per cui serve ora uno grande sforzo di promozione culturale per ricoinvolgere la società, non per diminuire o sostituire lo Stato nella cultura, ma per aiutarlo in una leale cooperazione, dove ciascuno fa la sua parte (questo è il contesto in cui Franceschini si è trovato a operare).
Abbiamo avuto una tutela seria dei beni più tradizionali, ma per esempio il Foro e il Palatino non hanno avuto didascalie fino al 2013, l’anfiteatro campano è inedito, Capua non si capisce che cosa sia (ottimo il ristorante biodinamico), Cuma è più che abbandonata: un Campo Elisio accanto all’Averno. La valorizzazione è stata del tutto tralasciata fino a ieri, nonostante che il primo comma dell’articolo 9 della Costituzione riguardi non la tutela ma la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca. I funzionari, fino a pochi mesi fa divisi in tre specializzazioni (archeologica, storico-artistica e architettonica), hanno sempre preteso di lavorare in Soprintendenze separate, mentre il territorio così come il patrimonio è uno. È come se oboi, percussioni e viole volessero suonare in tre orchestre diverse. Infine vi è un catalogo che non cataloga e che mai perviene a catasti, un restauro che oscura con i suoi fasti la manutenzione e un Istituto centrale di archeologia, da tempo auspicato dagli archeologi sul campo, che però è ancora in fasce (ma rompe l’equivalenza con la storia dell’arte).
È evidente che creare appositi uffici per la valorizzazione, visto che di essa gli uffici di tutela non si sono occupati, e unificare le Soprintendenze in modo che archeologi, storici dell’arte e architetti lavorino in comune (come ha voluto Franceschini) non poteva che essere fortemente avversata dal partito della purezza e favorita dal partito che fa della cultura una parte elevata ma pur sempre umana della vita. Il progresso di questi tempi sta nel fatto che mentre un tempo esistevano soltanto i soloni sacrosanti, esistono ora anche persone comuni che hanno saputo ragionare in maniera rigorosa ma empirica, tra le quali annovero a me stesso (dirò il mio più recente pensiero sulla «cosa» in un libro Laterza che uscirà questo mese intitolato La forza del contesto; vari spunti della recente riforma si trovano in miei libri a partire dal 1975).
Il corpo umano è un tutto organico, ma il cuore svolge una funzione e il fegato un’altra, eppure tra loro cooperano (Menenio Agrippa). Così uffici orientati alla valorizzazione, voluti dalla recente riforma, non decontestualizzano alcunché, rispetto a quelli dedicati alla tutela; anche perché la sensibilità contestuale è stata fino a ora quasi nulla. Esempio: per quante pitture si fa riferimento al loro contesto nei musei? La rapina delle opere d’arte fatta, a buon fine, sì che è stata decontestualizzante. Se poi Colosseo, Foro, Palatino e Domus Aurea (insigni esempi di promozione assente) diventano un parco, non vengono spostati dai loro luoghi, per cui il curatore dell’Atlante di Roma Antica, che ai contesti ha dedicato la vita, non soffre. Esiste anche un uso ideologico del contesto, di cui non ci si occupa solo come pretesto per fermare le riforme, che vanno intese come sperimentazioni da tentare e poi semmai correggere in quanto mai perfette.
Invece di perdersi in discussioni poco utili e poco amene sulle istituzioni da lasciare immobili quando vanno aggiornate (fino a scendere in piazza nel momento più incongruo), sui fondi che mancano mentre sono cresciuti di un terzo e sul personale scientifico mancante mentre se ne sta assumendo 500 unità pari a un quinto del necessario (una svolta quindi c’è stata con Franceschini, seppure insufficiente), tutti avrebbero dovuto concordemente puntare l’indice sulla mancanza generale di ogni manutenzione programmata nel Paese: contro i rischi idrogeologici, sismici e dovuti all’usura atmosferica. È sotto gli occhi di tutti che, benché varati dal Consiglio Superiore da me presieduto, le linee guida sulla riduzione del rischio sismico non sono state applicate così come manca ancora una reale manutenzione programmata di Pompei (queste sono le uniche critiche che mi sento di fare a Franceschini, che è stato peraltro il miglior ministro che abbiamo avuto). Ritardo drammatico e gravissimo, che ci vorrà mezza generazione a colmare. Ma se continueremo a sostenere che un muro medievale dipende da una Soprintendenza, quello antico su cui esso si fonda da un’altra e l’affresco che lo ricopre da un’altra ancora non andremo lontano, resteremo nel pantano. Per questo il Fai ha dedicato il Convegno nazionale di Torino dello scorso febbraio al rischio sismico: il problema più urgente, come l’esperienza tragicamente dimostra.