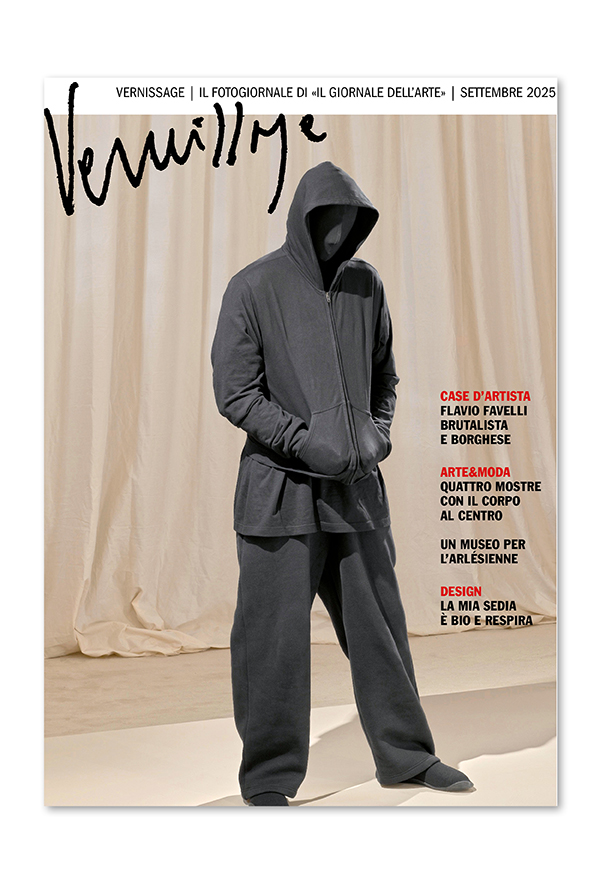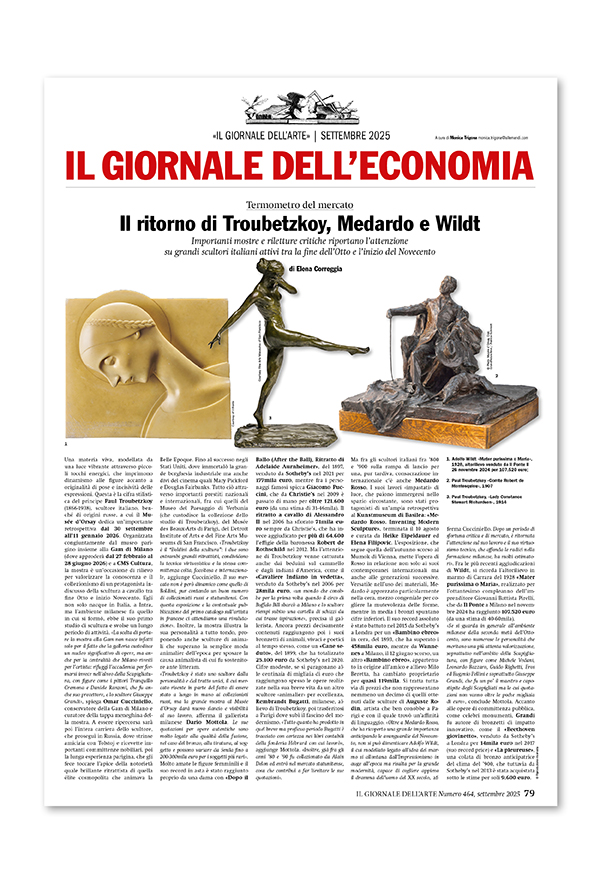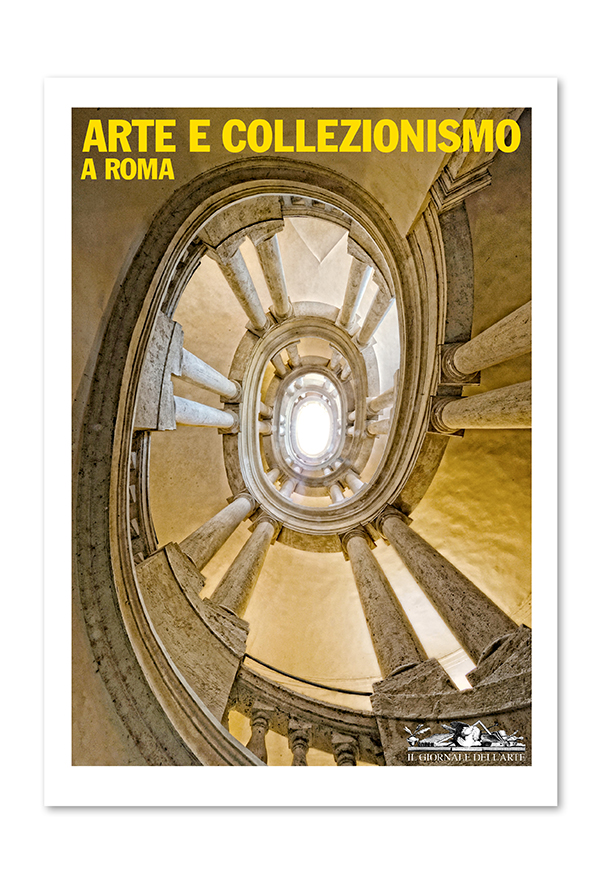Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Gaspare Melchiorri
Leggi i suoi articoliA Pompei, nell’ambito del progetto di scavo e messa in sicurezza dell’area lungo il fronte nord-occidentale della Villa dei Misteri, è stata scoperta una «panca d’attesa» in cocciopesto per i «clientes», le persone di estrazione umile che nell’antica Roma chiedevano protezione al «patronus», in genere una figura dell’aristocrazia. Si trattava perlopiù di braccianti, indigenti in cerca dei favori del padrone di casa.
Sulla panca, poi, sono stati scoperti i «graffiti dell’attesa»: in genere, accenni di disegni, date prive di anno, o nomi incompiuti. Nell’attesa di essere ricevuti, i «clientes» si radunavano intorno alla panchina posizionata di fronte al portone d’ingresso della Villa e ingannavano il tempo incidendo graffiti con carbone o strumenti appuntiti. Il direttore del Parco archeologico Zuchtriegel afferma che «troviamo le stesse panchine anche davanti ad alcune domus di Pompei. Come in uno studio medico con la sala d’attesa piena, anche le panchine affollate davanti alle domus pompeiane erano un motivo di vanto: più clienti aspettavano davanti al portone, più importante doveva essere il padrone di casa».
La scoperta delle iscrizioni permette di documentare la vita quotidiana degli strati inferiori della società. Questi graffiti rappresentano una fonte preziosa per lo studio dei rapporti sociali all’interno del mondo romano, in cui i notabili erano legati da relazioni clientelari a una rete di personalità di rango inferiore che giungevano al mattino per chiedere prestiti, sostegno politico o assistenza giudiziaria.
«Durante le lunghe ore di attesa spesso non sapevi se il padrone ti avrebbe ricevuto quel giorno, spiega Zuchtriegel. Forse la sera prima aveva fatto le ore piccole e preferiva dormire, oppure aveva altro da fare. Allora qualcuno che aspettava qui scriveva sul muro per passare il tempo: si riesce a leggere una data, però senza anno, e un possibile nome. È, per così dire, l'altra faccia dei meravigliosi ambienti affrescati con vista sul Golfo: chissà se le persone in attesa davanti al portone avrebbero mai visto una cosa del genere in vita loro. Vedere oggi la villa visitata quotidianamente da migliaia di persone da tutto il mondo è bellissimo: ciò che una volta era un privilegio sociale, oggi è alla portata di tutti, per lo più ogni prima domenica del mese a titolo totalmente gratuito».
I recenti scavi hanno inoltre fatto emergere l’ingresso originario della villa. Il grande portone d’accesso alla residenza era sormontato da un arco, affiancato da paracarri in muratura e da un tratto della via Superior.
La ripresa degli scavi è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, «in attuazione dei protocolli stipulati tra le due Istituzioni, sia in materia di contrasto al traffico illegale di reperti archeologici, sia in materia di finanziamento delle demolizioni delle opere abusive realizzate nell’area soggetta a vincoli archeologici di competenza del Parco Archeologico di Pompei».
Ulteriori ricerche permetteranno di completare l’indagine degli ambienti ancora in parte sepolti della villa, in particolare del quartiere servile, aprendo nuove prospettive di studio e valorizzazione di uno dei complessi residenziali più celebri e affascinanti dell'antico Impero romano.
Altri articoli dell'autore
I lavori, a cui partecipa un’équipe italo-statunitense, si concentrano su un ampio settore del quartiere sud-occidentale della città. Saranno aperti ai visitatori
Il sito, nel dipartimento del Basso Reno, è quello dell’antica città di Hellelum o Helvetum, sulla strada che portava al «vicus» di Lahr, nel Baden-Württemberg. Scoperte anche tracce di un insediamento dell’Età del Bronzo
È stato presentato il progetto di valorizzazione del complesso mediceo. Siglata la convenzione triennale tra Educandato dell’Annunziata e Città metropolitana del capoluogo toscano
Scampati alla distruzione ottocentesca della Chiesa dei Cappuccini di Chieri, intitolata a San Maurizio, e restaurati dal Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale», saranno visibili al primo piano della Galleria Sabauda