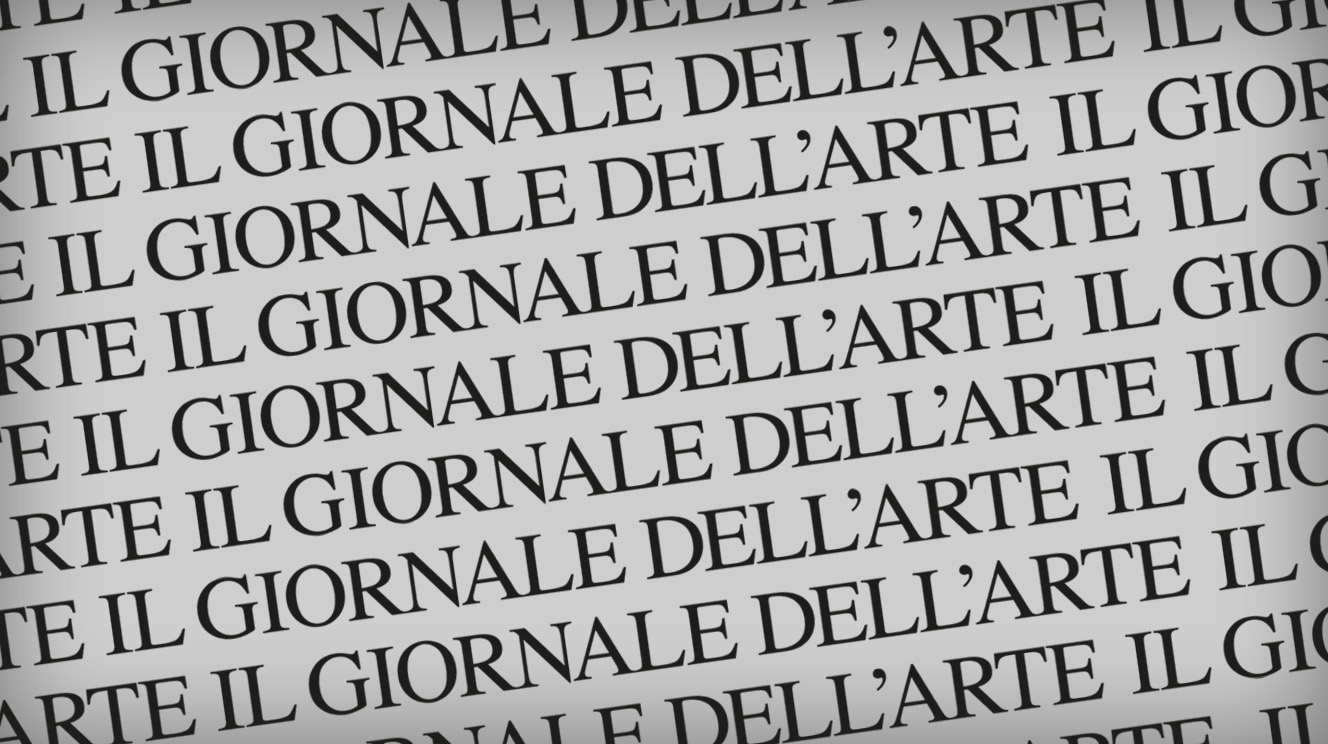Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanni Pellinghelli del Monticello
Leggi i suoi articoliDal 24 settembre al 21 gennaio al British Museum la prima mostra inglese (memorabile quella di Palazzo Grassi a Venezia nel 1991) dedicata all’arte e cultura celtica, «I Celti. Arte e identità», realizzata con i National Museums of Scotland, presenta 2.500 anni di storia, arte e identità etnoculturale: dall’uso degli antichi Greci del nome «Celti» per identificare le popolazioni barbariche nordiche fino alle rivendicazioni delle moderne nazionalità celtiche e alle frange, più o meno alterate e degradate, della cultura di matrice celtica del Novecento
I popoli indicati come «Celti» vivevano nell’Europa nord-occidentale come etnie collegate dalla condivisione religiosa e culturale. Reperti archeologici di manufatti per banchetti, cerimonie religiose, ornamenti, armi dimostrano la duplice funzione decorativa e di trasmissione di valori e credenze.
Lo stile è astratto, con sinuose forme organiche e animali fantastici negli stilemi utilizzati in tutta l’Europa settentrionale, dall’Atlantico al Mar Nero, e non legato alla quotidianità o al mito come nel mondo classico. La tecnica è invece pari ai migliori esemplari greci e latini, come dimostra lo scudo di Battersea, risalente all’età del Ferro (c. 350-50 a.C.), ritrovato nel Tamigi a Londra.
Intorno al 100 a.C. iniziò l’invasione romana conclusasi nel 43 d.C. con la conquista della Britannia da parte dell’imperatore Claudio. L’occupazione romana è spesso considerata scontro di culture, con i Celti guidati dalla regina degli Iceni Boadicea (33-61 d.C.) da un lato e i Romani dall’altra.
In Britannia il dominio romano fuse romanità e usi celtici creando una specifica cultura romano-britannica, di cui è esempio la piccola statua in bronzo di Nerone da Ipswich (I secolo d.C.). Tutt’altro accadde in Irlanda e in Scozia settentrionale, aree che, per quanto influenzate dal contatto col mondo romano, non furono mai sottoposte a Roma.
Intorno al 410 Roma abbandona la Britannia e cede il posto ai regni anglosassoni in Inghilterra, mentre Scozia, Irlanda e Galles continuano a sviluppare la propria identità culturale, linguistica e religiosa, unendo al Cristianesimo la pratica degli antichi riti druidici, da cui la nota «croce celtica». Anche in questi Paesi i monasteri funsero da centri di alfabetizzazione e trasmissione culturale assimilando le varie tradizioni locali, celtiche e anglosassoni, a quella latina, come testimonia la lastra di arenaria grigia con incisioni cruciformi da Monifieth, Scozia (800-900 d.C., National Museums Scotland).
Dal 793 l’invasione dei Vichinghi in Anglia e Irlanda portò ulteriori influenze culturali a cui si aggiunsero quelle normanne dal 1066 così da sommergere la cultura celtica. Fu solo nel Rinascimento che il termine «Celti», mai più utilizzato dall’epoca romana, venne riscoperto grazie ai testi greci e romani, assumendo la sua attuale connotazione etnoculturale nel Settecento con il fiorire della cultura romantica e del neogotico, quando iniziò a essere usato per descrivere lingue, culture e tradizioni autoctone di Bretagna, Cornovaglia, Irlanda, Isola di Man, Scozia e Galles.
In epoca vittoriana poi, a fine Ottocento, sull’onda dei preraffaelliti e del neomedievalismo, fiorì il Celtic Revival che nelle sue manifestazioni artistiche si relazionò al Modern Style, il Liberty inglese. Da questo percorso secolare nasce il patrimonio culturale dell’identità celtica che (non leso dalla recente verifica che i «Celti» non costituisco un gruppo genetico unico e a sé stante) permane nella cultura contemporanea, dalle feste tradizionali a sport, musica, spiritualità e tradizioni popolari.
Altri articoli dell'autore
Con tavole rinascimentali, pergamene e rotoli miniati, manufatti storici e installazioni interattive il Meis illustra la figura biblica della regina moglie di Assuero e la festa di Purim fra storia, tradizione, arte e attualità
Alle Scuderie del Quirinale un’ampia mostra esplora per la prima volta le relazioni tra Roma caput Mundi del Seicento e gli universi culturali di Africa, Americhe e Asia
I due disegni preparatori dei fratelli bolognesi, entrati nella collezione della National Gallery di Londra dal 1837, sono straordinariamente esposti al pubblico nonostante lo stato di conservazione delicato
Nel Museo di Santa Caterina a Treviso le diverse interpretazioni date all’immaginario emotivo e fideistico di Cristo e Maria Maddalena dal Duecento al Novecento