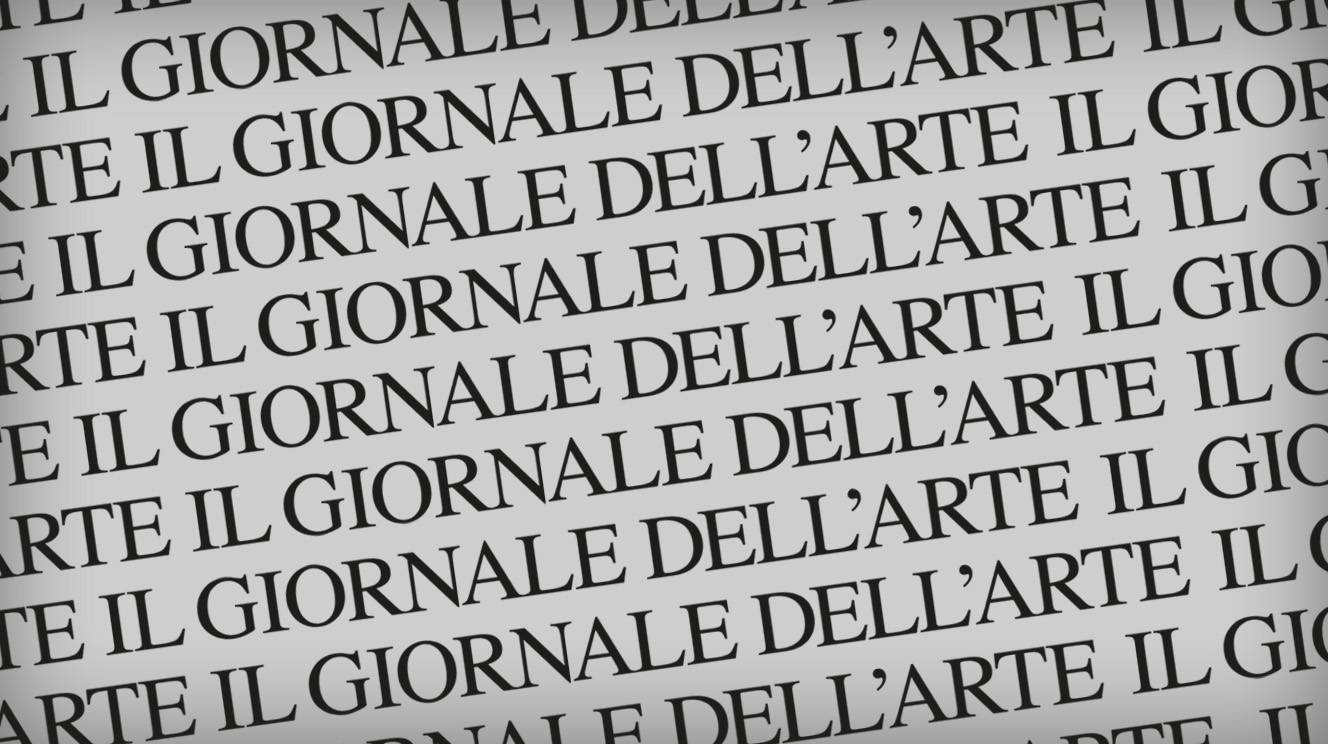Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanni Pellinghelli del Monticello
Leggi i suoi articoliL’Orlando furioso di Ludovico Ariosto fu il vero bestseller del Cinquecento, apoteosi di un genere letterario il cui successo, dalla metà del Quattrocento, si chiuderà con un epigono altrettanto acclamato (ma ben meno affascinante), quella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, che come l’Orlando furioso diede ampia ispirazione alle arti figurative.
Certamente la pazzia d’amore d’Orlando fu argomento adeguato, coerente, armonico alla cultura e agli umori, e pure agli amori, delle corti del Cinquecento e in altri centri di cultura signorile dell’Italia transpadana dove fiorirono edizioni illustrate, dipinti, sculture, maioliche e oggetti d’arte. Anche l’affrescare le nobili pareti di residenze di villeggiatura o di città fu pratica diffusa come dimostra questo studio di Federica Caneparo (Normale di Pisa, oggi a Princeton a studiare i temi letterari nell’arte del Rinascimento).
«Di molte figure adornato». L’Orlando furioso nei cicli pittorici tra Cinque e Seicento muove la sua trattazione elegante e densa di brani ariosteschi dalle sofisticate corti degli Este a Ferrara, Modena e Reggio (città natale dell’Ariosto) a quelle di Mantova e Parma alle residenze della nobiltà di campagna, analizzando affreschi noti e meno noti, da Lazio a Lombardia e Veneto.
Perlopiù ispirati alle xilografie delle edizioni di maggior successo, quelle di Zoppino (1540), Giolito (1542), Valvassori (1553) e Valgrisi (1556), tutti illustratori-incisori e tipografi veneziani, i vari cicli pittorici hanno qualità artistica discontinua per committenze variegate, dall’aulico e principesco al patrizio più rustico.
Nella prima metà del Cinquecento, le avventure di Orlando, Bradamante, Angelica, Ruggiero, Astolfo segnano gli illustri cicli perduti di Dosso e Battista Dossi a Ferrara e di Nicolò dell’Abate e Jean Boulanger alla Delizia Ducale di Sassuolo in Emilia e quello in Veneto di Jacopo Bassano nella villa dei patrizi veneziani Dolfin a Rosà di Bassano, poi le «Storie di Ruggiero» di Nicolò dell’Abate staccate da Palazzo Torfanini a Bologna (ora alla Pinacoteca Nazionale) e la solitaria Torre di Baggiovara di Modena dei Rangoni, diffondendosi a Nord in Valtellina, a Palazzo Ciceri a Como, a Bergamo, nel Bellunese e a Feltre fino a virare a Sud verso il Palazzo Colonna di Sciarra Barberini a Palestrina.
Nella seconda metà del secolo impera l’edizione giolitina fra ville lombarde e veronesi, la Grotta di Alcina a Palazzo Tè a Mantova a celebrare l’amante ducale Isabella Buschetti, il Palazzo del Giardino di Parma, le sontuose ville genovesi Centurione Doria, Spinola, Pallavicno delle Peschiere e da lì fino in Spagna al Palazzo di Don Álvaro de Bazán nella Mancha di Don Chisciotte.
Col finire del secolo e il passaggio al Seicento, la moda ariostesca si appanna, si affermano Tasso e la sua Gerusalemme, e Guarini e il Pastor Fido ma fioriscono ancora il fregio a Villa Giovannina a Cento nel 1617-19, per mano di quello stesso Guercino che tanto onorerà Tasso nelle sue opere, e il ciclo perduto nell’altrettato bentivolesco castello di Gualtieri, a Roma l’opera di Giovanni Lanfranco al Casino Consorti e la Villa Medici Corsini di Mezzomonte all’Impruneta di Firenze, per finire coi fastosi anonimi affreschi degli anni 1670 a Villa Besozzi Casati a Cologno Monzese.
«Di molte figure adornato». L’Orlando furioso nei cicli pittorici tra Cinque e Seicento, di Federica Caneparo, 480 pp., ill. colore, Officina Libraria, Milano 2015, € 39,00
Altri articoli dell'autore
Con tavole rinascimentali, pergamene e rotoli miniati, manufatti storici e installazioni interattive il Meis illustra la figura biblica della regina moglie di Assuero e la festa di Purim fra storia, tradizione, arte e attualità
Alle Scuderie del Quirinale un’ampia mostra esplora per la prima volta le relazioni tra Roma caput Mundi del Seicento e gli universi culturali di Africa, Americhe e Asia
I due disegni preparatori dei fratelli bolognesi, entrati nella collezione della National Gallery di Londra dal 1837, sono straordinariamente esposti al pubblico nonostante lo stato di conservazione delicato
Nel Museo di Santa Caterina a Treviso le diverse interpretazioni date all’immaginario emotivo e fideistico di Cristo e Maria Maddalena dal Duecento al Novecento