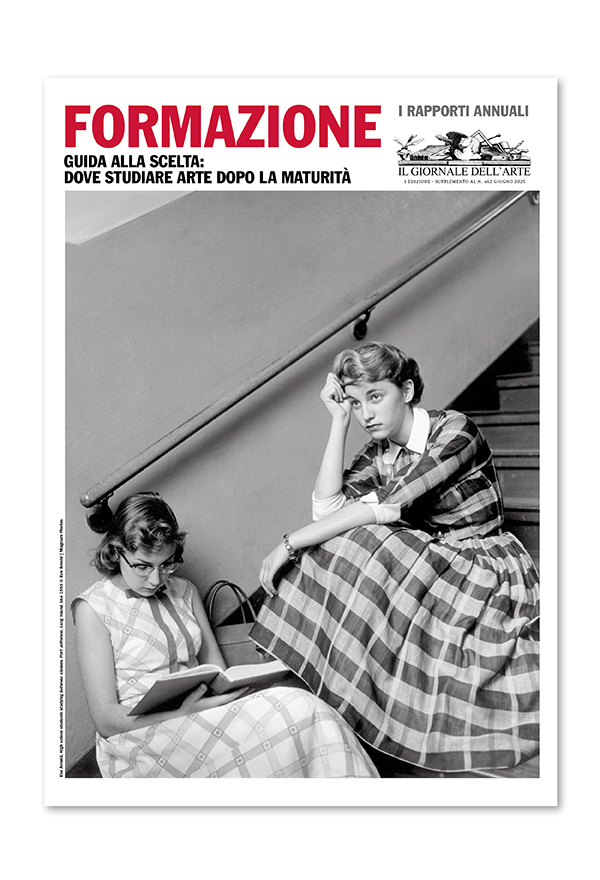Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Redazione
Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI
È mancata ieri, 31 marzo, all’età di 104 anni (era del 1921), Licia Vlad Borrelli, indiscussa protagonista dell’archeologia italiana e mondiale. Con lei se ne va un pezzo di storia importante dell’archeologia e della storia del restauro del secolo scorso. Di origine ferrarese, si era formata a Firenze laureandosi in Lettere antiche e una tesi in Archeologia classica con Ranuccio Bianchi Bandinelli. Successivamente aveva conseguito il perfezionamento studiando prima a Roma e poi presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene (1946-50). Sposata con il famoso pianista e compositore Roman Vlad, nel lunghissimo corso della sua carriera ha rivestito ruoli di rilievo dando un prezioso contributo alla Teoria del restauro di Cesare Brandi.
Tra i tanti incarichi si segnalano quelli di ispettore e poi direttore del settore archeologico presso l’Istituto Centrale del Restauro di Roma (1950-74) e di ispettore centrale per l’archeologia presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (1974-91). All’insegnamento presso numerosi istituti come la Scuola dell’Istituto Centrale del Restauro, l’Iccrom, la Scuola di perfezionamento in Storia dell’Arte dell’Università di Roma, la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Palermo e dell’Università di Viterbo e la Scuola di perfezionamento in Archeologia dell’Università di Firenze, aveva affiancato un’intensa attività di scavo in Italia e all’estero e di consulenza nell’ambito della conservazione e del restauro. È stata membro dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica, dell’Istituto Internazionale di Studi Etruschi, dell’Istituto Archeologico Germanico, del Consiglio scientifico del Centro Internazionale per i Beni Culturali di Ravello nonché vicepresidente della Commissione Italiana Unesco. Insignita della Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, l’archeologa è stata autrice di numerosi libri e pubblicazioni e membro del comitato di redazione di svariate riviste scientifiche.
Ripubblichiamo una sintesi della Lectio magistralis tenuta dall’autrice all’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma il 24 gennaio 2017.
L’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro è una grande famiglia e possiede lessico, regole e norme specifiche che rappresentano un segno indelebile di appartenenza e riconoscimento in qualsiasi tempo e luogo. Come ogni famiglia ha una sua storia e degli antenati, io sono l’unica superstite della stagione delle origini. L’Istituto nasce nel 1939 dopo che, in un memorabile Convegno dei soprintendenti dell’anno prima, Giulio Carlo Argan ne aveva presentato il progetto esecutivo al ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai: allora le Belle Arti erano una direzione generale del Ministero dell’Educazione. Il progetto sarà variamente modificato, ma serberà le premesse fondamentali, che erano quelle di fornire al Paese un’istituzione centrale che fosse nello stesso tempo laboratorio di restauro, dotato di gabinetti scientifici e tecnici, e scuola di addestramento per una nuova classe di restauratori, i quali, oltre a un tirocinio pratico, seguissero corsi di storia dell’arte, disegno e materie scientifiche. La denominazione Belle Arti, che oggi pare obsoleta, ha subìto nel tempo variazioni rispondenti a un diverso modo di concepire la tutela e la promozione dei beni culturali. Ad esempio il termine generico cosa, impiegato per indicare le opere d’arte nelle più antiche leggi di tutela fino alla legge Bottai del 1939, è stato sostituito in quelle successive da bene culturale, patrimonio, introducendo un significato riferito al valore economico, venale, del prodotto artistico, e permettendone al contempo un allargamento a quei prodotti dell’attività artistica immateriali, come il folclore, la musica popolare, le tradizioni orali ecc., che costituiscono i più arcaici e genuini fattori identitari di un popolo, ma sono fragili in quanto affidati solo alla memoria orale e dei quali, in quegli anni di rapide trasformazioni sociali, si cominciava a temere la perdita.
Immutato è rimasto il nome dei soprintendenti, i funzionari che reggono le Soprintendenze, organi periferici istituiti con l’unità d’Italia con il compito di tutela, conservazione, ricerca e promozione del patrimonio della regione di loro competenza. Nomi immutati anche se uffici e funzionari sono sempre più depauperati delle proprie funzioni e del proprio potere, prima a causa del decentramento regionale e ora per la scissione dal territorio di musei e altri luoghi privilegiati, la cui tutela e valorizzazione sono attribuite a soggetti diversi, interrompendo quel complesso unitario che aveva fatto del sistema italiano di tutela un unicum e che rifletteva la singolare situazione del nostro Paese, giustamente definito un museo diffuso.
Oggi è difficile rendersi conto dell’eccezionalità del modello proposto da Argan. Non che non fossero esistiti in precedenza dei progetti che suggerivano l’istituzione di scuole per restauratori. Intorno al secondo decennio dell’Ottocento Pietro Edwards, conservatore per le pitture a Venezia per oltre un cinquantennio, durante il quale si erano succeduti tre governi (la Repubblica veneta, la Francia di Napoleone e l’Austria), aveva redatto il progetto per l’istituzione di una pubblica Scuola del Restauro delle Danneggiate Pitture interna all’Accademia di Belle Arti; a Napoli, nel 1838, nel fervore delle scoperte nelle città vesuviane, due professori di chimica dell’Accademia delle Scienze, Francesco Lancellotti e Nicola Covelli, avevano proposto il progetto di un piano di chimica applicato alle arti; Giovan Battista Cavalcaselle, forse il più grande storico dell’arte dell’Ottocento (ma anche patriota, esule e cosmopolita) nel 1863, agli albori dell’unità d’Italia, aveva presentato al ministro della Pubblica Istruzione una memoria che includeva il progetto per una scuola per restauratori per controllare e unificare le attività di un mestiere esercitato con sistemi eterogenei e tecniche spesso empiriche e gelosamente segrete. Ma queste precoci proposte non ebbero seguito: i tempi non erano maturi. Anche la presenza di laboratori scientifici non era una novità. Il primo, istituito presso il museo archeologico di Copenaghen, risale al 1816. Vi fu, poi, il ben più attivo laboratorio chimico fondato presso i musei di Berlino nel 1888 da Friedrich Rahtgen, specializzato nella pulitura dei bronzi con il metodo elettrolitico, nato in concomitanza con i grandi scavi tedeschi in Oriente e in Egitto. Seguiranno molti altri, presso i musei locali, a Parigi, Mosca, New York, Boston, Madrid ecc. E neppure erano mancati fin dal Settecento studiosi e chimici interessati allo studio dei materiali antichi, alla loro composizione e all’analisi dei pigmenti e degli intonaci antichi. Fra i nomi famosi i tedeschi Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), lo scopritore dell’uranio e il fondatore della moderna chimica analitica, Philip Lorenz Geiger (1794-1836), scopritore dell’atropina e di altri medicamenti, Justus von Liebig (1803-73), specializzato nella chimica organica, gli inglesi sir Humphrey Davy (1778-1829), famoso per le scoperte elettrochimiche e per un dettagliatissimo studio sui pigmenti antichi, Michael Faraday (1791-67), padre dell’elettromagnetismo, che nel 1837 analizzò le tracce di colore e trovò i resti di una «flagrant gum» su alcuni monumenti di Atene (Propilei, Partenone, Theseion).
L’idea vincente, la novità dell’Istituto, fu però la contestualità di laboratori di restauro, gabinetti scientifici, laboratori fotografici, archivio dei restauri, biblioteca e corsi didattici, in modo che tra questi settori potesse avvenire uno scambio continuo di esperienze e di informazioni. Per la prima volta veniva messa in atto quella interdisciplinarità che diventerà la premessa di ogni approccio conoscitivo e conservativo ai manufatti artistici. Un’idea, allora, così originale che il sociologo Domenico De Masi inserì l’Istituto fra i più significativi esempi di gruppi creativi sorti in Europa fra la metà dell’Ottocento e quella del Novecento, accanto alla casa Thonet di Vienna, al Bauhaus di Weimar, all’Istituto Pasteur di Parigi, al laboratorio di Fisica in via Panisperna a Roma, e altri esempi perspicui, molti dei quali ebbero vita breve, mentre l’Istituto rimane fra i pochi longevi.
L’Istituto cominciò la sua attività nel 1941 con la direzione di Cesare Brandi che lo stesso Argan, al quale era stata offerta, aveva ritenuto più adatto a questo compito perché «straordinario lettore interprete dei testi pittorici… più adatto a lavorare sui testi». Argan e Brandi, quasi coetanei, rappresentavano la punta emergente della critica d’arte di quegli anni e ne dominarono il campo per tutto lo scorrere del secolo, con una solidarietà e una amicizia reciproche di intensità pari alla diversità dei loro temperamenti. Brandi si era già occupato di restauri nei suoi precedenti incarichi in Soprintendenza, a Siena e a Bologna, e aveva presto cominciato a elaborare anche la sua speculazione teorica sul restauro, come dimostra una relazione dal titolo «Fondamento teorico del restauro» presentata al secondo convegno dei soprintendenti (10-11 ottobre 1942); è l’antecedente della prolusione al suo corso universitario su Teoria e Storia del Restauro (1948-49) e troverà la sua definitiva codificazione nella Teoria del Restauro (prima edizione, 1963).
L’Italia era uno sterminato campo di macerie e nel campo del restauro non esisteva un indirizzo unitario basato su criteri teorici.
L’Istituto si impegnò fin dall’inizio in restauri importanti che sfociarono in una mostra, ma lo scoppio della guerra e la necessità di ricoverare tutte le attrezzature scientifiche in un luogo sicuro (il Vaticano) ne imposero la chiusura l’8 settembre del 1943. Fu riaperto nel giugno ’44. Io vi approdai nel ’47 pilotata dal mio maestro Ranuccio Bianchi Bandinelli, con il quale mi ero laureata in archeologia a Firenze e che era stato nominato direttore generale per le Antichità e Belle Arti. Vi rimarrò più di un quarto di secolo, fino alla promozione a soprintendente. L’istituto occupava allora il pianterreno e tre piani del Convento dei frati di San Francesco di Paola ristrutturati, sotto la guida di Brandi, da Silvio Radiconcini, uno dei giovani talenti riuniti intorno a Bruno Zevi sostenitore di quella nuova visione dell’architettura che ebbe in Frank Lloyd Wright il suo massimo esponente. Mi parve un luogo magico, sia per il nitore e l’eleganza degli ambienti ove perfino gli arredi erano stati disegnati dall’architetto, sia per la modernità delle attrezzature. Brandi aveva messo a frutto le conoscenze acquisite nel corso di un recente viaggio negli Stati Uniti, dove aveva accompagnato una mostra d’arte italiana e visitato i laboratori scientifici dei principali musei. La sala di esposizione ove si tenevano le mostre delle opere restaurate, con la mobilità dei suoi tendaggi e dei punti luce, era stata concepita per adattarla alle varie esigenze delle opere esposte e rappresentava un’ardita innovazione museografica. Solo lo studio del direttore, affacciato sulla scalinata di San Pietro in Vincoli, serbava intatta la grazia della dimora cinquecentesca dei Borgia. Nella biblioteca adiacente, un ritratto di Adolfo Venturi, opera di Giacomo Manzù, ricordava che la maggior parte dei testi conservati proveniva dalla biblioteca di quel grande storico dell’arte acquistata dal Ministero. Si trattava di un complesso che avrebbe meritato una musealizzazione, sia per il suo significato storico sia per le sue intrinseche qualità estetiche.
Nel 1947 l’attività dell’Istituto era frenetica: sopralluoghi, interventi di emergenza, arrivi di carichi di opere da restaurare. I corridoi erano ingombrati da centinaia di cassette che contenevano frammenti degli affreschi di Mantegna e allievi della Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani a Padova, di quelli trecenteschi del Camposanto di Pisa e degli altri provenienti dalla Cappella Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo, opera di Lorenzo da Viterbo, tutti devastati dai bombardamenti. Il Camposanto di Pisa aveva anche subìto un incendio. I frammenti di Padova erano circa 80mila, quelli di Viterbo 20mila!
Alla fine della guerra il Paese si presentava come uno sterminato campo di macerie. Il tessuto urbano era stato squarciato dalle bombe, i monumenti erano in rovina, le pitture murali, quando non ridotte in minuti frammenti, erano in preda all’incuria, le opere mobili, contenute nei musei o emerse dai provvisori ricoveri, private della consueta manutenzione, richiedevano tempestivi interventi. Per ricucire questi disastri si doveva affrontare un’opera immane e i pareri degli addetti ai lavori sui criteri da seguire negli interventi spesso erano discordi. Le polemiche, che divamparono a lungo sulla stampa del tempo, concernevano soprattutto le scelte sulle ricostruzioni dei monumenti e del tessuto urbano e opponevano due concezioni opposte. L’una, sostenuta anche dal grande storico dell’arte Bernard Berenson, mirava al rifacimento delle opere come erano prima della loro distruzione e faceva proprio l’assioma «com’era, dov’era», dettato dal sindaco Filippo Grimani e ripreso da Gabriele D’Annunzio, quando, nel 1902, era crollato il campanile di San Marco a Venezia. L’altra, argomentata da architetti emergenti e da storici dell’arte di avanguardia, riteneva la prima «un falso» e suggeriva scelte diverse, ma che serbassero la memoria storica di quanto era avvenuto. Come spesso accade si optò per soluzioni di compromesso, non sempre felici. Anche per le opere mobili e per le pitture murali i criteri d’intervento non sempre concordavano.
Di fronte a questo compito sterminato, alla vastità e alla novità dei problemi, i normali metodi di routine si rivelavano del tutto inadeguati; non esisteva un indirizzo unitario basato su criteri teorici. Mancava una filosofia del restauro.
Va tuttavia ricordato che la particolare ricchezza in opere d’arte e la precoce formazione di collezioni artistiche hanno alimentato nel nostro Paese una tradizione ininterrotta nell’esercizio del restauro, anche se il termine va interpretato in una accezione molto più generica di quella che oggi gli attribuiamo. Per molto tempo si è trattato difatti di rifacimenti mimetici o di geniali interpretazioni, ove il manufatto antico forniva lo spunto per creazioni originali. Come avvenne quando scultori di rango intervennero su opere antiche: Tullio e Antonio Lombardo, Donatello, Bertoldo, Verrocchio, Gian Lorenzo Bernini, Algardi, Buzzi, Cordier… Analogamente avveniva per le pitture: ad esempio Federico Zuccari restaurò le Nozze Aldobrandini, famoso affresco romano, subito dopo la scoperta avvenuta nel 1601 e, alla fine dello stesso secolo, Carlo Maratta intervenne sugli affreschi di Raffaello alla Farnesina. Era una pratica già seguita nel mondo greco-romano, dove scultori e pittori di vaglio erano chiamati per restaurare le opere dei loro predecessori. Negli Stati preunitari italiani e poi nell’Italia unita erano attivi laboratori di restauro in cui tecniche, metodi e segreti spesso si trasmettevano per generazioni.
A Napoli le straordinarie scoperte nel Settecento delle città vesuviane aprirono un’ininterrotta attività di restauri; la superficie delle pitture distaccate a massello e di quelle rimaste sul posto era protetta con vernici di vario tipo, la cui composizione veniva tenuta gelosamente segreta e trasmessa di padre in figlio. La più accreditata fu una vernice composta di cera e paraffina, con la quale, ancora fino alla metà del secolo scorso, venivano «rinfrescati» gli affreschi delle città vesuviane. Al momento della scoperta una lunga querelle sulla tecnica delle pitture pompeiane aveva animato i circoli degli studiosi settecenteschi. Alcuni di essi, a causa del nitore della superficie così diversa da quella degli affreschi medievali e di quelli a loro contemporanei, sostenevano che si trattasse di encausti, cioè pittura eseguita con i colori sciolti a caldo nella cera, altri propendevano per la tempera, cioè con i colori sciolti in un legante vegetale o animale, altri ancora, le ritenevano eseguite a fresco (colori sciolti in acqua). I bronzi erano trasferiti nella Real Fonderia di Portici; quelli ritenuti di qualità venivano restaurati con criteri molto disinvolti, spesso servendosi di altri bronzi antichi non pertinenti; gli altri fusi e rimpiegati per rappezzi o per farne busti moderni…
A Bergamo nell’Ottocento si coltivava soprattutto lo strappo delle pitture murali, una tecnica inventata probabilmente a Napoli nei primi decenni dei Settecento e che consisteva nel trasporto su tela della sola pellicola pittorica. Operazione estremamente rischiosa da impiegare solo nei casi in cui il supporto appaia totalmente degradato e irrecuperabile, lo strappo fu largamente praticato da Giovanni Secco Suardo, autore forse del primo manuale di restauro, e da una dinastia di restauratori, gli Steffanoni, chiamati anche all’estero; alla loro scuola crebbe Mauro Pellicioli (1887-1974), celebre, anche se discusso, restauratore della prima metà del secolo scorso. Pellicioli fu chiamato da Brandi insieme ad altri nei primissimi anni dell’Istituto, quando ancora non si era formata la nuova classe di restauratori usciti dalla scuola; ma la sua presenza fu breve e discontinua e la sua dipartita burrascosa: non accettava la nuova etica del restauro istituita sui principi brandiani che imponeva la conoscenza e la riconoscibilità dei metodi e dei materiali impiegati, il ricorso a esami scientifici, il bando di quelle «fumoserie» e di quei misteri ai quali spesso si erano accompagnate le pratiche di restauro. Pellicioli faceva parte di quei restauratori detti amatoriali, il principale esponente dei quali era stato a Milano Luigi Cavenaghi (1844-1918), che lavoravano soprattutto per il grande collezionismo privato e per gli antiquari; per essi ogni lacuna doveva essere mimetizzata onde esaltare l’apparente, ricostituita integrità della superficie pittorica. Anche a Firenze esisteva una lunga tradizione di restauro, più prudente nell’impiego del distacco per le pitture murali, incrementata anche dall’istituzione all’epoca granducale dell’Opificio delle Pietre Dure. Si trattava, tuttavia, per lo più di restauratori privati che agivano in modo autonomo ed eterogeneo, depositari di metodi e segreti gelosamente custoditi. I restauratori inseriti nell’amministrazione dello Stato erano pochi e mortificati in un ruolo inferiore nella scala gerarchica degli impiegati statali.
Non era certo con queste forze sparse, anche se eredi della lunga tradizione e fornite di abile manualità, che si potevano affrontare adeguatamente i drammatici problemi della ricostruzione e del restauro del patrimonio artistico. Occorreva un polo unificante, occorreva soprattutto un salto di qualità che ancorasse la prassi a una teoria. A queste esigenze rispose l’Istituto del Restauro, anche se le battaglie contro particolarismi regionali, inveterate consuetudini, gelose prerogative furono durissime e non sempre tutte vinte. Innovazione e creatività furono le due forze che animarono quelle prime esperienze, banco di prova per gli allievi del primo corso di restauro che attraverso il diuturno esercizio della ricerca e della ricomposizione imparavano a conoscere la materia dell’opera d’arte. I frammenti dei cicli di affreschi estratti dalle cassette e appoggiati su grandi tavoli venivano selezionati, dividendoli per colore, esaminando il verso della pennellata, le asperità e le striature lasciate sull’intonaco di supporto, cercando i margini combacianti. Un’opera da certosini che poteva valersi solo di fotografie in bianco e nero, poiché non esistevano degli affreschi perduti né fotografie a colori, né riproduzioni pittoriche. Eppure si riuscirono a ricomporre dei nuclei composti da più frammenti combacianti che vennero collocati su una riproduzione su tela della fotografia in bianco e nero ingrandita al vero, realizzata dal fotografo dell’Istituto Francesco Peleggi. Esaurita la ricerca, i gruppi ricomposti apparivano come delle isole desolate emergenti dall’intonaco che le collegava; impossibile da questi sparsi lacerti ricavare una pur minima leggibilità dell’immagine perduta. Fu allora che, dopo numerose prove, Brandi ebbe l’idea delle integrazioni a tratteggio. Dai sottili filamenti ad acquarello che riproducevano anche cromaticamente la parte perduta, l’immagine, magicamente, si ricomponeva. Era nato quello che in gergo viene chiamato rigatino.
La novità, l’idea vincente, fu la contestualità di laboratori di restauro, gabinetti scientifici, laboratori fotografici, archivio dei restauratori, biblioteca e corsi didattici.
Il tratteggio applicava un fenomeno ottico già noto agli antichi (studi sull’ottica di Aristotele e dello scienziato alessandrino Claudio Tolomeo) che consente di ricomporre in un’immagine visiva unitaria ad esempio un mosaico, che è un aggregato di tessere colorate. Il fenomeno fu teorizzato da Rudolf Arnheim, il quale in un libro pubblicato negli Stati Uniti nel 1974 che ebbe grande diffusione in Italia nella traduzione Arte e percezione visiva (Einaudi, 1991) scrive: «Quando le aree stimolate sono piccole, ad esempio quando formano un pattern di punti a grana fine, come quelli trasmessi all’occhio da un dipinto divisionista, non c’è scomposizione e il risultato è un’autentica mescolanza additiva». Arnheim fu il più rilevante studioso dell’applicazione alla lettura delle opere d’arte della Gestaltpsychologie o psicologia della percezione, più letteralmente psicologia della forma, una corrente di pensiero nata in Germania agli inizi del XX secolo che indagava sui modi in cui veniva percepita la realtà fenomenica. L’aggiornamento di Cesare Brandi su tutto quanto avveniva nel mondo della cultura era leggendario; non possiamo quindi certo escludere che le idee della Gestalt non abbiano influito sulla sua straordinaria applicazione nel campo del restauro. Brandi nei suoi scritti non ha mai menzionato un suo incontro con Rudolf Arnheim che, per sfuggire alla persecuzione nazista, si era rifugiato a Roma dal 1933 al 1938, prima di emigrare a Londra e poi negli Stati Uniti. Edito nel 1974, il libro di Arnheim sulla psicologia della percezione applicata alle arti figurative è successivo di decenni al suo soggiorno romano e all’invenzione brandiana del rigatino, ma è probabile che questi temi già occupassero le meditazioni di Arnheim che frequentava amici di Brandi come Fedele d’Amico ed Emilio Cecchi, in una Roma ove gli intellettuali si conoscevano tutti. L’uso del tratteggio per le integrazioni delle lacune (limitato, beninteso, solo ove la ricostruzione fosse attendibile) rispettava pienamente un altro dei criteri base dei protocolli brandiani, la riconoscibilità. La tecnica pittorica del tratteggio, ad acquarello, era diversa da quella dell’affresco originale e se a distanza l’immagine appariva ricomposta e unitaria, da vicino l’integrazione era perfettamente riconoscibile. Si trattava peraltro di una tecnica flessibile che poteva essere applicata, e lo fu, anche ad altri materiali. Divenne la cifra distintiva dei restauri dell’Istituto.
La speculazione filosofica di Brandi sul restauro si alimenta attraverso uno stretto contatto con la prassi. L’assioma espresso nella Teoria del Restauro che «ogni frammento in un’opera d’arte contiene in potenza tutto l’intero», sembra nascere proprio dalla frequentazione con i miseri frustuli degli affreschi distrutti e dall’appassionata volontà di ritrovare, attraverso la loro ricomposizione, l’immagine perduta. La stessa lucidissima meditazione sull’incidenza prevaricante della lacuna rispetto al testo pittorico presuppone uno stretto contatto con le opere e nasce dall’esigenza pratica del risarcimento del testo nel manufatto artistico per renderlo leggibile. «La cosa più grave, osserva Brandi, non è tanto quel che manca, ma quanto quel che indebitamente si inserisce, poiché la lacuna... si pone come figura rispetto a un fondo». Il prevaricante aspetto della lacuna determina una perversa inversione delle parti: ciò che è nato come figura, cioè il testo autografo, viene retrocesso a fondo. Le soluzioni proposte sono molteplici, ma devono tutte mirare a retrocedere la lacuna in secondo piano, in modo che rechi il minimo disturbo alla ricomposizione anche mutila dell’immagine. Dalla scelta del tratteggio per le lacune ricomponibili, ci si affida, nel caso di quelle maggiori, a un intonaco grezzo per le pitture murali o al legno del supporto a vista per i dipinti su tavola, come è avvenuto per la Madonna della Clemenza di Santa Maria in Trastevere, prezioso incunabolo dell’arte romana forse ancora del VI secolo, ove il legno del supporto fu lasciato a vista fra brandelli di pittura considerati come reliquie. Se possibile la lacuna è leggermente in sottosquadro e presenta una colorazione adeguata a quella delle aree adiacenti. La banale soluzione della cosiddetta tinta neutra adottata in passato non teneva conto del fatto che non esiste una tinta neutra, ma che, come già aveva acutamente rilevato Roberto Longhi, «una volta inserita nella cerchia di una calcolata sintassi cromatica nessuna tinta è neutra». Il rapporto fra figura e fondo sarà uno dei principali temi affrontati dalla Gestaltpsychologie. Nel 1961, a New York, al XX Congresso di Storia dell’Arte, Brandi presenterà una relazione proprio sul trattamento delle lacune e la Gestaltpsychologie.
In quei primi anni ciascuno di noi (eravamo pochi: l’intero organico dell’Istituto non credo raggiungesse le cinquanta unità) aveva l’esaltante consapevolezza di assistere e, in modo minore, anche di contribuire alla gestazione di una nuova cultura del restauro. Era, certo, un lavoro da pionieri, con i vantaggi e gli svantaggi che questa situazione comporta; creatività, invenzione, fantasia dovevano adattarsi a una manualità ancora incerta, a supporti scientifici poveri e limitati. Ma per la prima volta la metodologia operativa era guidata da una rigorosa speculazione filosofica che poneva il restauro fra i momenti decisivi dell’approccio conoscitivo, come recita una delle più pregnanti definizioni contenute nella Teoria del Restauro: «Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetico-storica, in vista della sua trasmissione al futuro».
Prendendo a prestito una terminologia della semiotica si può affermare che ogni restauro è un’opera aperta; aperta a nuovi interventi di ordine conservativo a causa del progressivo e inevitabile degrado della materia, ma anche per possibilità sempre maggiori offerte da nuove ricerche e dai progressi delle tecnologie. Nessun restauro è definitivo, né tantomeno poteva esserlo quello condotto sui frammenti degli affreschi bombardati. In anni recenti si è difatti nuovamente intervenuto sui tre cicli della Cappella Ovetari di Padova (2006), della Cappella Mazzatosta di Viterbo (1991) e del Camposanto di Pisa (tuttora in corso). Nel primo caso con l’aiuto di apparecchiature computerizzate sono stati ricollocati numerosi frammenti adespoti; il secondo caso è stato un «restauro del restauro» eseguito con tecniche e manualità molto raffinate da Carlo Giantomassi; il terzo è un intervento estremamente complesso che comprende la revisione degli affreschi staccati e la loro ricollocazione, previo risanamento dell’ambiente. Si tratta, quindi, di operazioni molto diverse fra loro, rese possibili perché i primi interventi dell’Istituto erano stati accuratamente documentati ed erano reversibili. Si può anche parlare per questi casi di innovazione nella continuità, poiché i criteri metodologici sono rimasti immutati, anche se i sussidi forniti oggi dai mezzi digitali e dalle scienze archeometriche permettono di raggiungere risultati che allora erano impensabili. Esemplare, in questo senso, il restauro condotto sugli affreschi di Assisi dopo il terremoto del 1997.
Accanto a questi casi estremi dovuti alla distruzione dei monumenti che contenevano le pitture murali, in quegli anni lontani l’Istituto fu impegnato in altre operazioni di salvataggio. La mancanza di manutenzione, l’incuria e l’indebito uso che in alcuni casi ne era stato fatto avevano provocato danni gravissimi a tutto il patrimonio pittorico rimasto in situ. Particolarmente delicata era la situazione della pittura antica: i cicli pittorici del Foro romano, del Palatino, della Domus Aurea e lo straordinario complesso delle pitture delle tombe etrusche di Tarquinia, Veio, Chiusi e Orvieto.
Alla scuola dei restauratori bergamaschi apparteneva anche Luigi Pigazzini, chiamato nel 1939 da Cesare Brandi all’Istituto. Nominato restauratore capo, Pigazzini fu insegnante alla scuola di restauro e seguì per i primi decenni i principali restauri dell’Istituto; con grande duttilità e una buona dose di umiltà egli aderì in pieno alla nuova cultura del restauro e con la sua grande esperienza, sia nel campo del restauro degli affreschi sia in quello della pittura su tavola e su tela, contribuì in modo determinante alle attività di quegli anni. Si devono a Pigazzini e a un gruppo di allievi da lui diretti i distacchi delle pitture murali del Palatino (Casa dei Grifi, Aula Isiaca, Casa di Livia), quelli dell’aula della Villa di Livia a Primaporta con scene di giardino e di un gruppo di pitture etrusche. Scavi successivi salderanno la Casa di Livia al grandioso complesso della Casa di Augusto con le splendide decorazioni pittoriche il cui restauro è stato curato in modo mirabile da una ex allieva dell’Istituto, Gianna Musatti. La stessa squadra di restauratori intervenne anche quando nel 1951 si richiese l’aiuto dell’Istituto per il restauro del gruppo di affreschi provenienti dalla villa di Boscoreale emigrati al Musée Royal di Mariemont in Belgio.
Un’importante scoperta, conseguenza dei distacchi delle pitture romane, fu il ritrovamento sul tergo dell’intonaco di lievi emergenze che erano la traccia delle giunzioni delle giornate lavorative. La definizione usata dai trattatisti medievali indica quella porzione di pittura eseguita giorno per giorno dal frescante finché la preparazione è umida, condizione fondamentale perché avvenga la reazione chimica della carbonatazione di uno dei principali componenti dell’intonaco, la calce. La trasformazione della calce in carbonato di calcio è responsabile del tenace legame fra l’intonaco e i pigmenti sciolti in acqua senza altro legante. Il processo era ben noto a Vitruvio e a Plinio che lo descrivono dettagliatamente. La scoperta nella pittura antica della presenza di giornate lavorative fu di enorme importanza poiché mise fine alle interminabili diatribe sulla tecnica, una disputa iniziata fin dal momento della scoperta delle pitture vesuviane. Vi erano ancora nel XX secolo studiosi che sostenevano che si trattasse di pitture a encausto. In vari casi, sia negli affreschi che nei mosaici, il distacco rivelò la presenza della sinopia, cioè di un disegno preparatorio tracciato in color rosso-bruno (sinopia), ma eccezionalmente anche con altri colori. Sul tergo del soffitto dell’Aula Isiaca si rilevarono le impronte dell’incannucciata sulla quale era stato posto (una tecnica puntualmente ricordata da Vitruvio), mentre sulla ricchissima decorazione dipinta apparvero tracce di doratura appoggiata su uno strato argilloso, una peculiarità che solo più tardi sarà trovata anche su altre pitture murali romane. Sono tutte osservazioni preziose che solo un accurato restauro può rivelare.
Le tombe di Tarquinia, ipogei scavati nel banco tufaceo della collina e che con le loro pareti dipinte costituiscono una delle più preziose testimonianze della pittura antica, durante la guerra erano servite da ricovero temporaneo per militari, prima tedeschi e poi alleati, nonché per la popolazione locale e per gli animali. Le porte erano state divelte, all’interno vi erano stati accesi fuochi e danni irreparabili si erano verificati sulla superficie pittorica. Il colore appariva distaccato dalle pareti a causa delle infiltrazioni di acqua e delle radici che erano penetrate dalla vegetazione soprastante; era devastato dalla presenza di microrganismi e di insetti vari. I deleteri restauri eseguiti in cemento nei decenni precedenti per fermare i lacerti di pittura pericolanti avevano aggravato la situazione. La battaglia contro il diffuso impiego del cemento nel restauro, sia come supporto di dipinti o mosaici distaccati, sia per provvedimenti in situ, fu uno dei grossi impegni dell’Istituto intorno alla metà del secolo scorso; il cemento è irreversibile e igroscopico. Ai primi sopralluoghi la situazione di Tarquinia si rivelò disperata. L’unico salvataggio possibile era il distacco dei dipinti, un rimedio estremo cui si ricorre malvolentieri poiché isola la pittura dal proprio contesto e provoca, comunque, un innegabile trauma; giustamente è stato deplorato l’uso eccessivo che in più casi ne è stato fatto. Tuttavia quei numerosi distacchi compiuti negli anni del dopoguerra furono inevitabili per salvare dei documenti che altrimenti sarebbero andati perduti. Ma il distacco delle pitture etrusche presentava dei particolari problemi. La pittura murale romana poggia su uno spesso strato di preparazione costituito dall’arriccio e dall’intonaco; non sempre ciascuno di essi è formato da tre strati come prescrivono le fonti antiche (Plinio, Vitruvio), ma lo spessore è sempre tale da permettere l’inserzione delle sciabole per il distacco e la conservazione di uno strato di intonaco che protegge il tergo della pittura. Le pitture etrusche, soprattutto quelle più antiche, poggiano invece direttamente sul supporto tufaceo o presentano solo un esiguo strato intermedio, uno scialbo, fra questo e la pellicola pittorica; inoltre la situazione termoigrometrica dell’ambiente, estremamente umido, impedisce di adoperare i collanti impiegati normalmente per l’adesione delle tele alla superficie pittorica da staccare, poiché le colle, che sono igroscopiche, non si asciugherebbero. Questo era stato il principale motivo dei disastrosi tentativi di distacco compiuti in passato, ad eccezione del caso della tomba François a Vulci le cui pitture, distaccate nel 1863 da Pellegrino Succi, poggiavano su un intonaco di notevole spessore. Pigazzini si servì di un collante non igroscopico costituito da gommalacca sciolta in alcool. Con questo sistema fra gli anni Cinquanta e Sessanta furono strappate le pitture delle tombe delle Bighe, del Triclinio, del Letto Funebre e di tre tombe scoperte in quegli anni (delle Olimpiadi, della Scrofa Nera e della Nave); seguirono le due tombe Golini di Orvieto e due settori della tomba del Colle a Chiusi. Le pitture delle tombe di Tarquinia, distaccate, incollate su tela e rimontate su telai, furono ricomposte nel museo di Tarquinia in Palazzo Vitelleschi. Anch’esse in anni recenti sono state oggetto di nuovi interventi: ai telai di supporto di prima generazione in legno sono stati sostituiti telai metallici e successivamente altri telai più sottili, leggeri e compatibili, i cosiddetti telai a sandwich con anima in nido d’ape e strati di lana di vetro e poliuretano espanso, impiegando materiali che le scoperte della chimica organica hanno messo a disposizione del restauro; la superficie pittorica è stata più volte riesaminata e ritoccata. Il restauro è un continuo work in progress, ma tutti gli ulteriori interventi sono stati resi possibili dalla accurata anamnesi di quanto era stato eseguito e dall’impiego di materiali reversibili.
Non si può non ricordare un’altra operazione spettacolare condotta in quel tempo (1951-52) sotto la spinta dell’emergenza: l’estrazione in un sol blocco e il trasporto di una tomba scoperta sulla via Portuense. La tomba recava una raffinata decorazione pittorica del II secolo d.C. Adeguatamente imbracata e sorretta, fu segata e asportata dal banco di tufo entro cui era stata ricavata; fasciata da cordoli di cemento armato, ridotta a un enorme dado del peso di oltre 50 tonnellate, fu caricata su un carro armato e con un viaggio durato un’intera notte fu trasportata al Museo delle Terme ove in seguito si procedette alle operazioni finali di sistemazione e restauro.
Occorreva un polo unificante, occorreva soprattutto un salto di qualità che ancorasse la prassi a una teoria.
Allo stesso clima di emergenza e al suo carattere pionieristico appartiene anche un’altra impresa di grande impegno portata a termine a Colonia alla fine degli anni Cinquanta. Floridissima colonia romana, Colonia serbava ancora numerosi resti del suo passato. Durante la guerra aveva subito centinaia di incursioni aeree che avevano riversato sull’abitato due milioni di bombe riducendolo a un ammasso di rovine. La popolazione si rifugiava nei bunker e, nel corso della costruzione di uno di questi, erano stati scoperti i resti di una lussuosa villa romana ai margini del Reno. Un grande ambiente (7 x 10,27 m), forse un triclinio, era arricchito da un prezioso pavimento musivo degli inizi del III secolo d.C. composto di tessere di dimensioni e materiali diversi sommariamente calcolate in un numero fra il milione e mezzo e i due milioni. La locale direzione delle antichità si rivolse all’Istituto perché ne eseguisse il restauro; la nostra fama di moderni «estrattisti» aveva già varcato i confini nazionali e le tecniche di realizzazione e di restauro per affreschi e mosaici sono molto simili. I tentativi di restauro in situ per ridurre l’umidità, bonificare il supporto, eliminare il velo grigiastro di sali in superficie e restituire coesione alle tessere maggiormente disgregate risultarono vani poiché il luogo aveva subìto un incendio, il cedimento del terreno, infiltrazioni di acqua per condensazione e per capillarità e altri incidenti che ne avevano profondamente deteriorato i materiali. I mezzi per operare erano limitati e la città, come tutto il Paese, era ancora in macerie e priva di strutture adeguate. L’unico salvataggio possibile apparve il distacco. Poiché il tessuto musivo serbava una sua notevole unità figurativa e un sezionamento in più parti avrebbe provocato deturpanti fratture, si decise di effettuare il distacco di tutto il complesso mediante l’avvolgimento su rulli. Dopo aver velato la superficie con un collante, del quale si accelerò l’essiccazione con lampade a raggi infrarossi, furono sezionati i due bordi e arrotolati ciascuno su un rullo. Su un altro rullo di circa 10 metri, rinforzato all’interno da un’anima di legno, fu lentamente arrotolata la parte restante del mosaico di circa 54 metri quadrati. Fu la prima applicazione su larga scala di una tecnica di stacco meno lesiva di quella allora consueta che consisteva nel distaccare i mosaici a sezioni per poi ricomporli. Un gigantesco carrello e una gru trasportarono i rulli con il mosaico distaccato in una baracca appositamente allestita ove furono condotte le operazioni di srotolamento, assottigliamento e pulitura del tergo, congiunzione con i bordi e applicazione su un nuovo supporto formato da malte e resina epossidica. Fu la prima volta in cui, nella ricostituzione del supporto, furono impiegate resine sintetiche di primissima generazione. Chiuso fra due tavoloni e imbrigliato in travi e cavi d’acciaio, il mosaico, pesante circa 100 quintali, fu ricollocato su quattro pilastri nella sede originaria previamente bonificata. Seguirono la svelatura, la rinettatura della superficie e le integrazioni per colmare le modiche lacune. Lo splendido tessuto musivo divenne il primo livello dell’erigendo Museo archeologico della città inaugurato nel 1961: se ne realizzava così, contestualmente, il riposizionamento in situ e la fruizione museale. In anni più recenti (2007-08), a causa di un violento tifone che ha provocato la rottura di una grande vetrata del museo, si è reso necessario un nuovo intervento portato a termine da un gruppo di lavoro guidato da Christoph Merzenich, già allievo dell’Istituto, con la collaborazione e la supervisione dello stesso Istituto. Oltre alla risarcitura dei danni, si colse l’occasione per effettuare dopo circa mezzo secolo la revisione di tutta la superficie del mosaico e applicarvi un nuovo protettivo: un altro esempio di «restauro di un restauro».
La stagione dell’emergenza che aveva costretto all’esecuzione di tanti distacchi si chiuse intorno agli anni Sessanta. I rapporti interdisciplinari sempre più stretti fra l’archeologia e le discipline archeometriche hanno permesso soluzioni meno drastiche. Per merito del fisico Marcello Paribeni fu intrapreso uno studio sistematico sulle cause del deterioramento delle pitture tarquiniesi: risultò prevalentemente provocato dalle brusche variazioni del rapporto fra l’umidità e la temperatura dell’ambiente causate dall’apertura e dalla chiusura delle tombe e dalla presenza dei visitatori. Gli stessi problemi si erano posti per le pitture delle grotte preistoriche, a Lascaux in Francia, ad Altamira in Spagna e per tombe e ipogei in vari altri luoghi. La drastica chiusura, in alcuni casi, l’accesso calmierato a gruppi limitati in altri, l’istituzione di doppie porte e camere stagne, l’impiego di apparecchiature per stabilizzare i rapporti termoigrometrici, i periodici controlli e una costante manutenzione sono le misure attuate rispondenti a quei criteri di minimo intervento che caratterizzano sempre più la cultura della conservazione. Ma tutto questo era irrealizzabile e inconcepibile in quei primi anni.
Con gli interventi pioneristici sulla pittura antica si era aperto un diverso orizzonte per il restauro archeologico. Nei decenni precedenti i restauri monumentali erano stati affidati ad architetti che avevano compiuto pesanti anastilosi, anche in ossequio ai gusti del regime fascista, quelli dei materiali metallici erano ceduti a collaboratori esterni, quasi sempre depositari di pratiche segrete; per le operazioni più modeste, come l’incollaggio dei frammenti ceramici e altro, ci si accontentava dei custodi. Nella maggior parte dei casi erano trascurate le straordinarie potenzialità che il restauro poteva offrire per la conoscenza della storia e delle tecniche nella società antica. Le nuove metodologie, il costante supporto delle analisi scientifiche, il rigore filologico, in sostanza la teoria e la prassi brandiane, non ponevano barriere e limiti cronologici. Per Brandi il restauro si rivolge alla materia dell’opera e su di essa solo si interviene, purché l’aspetto a cui è stata consegnata l’immagine non sia mutato e ne sia rispettata la duplice valenza estetica e storica. Appare quindi irrilevante se si tratti di un manufatto antico o di epoca successiva. Sarà solo il degrado e la qualità della materia a dettare il tipo di intervento da compiere. «Il restauro della pittura antica, scriverà Brandi, rientra nel restauro della pittura a titolo non diverso da quello per cui le pitture medievali non si isolano alle pitture rinascimentali, barocche, moderne». Certo il degrado della materia e la frammentarietà delle immagini, che spesso riducono le opere archeologiche allo stato di ruderi (altro tema genialmente affrontato da Brandi), spingono piuttosto a un restauro conservativo e con minimi interventi integrativi, ma la diligenza e la manualità devono essere le stesse.
Le teorie di Brandi suscitarono anche violente polemiche, sia in Italia sia all’estero. Non tutti accettarono il ruolo critico del restauro, la nuova «dignità» che acquisiva come elemento fondamentale nella conoscenza e nel riconoscimento dell’opera d’arte o del manufatto artistico. E, a proposito di queste due ultime espressioni, ricordiamo che i Greci impiegavano lo stesso termine, techné, per indicare il prodotto dell’attività di Fidia e quella di un umile vasaio. Analogamente il termine latino ars indica sia la produzione artistica sia i mestieri. Questa indistinzione durò per lungo tempo. Sarà solo il Romanticismo che separerà i due «generi».
La lunga segregazione dovuta agli anni di guerra e, per l’Italia, ancor prima, l’isolamento autarchico voluto dal regime, avevano impedito quella libera circolazione di idee, quello scambio di esperienze e quel civile confronto che sono l’indispensabile nutrimento per ogni progresso. Nel campo della nostra disciplina l’apertura delle frontiere rivelò la radicalizzazione di due opposte culture del restauro. Da un lato, quella italiana, condivisa da altri Paesi latini, era il frutto di una maturazione filosofica derivata dall’idealismo e dallo storicismo e, di conseguenza, esigeva in ogni approccio conservativo cautela e rispetto dei segni lasciati sull’opera dalla storia; dall’altro lato la cultura anglosassone, figlia dell’empirismo e del positivismo, mirava a ricondurre l’oggetto del restauro a un suo presunto stato d’origine, cancellando i segni del tempo, e considerava prevalente il giudizio degli scienziati rispetto a quello dei critici d’arte, tanto che i principali gabinetti di restauro appoggiati ai musei erano affidati a chimici o fisici.
Con il nome di cleaning controversy scoppiò quella che fu forse la più violenta polemica mai esistita nel mondo della storia dell’arte. Per oltre quindici anni occupò sopratutto le pagine del «Burlington Magazine», allora la più importante rivista inglese di storia dell’arte. In un vibrante articolo del luglio 1949 intitolato «The Cleaning of the Pictures in Relation to Patina, Varnish and Glaze», Brandi denunciava le drastiche puliture eseguite su dipinti della National Gallery di Londra che avevano distrutto patina, vernici e velature ritenendole aggiunte successive o depositi di sudicio. Con un’approfondita ricerca sui testi e un’attenta analisi dei risultati degli esami scientifici di opere restaurate all’Istituto, Brandi dimostrò inoppugnabilmente che le patine sui dipinti erano accorgimenti impiegati dagli stessi artisti per rifinire e dare un ultimo tocco alla propria opera: «Per spegnere, egli scriverà, la iattanza della materia» e favorire «la consustanzialità dell’immagine». I suoi antagonisti sostenevano che il rispetto della patina era un’invenzione romantica, relitto del «rovinismo» e della teoria del «non restauro» (Ruskin). Seguirono altri articoli, anche sul Bollettino dell’Icr. Dal 1950 infatti l’Istituto aveva una propria pubblicazione su cui vennero riprodotte anche le prime due lezioni teoriche di Brandi che costituiranno il primo nucleo della Teoria.
A Londra la violenza nelle «puliture» aveva raggiunto anche quelle sculture del Partenone che lord Elgin aveva sottratto ad Atene e che il British Museum possedeva dal 1818 (ormai si chiamavano gli Elgin Marbles!). Eppure, al momento del loro arrivo a Londra i marmi erano stati accolti dal più reverente atto di rispetto e ammirazione che l’opera di un artista possa ricevere da un altro artista: Canova si era rifiutato di porvi le mani per un restauro, un omaggio simile a quello che Michelangelo aveva tributato al Torso del Belvedere. Per indagare sulla eventuale presenza di tracce di colori originali e preservare i resti preziosi dallo smog londinese o da altre alterazioni, il British aveva istituito commissioni di indagine e aveva interpellato scienziati come Faraday. Il che non impedì che dalle sculture fossero tratti calchi e si eseguissero puliture con l’acido solforico diluito «alla maniera di Cavaceppi», come se la menzione del grande restauratore italiano del Settecento potesse rappresentare un avallo! Nel 1937-38, in occasione di una richiesta di lord Duveen che aveva donato una nuova ala al museo per sistemarvi i marmi, avvenne di peggio, un atto che pudicamente per molti anni venne chiamato l’«affair»: la manovalanza del museo rimosse con spazzole e raschietti metallici e ammoniaca quello che veniva creduto lo sporco, ma in realtà era la «pelle» del marmo e serbava ancora tracce di preparazione e di colore. La «stagionatura» colore del miele e leggermente rosata che il marmo pentelico assume col tempo era stata scambiata per un accumulo di sudicio! Nella stessa Inghilterra non mancarono voci di dissenso, ma la direzione del museo cercò di stendere un velo di silenzio sulla questione.
L’asportazione della patina dei marmi Elgin avvenne nonostante i testi antichi riferissero molto in merito alle patine. I termini usati per indicare le patine sono ganosis (il termine è greco), circumlitio (probabilmente la sua traduzione latina) e atramentum. La ganosis/circumlitio consisteva in una encausticatura, cioè una lucidatura a caldo con olio e cera punica, e rappresentava l’ultima finitura di un manufatto in marmo, pietra, terracotta, legno ecc. Era così importante che, secondo la menzione di Plinio, Prassitele la affidava a Nicia, uno dei maggiori pittori del IV secolo a.C. Anche Fidia era pittore e non si può escludere che vi fosse la sua mano nelle rifiniture pittoriche del Partenone. L’atramentum era invece una vernice leggermente colorata che il grande pittore greco del IV secolo a.C. Apelle ricavava dall’avorio bruciato e stendeva sul dipinto per ottenere una superficie riflettente. La patinatura veniva ripetuta periodicamente e rientrava fra le normali operazioni di manutenzione. Anche il nitore delle pareti dipinte romane era dovuto a un’ultima lucidatura con boli, cioè terre argillose. Non parliamo poi del colore: che fosse stato uno dei principali coefficienti della scultura antica in marmo, in pietra e in bronzo era un fatto noto sia per le copiose informazioni delle fonti antiche sia per le evidenze sui monumenti. Tracce di colore erano state osservate su molti monumenti antichi già dalla fine del Settecento e avevano sollecitato le ricerche di numerosi studiosi. Tali ricerche si erano intensificate soprattutto dopo l’arrivo a Monaco delle sculture del tempio di Egina acquistate da Luigi I di Baviera nel 1812, sculture che avevano generato disegni e riproduzioni ove più o meno arbitrariamente era ripristinata la vivace colorazione di cui si erano rilevate le tracce. Ad Atene (Paccard, Landerer, Faraday), in Sicilia (Hittorf, Semper), a Roma e in molti altri luoghi del mondo antico si erano moltiplicate ricerche e indagini che avevano confermato la presenza di colore applicato su preparazioni di varia natura applicate sulla superficie litica. Tutto ciò non bastò a fermare le mani sacrileghe. L’«affair» uscì dall’anonimato solo oltre mezzo secolo dopo con un tardivo riconoscimento da parte di due studiosi britannici, J. Jenkins e A.R. Middleton, ai quali si deve la cronistoria di tutti gli interventi compiuti sui marmi fin dal loro arrivo al British Museum. Jenkins, nella sua qualità di curator del British Museum, indisse, poi, una serie di incontri internazionali sull’argomento e illustrò in un articolo la presenza di uno scialbo color arancio e di una pennellata sul tergo di una delle sculture del British che i «vandali» avevano risparmiata. Se non fu una palinodia fu certo un onesto riconoscimento.
Vi saranno molti altri contributi preziosi al tema del colore nell’arte antica come quelli degli studiosi greci impegnati nei recenti restauri dei monumenti dell’Acropoli, degli italiani sui monumenti romani e di quanti altri si interessano al degrado provocato dalla polluzione atmosferica. Ovunque furono trovate patine protettive e residui resti di colore su quella che è stata definita l’«epidermide» dei manufatti.
Il problema della individuazione delle patine e della coloritura nella architettura e nella scultura antica è diventato uno dei temi di punta per la ricerca archeologica e per la conservazione. Negli ultimi decenni, grazie ai più sofisticati mezzi di indagine scientifica, sono apparse policromie prima invisibili. Sulle statue dell’Acropoli di Atene, sull’Augusto di Primaporta, sulla Nike di Samotracia, sul cosiddetto sarcofago di Alessandro nel museo di Istanbul, sulle sculture di Egina e su molte altre sono emerse tracce di coloriture così intense da far sperimentare anche delle riproduzioni su calchi della cromia originaria.
L’appassionata difesa di Brandi in favore delle patine risultò vincente e gradualmente conquistò la generale opinione degli studiosi.
La difesa della patina era diventata una delle bandiere dell’Istituto. Una grossa sfida fu quella di preservarla anche sui bronzi, per i quali fino ad allora la pulitura elettrolitica, con la conseguenza della totale spatinatura, era stata considerata l’unico rimedio per eliminare la corrosione. Il bronzo, come l’argento, era in antico protetto da patine (bitume, esposizione a vapori di zolfo) e vivacizzato da elementi cromatici che andavano dalla doratura alla varietà delle leghe, all’inserzione di elementi in altri metalli o, per gli occhi, di frammenti di marmo o paste vitree, fino a ridipinture a tempera. I bronzi di scavo sono spesso ricoperti dalle cosidette patine nobili costituite da carbonati (malachiti o azzurriti) o ossidi (cuprite), risultato di alterazioni avvenute nel tempo di lunga giacenza in un ambiente privo di sali corrosivi; proteggono la superficie e hanno una loro valenza estetica e storica. Lo Zeus di Ugento (circa 530 a.C.), scoperto nel 1961 e poco dopo affidato all’Istituto per il restauro fu, se non erro, il primo bronzo antico sottoposto a un esame radiografico al fine di esaminarne l’interno. Ai primi restauri sui bronzi, come quelli dello Zeus di Ugento e dell’Efebo di Castelvetrano, ne sono seguiti molti altri, del Grifo e del Leone di Perugia, dei Cavalli di San Marco, del Marc’Aurelio, dei Bronzi di Riace... Si è trattato di imprese molto complesse che hanno richiesto contributi interdisciplinari sempre più articolati e hanno ampliato in modo esponenziale le conoscenze sulla tecnologia antica. In alcuni casi i restauri hanno recato un contributo critico che ha mutato inveterate collocazioni cronologiche, come è avvenuto per la Lupa Capitolina: a seguito degli esami e delle osservazioni sortite dal restauro compiuto da Anna Maria Carruba, già brillante allieva dell’Istituto, un’opera considerata un cardine della scultura antica dal V secolo a.C. è rimbalzata nell’Alto Medioevo!
Nel 1961 Brandi lasciò l’amministrazione delle Belle Arti, e quindi l’Istituto, perché era stato nominato professore all’Università di Palermo. Gli subentrò Pasquale Rotondi, già soprintendente a Genova. Durante la guerra, mentre era soprintendente a Urbino, Rotondi aveva salvato molte opere d’arte che erano state raccolte nelle Marche con la presunzione che questa regione fosse più al riparo da bombardamenti e razzie. Non lo fu e senza l’abnegazione, il coraggio e la prontezza di Rotondi che riuscì a trasportarle e nasconderle nel castello di Sassocorvaro e in qualche altro luogo remoto della provincia, una grossa fetta del patrimonio artistico italiano avrebbe preso la via della Germania.
Con Rotondi si aprì un’era che per buona parte travalica i limiti posti a questo mio intervento. L’Istituto era cresciuto, il personale moltiplicato, molti degli allievi dei primi corsi ne facevano parte. Era nata quella nuova stirpe di restauratori ideata da Brandi. Il Ministero istituì nel 1964 la Commissione Franceschini per studiare i problemi della conservazione e della tutela e suggerire proposte e interventi. Ci furono nuove emergenze come l’alluvione di Firenze del 1966, ove l’Istituto fu impegnato attivamente, nuove imprese come quella per il restauro dei Cavalli di San Marco, alla quale ancora presi parte, e, infine, la battaglia in difesa del patrimonio monumentale minacciato dalla polluzione atmosferica, aperta proprio dal grido d’allarme di Rotondi sul rapido e progressivo degrado della superficie bronzea dei Cavalli veneziani.
Queste battaglie sono ormai condotte su un fronte internazionale. Anche se l’Istituto si era mosso fin dall’inizio in questa direzione con l’accoglimento di allievi stranieri, con le numerose missioni all’estero (fra le prime il sarcofago di Haghia Triada a Creta, le porte di Santa Sofia a Istanbul, le sculture ittite di Karatepe, le pitture di Bonampak in Messico ecc.) e con le collaborazioni con l’Unesco, l’Iccrom e altri organismi intergovernativi, la gestione Rotondi allargò questi rapporti e istituzionalizzò le relazioni con grandi enti di ricerca. I laboratori dell’Istituto, per quanto ampliati e incrementati, ricorrevano con sempre maggiore frequenza a centri di ricerca altamente specializzati. In questa politica Rotondi fu affiancato e sostenuto da figure carismatiche, come Giovanni Urbani, Paolo Mora, Giorgio Torraca (anche se quest’ultimo non fece mai parte del corpo istituzionale dell’Istituto). Il mondo era cambiato; eravamo entrati nell’epoca della globalizzazione. Ma questo è un altro discorso.
Il mio compito era quello di farvi conoscere gli esordi dell’Istituto. Non era, quella, un’età dell’oro e non bisogna mitizzarla, ma fu un’avventura entusiasmante e ha segnato la nostra vita. Con una certa emozione ho dovuto districarmi fra molti ricordi e perciò la mia narrazione è stata inevitabilmente parziale e discontinua, citando solo i fatti che mi sono parsi più emblematici e ai quali ho più direttamente partecipato.
Se, ora, da questa ribalta mi volgo indietro, vedo aprirsi un panorama sterminato: disseminazione di ex allievi, poi diplomati, che sono diventati i migliori ambasciatori della cultura italiana del restauro, lavori e consulenze in tutto il mondo, prestigiose collaborazioni interdisciplinari. La filosofia del restauro dell’Istituto e perfino una certa terminologia, come ad esempio quella di «restauro preventivo» inventata da Brandi, è stata fatta propria da organismi intergovernativi, come l’Unesco, e da istituzioni estranee, se non un tempo addirittura ostili, come il Getty.
Merito della forza delle idee e anche, certo, della facilità degli scambi e della rapidità dei mezzi di comunicazione. A quelle idee, pur nelle inevitabili e opportune trasformazioni, l’Istituto è rimasto fedele. È questo il motivo per il quale, ancora dopo tanti anni, qui mi sento a casa, anche se incontro, come direbbe Truman Capote, «altre voci, altre stanze».
Altri articoli dell'autore
Il nuovo allestimento del secondo piano del Museo Archeologico Nazionale di Napoli consente di vivere in una domus pompeiana
Dietro il coro ligneo sono state rinvenute due figure di uomini armati, databili alla prima metà del Cinquecento, probabilmente parte di una Resurrezione
Nell’area di CityLife, evacuata la piazza sotto l’edificio di Zaha Hadid dopo il distacco parziale
I fondatori augurano tempi migliori ai loro colleghi, soprattutto i più giovani