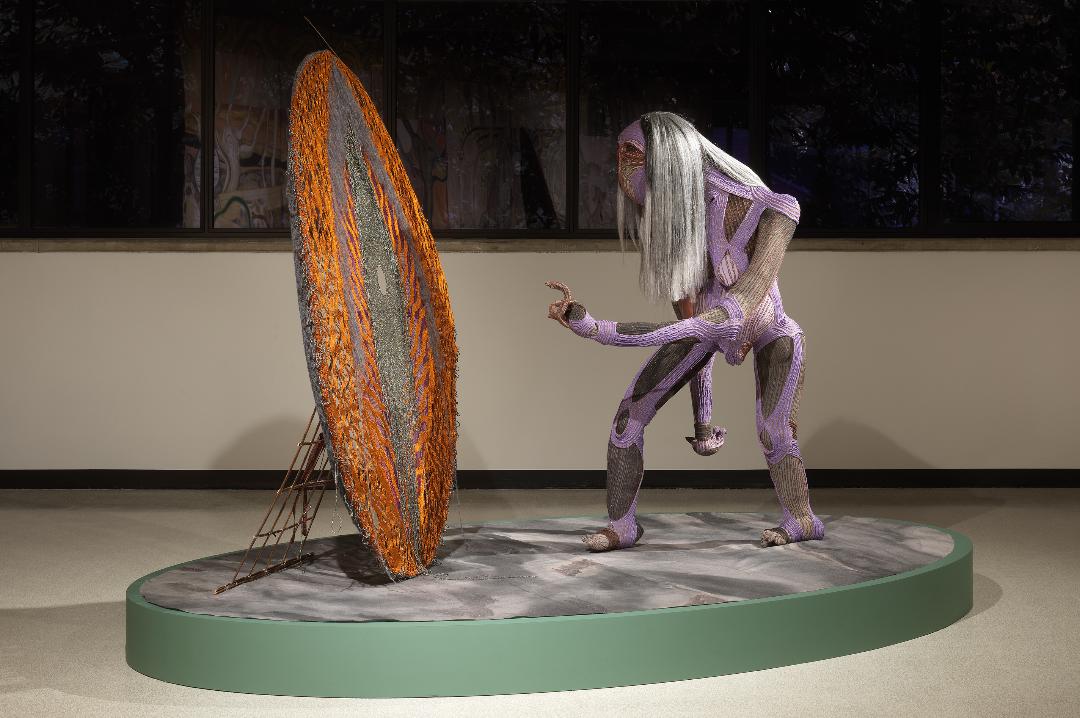Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Valeria Tassinari
Leggi i suoi articoliLa «montagna contemporanea» su cui si estende il progetto di Arte Sella e la grande tenuta intorno alla Fattoria di Celle, dove ha sede la Collezione Gori, sono due straordinari siti dedicati all’arte ambientale, due contesti paesaggistici e concettuali che, per la maggior parte degli aspetti, non potrebbero essere più differenti. Eppure, l’effetto che regalano a chi li visita è piuttosto simile: si esce dall’esperienza con la sensazione di avere attraversato il bosco incantato delle fiabe, quello che ti ammalia, ti mette alla prova e ti cambia, facendoti scoprire qualcosa di te che non immaginavi di avere.
Del resto, nonostante le situazioni che propongono opere d’arte immerse nell’ambiente siano ormai sempre più numerose anche nel nostro Paese, proprio questi due luoghi, entrambi abitati da un genius loci dal sapore ancestrale e dallo sguardo contemporaneo, restano senza dubbio i punti di riferimento più importanti per l’arte ambientale in Italia. Entrambi con una storia pluridecennale alle spalle, e radici profondamente affondate nella natura che li ha ispirati, si espandono e continuano a crescere, grazie all’indissolubile integrazione con decine e decine di interventi site specific progettati da artisti internazionali.
La Collezione Gori a Santomato di Pistoia nasce nel 1970 quando, dopo aver ambientato la loro collezione di arte contemporanea all’interno di un’elegante residenza settecentesca, inserita nella cornice di uno splendido parco-giardino toscano, Pina e Giuliano Gori (imprenditore e appassionato collezionista di lungo corso) decidono di espandere la loro raccolta nella tenuta di pertinenza della villa. I padroni di casa amano invitare gli artisti a soggiornare presso di loro, per approfondire lo scambio intellettuale tra artista e committente. Le opere, progettate dai più noti nomi della scena museale internazionale, sono realizzate in stretta relazione con il luogo, utilizzando un’ampia gamma di tecniche e materiali. Tutte le installazioni, anche quelle monumentali, nascono sempre da progetti condivisi con la proprietà che, su richiesta, ama aprire al pubblico la tenuta, offrendo una visita gratuita rigorosamente accompagnata da una guida esperta.
Arte Sella è un luogo del nord. Si visita partendo da una malga con una cartina in mano, ma nel bosco non ci sono confini, si sentono gli echi del vento che spesso rinfresca la Val di Sella, in Trentino; le opere sono di sasso, di legno, di materiali «saturnini», si propongono come fasi transitorie di un processo, vanno «abitate» attraversate con lo sguardo, ascoltate. Se ti lasci un po’ andare, puoi perderti, aspettare che l’opera che non avevi visto si sveli all’improvviso. L’iniziativa nasce nel 1986, l’anno dell’incidente nucleare di Chernobyl, dall’idea di un’associazione culturale impegnata a sensibilizzare il pubblico sulla questione ambientale. Coerentemente con le sue origini, sotto la direzione artistica di Emanuele Montibeller si muove da sempre intercettando esperienze, poetiche e sensibilità alternative, invitando artisti di qualità ma non troppo noti, coinvolgendo intellettuali, scienziati, musicisti, in un’azione/situazione interdisciplinare che intende riflettere sulla relazione uomo-ambiente.
Pur nelle evidenti divergenze tra le intenzioni che si respirano in questi luoghi, la natura è in entrambi i casi ben più che uno scenario: interlocutrice ed elemento strutturale di ogni opera, enigma da decifrare e materia prima, a lei tutto deve comunque essere ricondotto.
La potenza distruttiva della meteorologia, che in tempi diversi ha colpito duramente anche questi siti, ci offre qui l’occasione di un confronto tra due modi di sentire questo rapporto. Due visioni che chiamano in causa l’identità dell’arte e il suo ruolo nell’Antropocene, l’era in cui abbiamo scoperto di trovarci, tutti figli di una responsabilità che un po’ ci spaventa e un po’ ci soggioga.
Giuliano Gori. Quando la natura ha salvato l’arte
Arte e natura: chi vince?
Il 5 marzo 2015 la violenza della natura avrebbe potuto imporsi, invece l’arte è stata salvata. Alle tre del mattino una tempesta violentissima si è abbattuta sulla tenuta di Celle, sono cadute 550 piante secolari, la viabilità era completamente bloccata. Un disastro. Ma nessuna delle opere è stata danneggiata.
Come avete interpretato l’evento?
Dimostra che se c’è reciprocità, se il progetto è inserito correttamente nell’ambiente, si crea una sinergia perfetta. Il problema è come si costruisce nella natura. Non si può pensare di creare un grande museo d’arte ambientale a cielo aperto come il nostro usando materiali precari. Da noi l’ambiente è parte integrante dell’opera, nel senso che l’opera non è «ambientata» ma profondamente, indissolubilmente inserita nel contesto. I materiali devono poter dialogare, ma anche resistere, rispettare il piano definito dal progetto.
Come nascono i progetti?
Per prima cosa invito gli artisti a «sentire» il luogo. A volte sono artisti che non hanno mai fatto opere di carattere ambientale, devono avere il tempo di sviluppare la loro progettazione, di entrare in sintonia con lo spazio. In genere tra l’idea iniziale e l’esecuzione gli interventi richiedono un tempo che va da tre mesi a due anni. Non c’è preclusione sui materiali, purché ci sia condivisione intellettuale ed estetica tra noi e l’artista. Dobbiamo pianificare tendo in considerazione molti fattori.
L’arte salverà la natura?
Di certo lo farà poeticamente. L’ultima opera che abbiamo realizzato, l’ottantesima, ha richiesto sei mesi di lavoro. Nasce da un’idea dello scrittore Sandro Veronesi e s’intitola «La serra dei poeti», si compone di quattro file di cipressi che convergono prospetticamente verso una struttura in vetro e acciaio in cui si coltivano piccole piante celebrate dai poeti nei loro versi. Gli alberi che abbiamo piantato, dedicati ai poeti italiani, sono un segno di riparazione dell’ecatombe degli alberi caduti per la tempesta, mentre la struttura della serra è ispirata alla voliera storica della tenuta di Celle.
Emanuele Montibeller. Se la ricostruzione è un feticcio meglio una rinascita
Arte e natura: chi vince?
Il 29 e il 30 ottobre 2018 un evento naturale catastrofico ha colpito molto duramente la Val di Sella, e nell’immane distruzione degli alberi sono rimaste coinvolte anche numerose installazioni. Del resto il rapporto d’amore di queste opere con il bosco di Monte Armentera, dove si estende una parte di Arte Sella, le ha legate al suo destino. Questo ci ha messo sicuramente alla prova, però noi non siamo un museo ma una situazione artistico-ambientale, il nostro obiettivo non è aggrapparsi al manufatto, ma innescare un processo di sensibilizzazione. Non abbiamo mai pensato che le opere dovessero essere permanenti.
Come avete interpretato l’evento?
Un evento di quella violenza è connesso ai mutamenti climatici, richiama una responsabilità dell’uomo. Sicuramente ci ha destabilizzato, ma anche portato a fare ragionamenti nuovi, ad esempio sull’uso delle nuove tecnologie, che è tempo di tenere in considerazione. Intanto abbiamo agito velocemente per ripristinare le opere che non sarebbero state snaturate dal nostro intervento, ma molte altre opere sono state e saranno rinnovate con progetti degli stessi artisti e anche di altri. Già prima era prevista la modalità di sostituzione delle opere nell’ottica di un processo di sostenibilità ambientale che consentisse il rinnovamento del bosco.
Come procede il ripristino?
Non esiste una modalità unitaria, su ogni opera bisogna ragionare in maniera sensibile, per non perdere il significato voluto dall’autore. Assecondare un processo di rinnovamento è in realtà insito nei meccanismi stessi della natura. Nelle installazioni bisogna avere consapevolezza che la collocazione è fondamentale e incide per più del cinquanta per cento sul senso del progetto e sulla sua estetica. Il nostro obiettivo è di proporre delle esperienze che cambino l’atteggiamento delle persone nei confronti dei problemi ambientali, l’oggetto è l’ispiratore dell’esperienza, non il punto di arrivo.
Avete ricevuto segni di solidarietà e avviato una raccolta fondi per la rigenerazione del parco?
Abbiamo avviato molti progetti, a differenza degli enti pubblici noi possiamo essere molto veloci. Ma quello che ci aiuta di più è l’afflusso dei visitatori. La loro presenza è ciò che restituisce valore al nostro lavoro, perché è nel tempo che le persone trascorrono con l’opera che verifichiamo il valore del nostro investimento in creatività.

Un’opera della montagna di Arte Sella, «Nido di Sella II» di Nils-Udo. Foto Giacomo Bianchi
Altri articoli dell'autore
Nella Strozzina di Firenze sono esposte le opere finali dei progetti che dal 2005 si sono aggiudicati il premio, frutto della collaborazione tra il brand di moda, la Whitechapel Gallery di Londra e la Collezione Maramotti di Reggio Emilia
Il percorso antologico di Gian Marco Montesano alla Galleria Spazia presenta una serie di lavori che richiamano i principali temi della sua ricerca
Per la sua prima personale in Italia, nella Collezione Maramotti, l’artista ha realizzato 20 grandi dipinti su velluto nero: una scelta ispiratagli da Julian Schnabel e dalla pittura barocca
A Palazzo Roverella una trentina di opere autografe e una quarantina di dipinti di autori meno noti inseriscono il pittore danese nel contesto europeo e ne indagano il rapporto con l’Italia