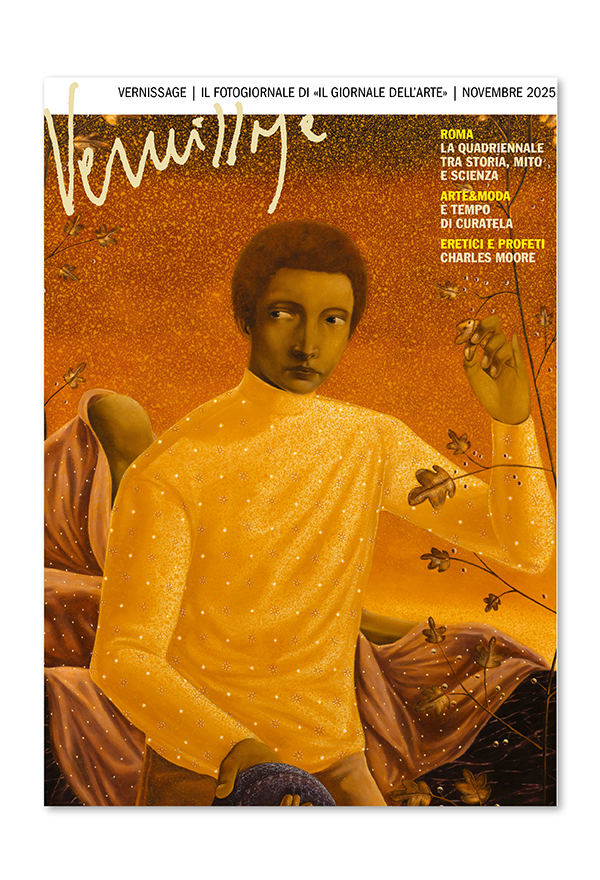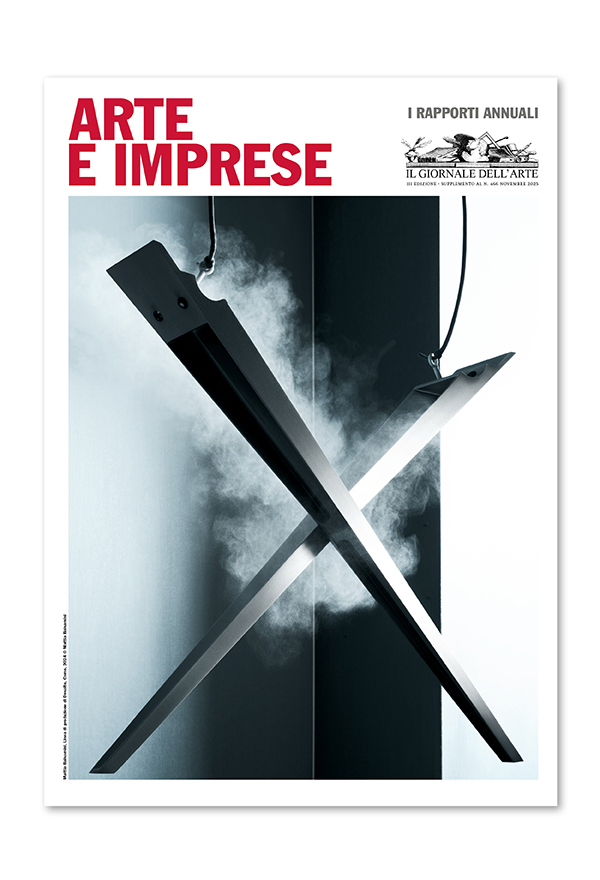Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliDa giorni sulla stampa, prima cittadina poi nazionale, e sui social, rimbalza la polemica sul «cubo» brunito che svetta nello skyline del centro storico, nell’area dell’ex Teatro Comunale in Corso Italia, un tempo sede del «Maggio Musicale Fiorentino». Polemiche che hanno portato ad aprire una inchiesta in Procura per approfondire se siano state violate norme edilizie e urbanistiche, anche se al momento non vi sono indagati o ipotesi di reato ed è molto probabile che tutto si risolva in una bolla di sapone. Tanto rumore forse per nulla, ma che solleva molti quesiti di più ampia portata in una città messa a dura prova dall’overtourism e da investimenti stranieri che, se da un lato dovrebbero portare ricchezza, dall’altro spingono ai margini gli abitanti meno facoltosi e gli studenti ‘fuori sede’, stravolgendo il tessuto estetico e sociale; va tuttavia precisato che il quartiere in cui sorge il cubo è residenziale, con prezzi al mq comunque alti.
Il cubo, che supera in altezza gli edifici circostanti ed è visibile da varie parti della città, (ma senza in questo alterare quanto previsto dal progetto iniziale) ha colori scuri e materiali giudicati in forte contrasto con le architetture vicine. Il progetto incriminato risale al 2013, quando la giunta guidata dall’allora sindaco Matteo Renzi decise, una volta inaugurato e reso operativo il nuovo «Teatro dell’Opera» (che avrebbe rimpiazzato il Teatro Comunale), di destinare la vecchia struttura (ottocentesca ma con aggiunta di interventi successivi) a scopo residenziale ricettivo, con alcuni limiti, tra cui quello di conservare la facciata originale, di non superare l’altezza della torre scenica del precedente edificio (30 metri circa) e di ridurre la superficie costruita da 21 a 18mila mq. Il progetto del 2018 prevedeva tre edifici e una strada interna, ed è proprio il colore brunito di uno dei tre a rappresentare oggi la pietra dello scandalo.
La «Cassa Depositi e Prestiti» che aveva acquistato l’ex Teatro, messo in vendita dal Comune per 23 milioni di euro dopo due aste andate a vuoto, era riuscita nel 2020, a rivenderlo, a poco più della metà del valore, alla «Blue Noble» e «Hines», due società internazionali che si occupano di immobiliare e che avrebbero infatti deciso di destinare gli edifici a appartamenti in vendita o ad affitti. Da qui parte lo ‘scaricabarile’ delle responsabilità, perché la Soprintendenza, al cui vertice era all’epoca Andrea Pessina, aveva dato parere positivo al progetto, compreso il colore e il materiale ora incriminati. Come sempre avviene in questi casi, i pareri oggi divergono, tra chi grida allo scandalo per gli orrori permessi, cercando i responsabili, e chi afferma invece che Firenze sempre osteggi il ‘nuovo’ a priori, per eccesivo conservatorismo. Questa seconda accusa troverebbe giustificazione nella bocciatura del progetto di Arata Isozaki, pur vincitore di un concorso internazionale, per l’uscita della Galleria degli Uffizi, mai realizzata.
Al di là delle diatribe cittadine e del riflesso mediatico, il cubo non è che una testimonianza di una criticità innegabile ben più ampia, che riguarda, al di là dei singoli casi, la modalità con la quale gli enti, non solo fiorentini, attuano i propri controlli, per cui avviene che la Soprintendenza si pronunci magari sull’intonaco, ma non si accorga, per esempio, di un ‘fuori scala’.
Il Cubo rientra nel «Regolamento urbanistico» adottato dal Comune di Firenze nel 2014 che prevede di non costruire «un mattone in più», puntando alla riqualificazione e recupero del patrimonio esistente, circa 750.000 mq. «Tanto per dare un ordine di misura, spiega l’architetto Piero Baroni, se ci vogliono circa 2000,00 €/mq ciò corrisponde a una cifra di circa 1.500.000.000 euro, una cifra colossale che fa gola a tutti gli operatori economici e imprese, con un’attrattiva che oltrepassa i nostri confini italiani e che coinvolge quindi investimenti oltreoceano, anche asiatici e fondi internazionali». Come sottolinea Baroni «tutto avviene senza un’idea di città ed un disegno che indichi funzioni collettive e private nei contenitori da recuperare; i pochi interventi collettivi di rilevanza sono sul sistema infrastrutturale (TAV e tramvia, anche se rimane in sospeso il tema della tangenziale a NORD). Gran parte di questi contenitori appartiene a banche locali o a scala nazionale ad enti pubblici e privati; ciascuno immette sul mercato nazionale ed internazionale il suo contenitore proponendo una nuova destinazione d’uso permessa dal Regolamento urbanistica che privilegia il ricettivo rispetto a funzioni collettive».
Alcuni contenitori pubblici sono quindi ceduti direttamente dall’ente (vedi in questo caso il Comune di Firenze) a Cassa Depositi e Prestiti (è la nuova IRI) che li valorizza progettualmente e li immette sul mercato delle aste internazionali (come appunto per l’ex Teatro Comunale di Firenze); in alcuni casi grandi contenitori come il complesso di Sant’ Orsola (il cui proprietario era il Demanio) sono oggetto di scambio con la «Città Metropolitana di Firenze», che l’acquisisce cedendo gli edifici della Facoltà di Agraria delle Cascine di proprietà comunale: un’operazione positiva in questo caso, perché ha destinato a funzioni collettive un contenitore all’interno del centro storico. In altri casi invece è direttamente il Demanio a vendere, per esempio l’Ospedale di San Gallo, la Scuola di Sanità a Costa San Giorgio, il complesso di Monte Oliveto, la Manifattura Tabacchi. «La politica è debole, precisa ancora Baroni, ed è di conseguenza dipendente da queste lobby economiche; a ciò si aggiunge l’assenza dell’intellettuale militante e di docenti universitari di grande fama che molto spesso hanno svolto in passato, almeno fino alla fine degli anni Novanta [si pensi alla riconversione pubblica dell’area del complesso delle Murate] un’attività critica di controllo e di elevata qualità. Per superare gli ostacoli della Soprintendenza, Commissioni Paesaggistiche, opinione pubblica, gli operatori economici si rivolgono alle “archistar” che garantiscono riconoscibilità ed una maggiore attenzione da parte dei soggetti istituzionali di controllo».
Il «cubo» dello scandalo va dunque inserito in questo quadro istituzionale. La decisione della Soprintendenza di imporre il mantenimento della facciata del vecchio Politeama, teatro di cui non è rimasto più niente dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, si era rivelata già «un’operazione di tutela debole, nota Baroni: se proprio si voleva tutelarlo, era necessario imporre il vincolo su tutta la struttura. Il risultato è invece, ora, una quinta con sul retro un edificio contemporaneo: questo tipo di interventi si realizzavano negli anni ’80, un post moderno, déjà-vu!» I nuovi progettisti degli acquirenti, uno studio milanese, seguono il progetto iniziale firmato Archea ed il risultato è quello che vediamo oggi, dove l’errore non sta tanto nel metallo brunito scelto ma nel generale approccio metodologico: se la facciata su via Solferino è accettabile, pur con un gioco di pieni e vuoti marcato da grandi infissi metallo scuro con vetri a specchio abbastanza discutibili, «ciò che appare inusuale e inaccettabile è il corpo superiore del prospetto ottocentesco su Corso Italia, trattato con una facciata continua con vetro riflettente che ricorda certi uffici direzionali delle aree periferiche; a questo si aggiungono i prospetti interni della via interna e quelli superiori delle torri “famosi cubi neri” interne rivestiti in lamiera brunita tipo bronzo di qualità e dettagli architettonici non elevati. Questo edificio, conclude Baroni, è purtroppo la rappresentazione materiale di un’incapacità collettiva di creare identità architettonica; ritengo che tutti siano coinvolti con le loro responsabilità non penali ma culturali in questa sconfitta. Pertanto, la querelle estiva sul cubo nero o la scelta chiaro o più scuro è del tutto ininfluente».
Lunga sarebbe la lista delle incongruenze in materia di vincoli e di permessi: basti ricordare che, a poche centinaia di metri, dall’ex Teatro Comunale, la stessa Soprintendenza ha vietato, ritenendole lesive al decoro, le pensiline alle fermate della tramvia, obbligando gli utenti a sostare sotto il sole estivo o le intemperie invernali. Impedimenti che vengono posti anche a chiunque chieda di aprire una finestrella sui tetti del centro storico, intervento visibile solo ai droni o a chi sorvoli Firenze in elicottero a bassa quota!. Eppure, invece, chi attraversa la bellissima zona di campagna suburbana a sud della città potrà imbattersi nel faraonico e totalmente fuori scala progetto del «Rocco B. Commisso» Viola Park, noto semplicemente come Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli, di proprietà della società calcistica italiana ACF Fiorentina, realizzato in un’area rurale con vincolo paesaggistico, ma per la quale poi è stata richiesta, e concessa, la variante del piano regolatore….
Resta l’amarezza di notare che Firenze, a differenza di altre città europee, pur avendo vantato nel Rinascimento un primato nell’architettura, non abbia oggi una visione complessiva della contemporaneità. Quando l’architetto Giuseppe Poggi abbatté negli anni Sessanta del XIX secolo le mura di Firenze per costruire i viali di circonvallazione sul modello parigino dei boulevards del barone Haussmann, ugualmente le critiche furono feroci, come d’altronde lo erano state quelle dei parigini contro Haussmann (Baudelaire nei «Fiori del male» esclama «palais neufs, échafaudages, blocs, vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie!»). Tuttavia, in quei casi c’era un disegno urbanistico d’insieme, legato, per Firenze, alla decisione di rendere la città, nel 1865, capitale del nuovo regno (lo sarà solo fino al 1870). Ora il volto di Firenze va invece mutando tramite iniziative singole e slegate che, se da un lato arricchiscono le casse comunali in crisi, dall’altro si prestano più facilmente a polemiche, rinforzando l’idea, un po’ facile se affrontata in modo generico, di un passatismo restìo ad ogni trasformazione, quando il problema risiede altrove, nella questione dell’ identità cittadina e nei servizi offerti ai suoi abitanti.

Altri articoli dell'autore
Nelle «Giornate per l’arte contemporanea» sono state presentate la mostra all’UMoCA dell’artista argentino e la nuova installazione permanente di Tobias Reheberger
S’inaugura nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’omaggio a un’artista radicale e carismatica
Tra l’Accademia di Belle Arti di Firenze, la Fondazione Ragghianti di Lucca e il Museo Ardengo Soffici di Poggio a Caiano, due giornate di studio grazie a nuove fonti archivistiche e a carteggi inediti propongono una rilettura dell’opera del pittore, lontano dalle sperimentazioni delle avanguardie
Nuova veste espositiva per il celebre bronzo etrusco, assurto a simbolo dell’Unità d’Italia, grazie al contributo dei coniugi statunitensi Winchester, prima tappa del riallestimento delle sale etrusche