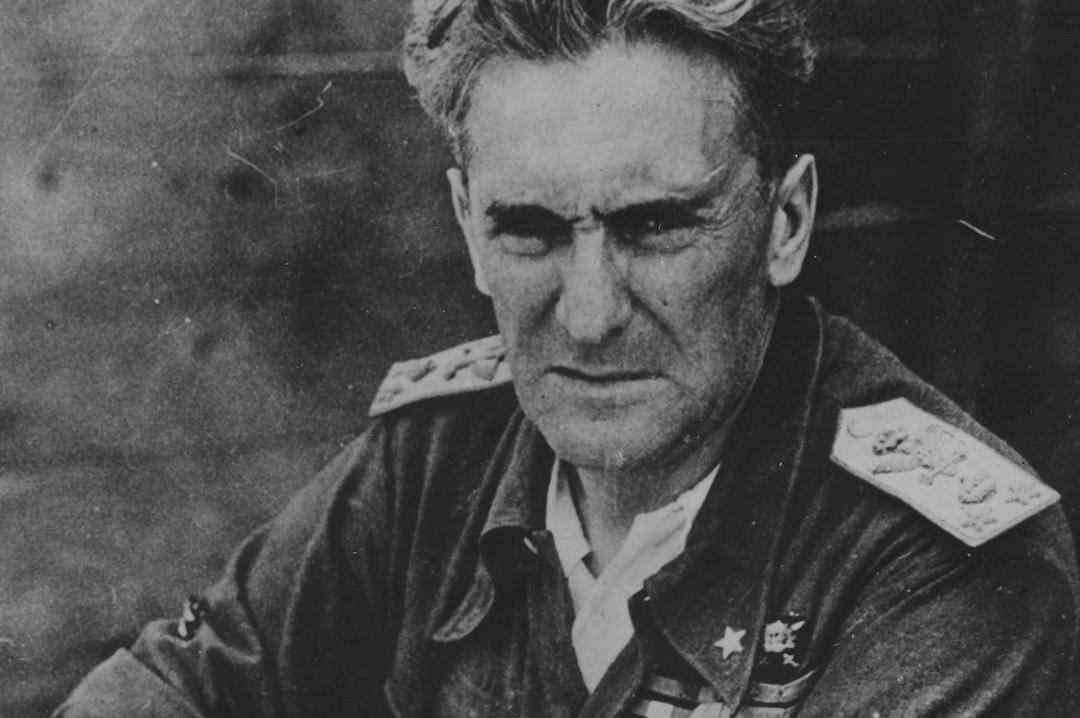Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliÈ ancora lungo il percorso che dovrebbe portare alla ratifica italiana della Convenzione di Nicosia e, perché possa essere messa in pratica, a una nuova legge per i reati contro i beni culturali da inserire nel nostro Codice Penale. Un importante passo avanti è stato compiuto il 13 ottobre quando il Senato ha approvato, senza alcun voto contrario, la ratifica di quella Convenzione, firmata dall’Italia nel 2018. Dopo quello del Senato, si aspetta il voto della Camera dove la ratifica, già approvata dalla Commissione Affari Costituzionali, è ancora al vaglio delle Commissioni Giustizia, Bilancio e Cultura.
La ratifica italiana della Convenzione di Nicosia è attesa da quando, nel maggio 2017, è stato firmato a Cipro quel trattato internazionale, promosso dal Consiglio d’Europa, che impegna i Paesi aderenti a far sì che le proprie leggi proteggano in modo efficace i beni culturali da danni, distruzione, furti, scavi illegali e traffico illecito. Per ora, 14 Stati, dei 47 membri del Consiglio d’Europa, hanno firmato la Convenzione di Nicosia (Cipro, Grecia, Armenia, Portogallo, San Marino, Italia, Slovenia, Ungheria, Russia, Ucraina, Montenegro, Lettonia e anche il Messico (che nel Consiglio è «Stato osservatore»).
Ma la Convenzione non è ancora in vigore: infatti è necessaria la ratifica di almeno cinque Stati e per ora sono solo quattro: Cipro, Lettonia, Grecia e Messico. Quindi diventerà operativa quando sarà ratificato anche dall’Italia. La ratifica della Convenzione implica però seri obblighi e gli Stati aderenti sono tenuti ad assicurare norme efficaci e dissuasive, con pene detentive e pecuniarie adeguate, che riconoscano la specifica gravità criminale dei reati commessi a danno dei beni culturali. È quindi necessario che l’Italia aggiorni le sue leggi, oggi del tutto inadeguate a fronteggiare e reprimere quei reati.
In effetti, una proposta di legge firmata da Dario Franceschini e Andrea Orlando, che intendeva riformare dalle basi le disposizioni penali vigenti, era già stata approvata dalla Camera il 18 ottobre 2018. Passata al Senato il 6 novembre di quell’anno, non è stata più discussa. Dopo quasi tre anni di oblio nel 2021 è stata riproposta dal senatore Orlando. L’iter parlamentare del disegno di legge è così ripreso al Senato nel maggio 2021 e le procedure previste per la sua approvazione definitiva sono quindi parallele a quelle in corso alla Camera per la ratifica della Convenzione di Nicosia.
La nuova legge intende inserire nel nostro Codice Penale, sotto il titolo «Delitti contro il patrimonio culturale», 19 articoli elencati nel testo della Convenzione: alcuni introducono nuove fattispecie di reato, altri prevedono pene più pesanti per quelli già previsti dal Codice dei Beni culturali e dal Codice penale. Tra questi: furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e danneggiamento dei beni culturali, sanzionati oggi con pene irrisorie. Tra i nuovi reati entrano l’illecito impiego e alienazione di beni culturali, la contraffazione e il traffico organizzato di beni culturali. Sono anche previste maggiori pene per qualsiasi reato comune qualora provochi danni gravi ai beni culturali e paesaggistici.
Convenzione di Nicosia e futura nuova legge italiana fanno parte, insieme a molti altri trattati internazionali, del tentativo di creare un sistema globale di tutela del patrimonio mondiale. È importante ricordare che nel mondo l’Italia è il Paese più colpito dal traffico illecito dei beni culturali, soprattutto a opera di organizzazioni criminali, le cosiddette archeomafie, che si servono di questi beni anche per il riciclaggio di denaro: un valore stimato in centinaia di milioni all’anno.

I Carabinieri tpc con un reperto trafugato

«Cristo nella tempesta sul mare di Galilea» (1633) di Rembrandt, rubato nel 1990 dall’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston
Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis