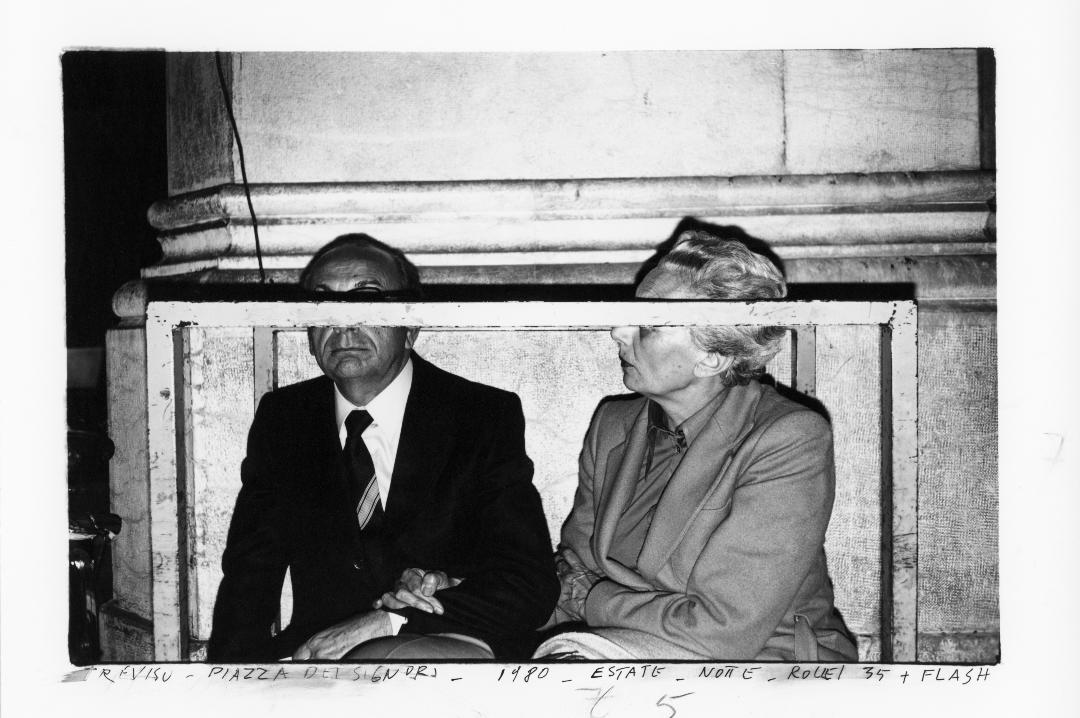Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Si faceva chiamare Christian Stein ma lei era, in realtà, Margherita Stein. E prima di aprire la sua galleria a Torino, esattamente cinquant’anni fa, in via Teofilo Rossi, non aveva mai lavorato. Normale, per una bellissima ragazza nata («negli anni del Déco», diceva lei con civetteria) in una famiglia della migliore borghesia piemontese, in cui si praticava il collezionismo d’arte, anche contemporanea (Fontana, Manzoni, Lo Savio) e in cui aveva ricevuto «un’educazione piemontese: cattolica, liberale, militare». Cioè: studio costante, rigore, impegno a «fare le cose fino in fondo, eccezionali o banali che siano». Aveva poi sposato un alto magistrato di origine tedesca, Christian Stein appunto, di cui aveva assunto non solo il cognome ma anche il nome. Si legge sempre che lo fece per essere più rispettata nel mondo del lavoro, ma nell’intervista del 1992 pubblicata nel catalogo della prima mostra della sua collezione, al Nouveau Musée di Villeurbanne, presso Lione, diede una risposta ben più spiazzante: «Avevo una bambinaia provenzale, che è rimasta con noi tutta la sua vita e che ha allevato anche mio figlio; ebbene, per lei, nel momento in cui mi sono sposata, sono diventata “la signora Christian”».
Perché Margherita-Christian, che fu una vera mecenate per i «suoi» artisti (i futuri maestri dell’Arte povera, fra i più fieri contestatori dei valori borghesi) restò sempre, invece, una «grande borghese», ma nell’accezione più nobile che questa espressione potesse allora avere: «Gli artisti sapevano che non condividevo le loro idee. Non ne parlavamo mai. Capivo le opere senza passare per le idee politiche. Parlavano di “rivoluzione”, ma per me era solo una rivoluzione artistica». Eppure non esitò a vendere i Fontana e i Manzoni della collezione materna, oltre ai suoi gioielli («ma era di moda portare abiti afghani, e dunque niente gioielli! Farei lo stesso oggi») per finanziare la galleria, che all’inizio non fruttava un quattrino. E quando nel 1967 allestì la prima personale di Alighiero Boetti e non vendette nemmeno un’opera, acquistò tutto lei. Perché «nessun’altra cosa nella vita, spiegava, mi dà la stessa gioia dell’arte».
Tutto ciò poteva accadere solo coltivando il rapporto umano con gli artisti: «Per lavorare bene, amava dire, per approfondire la conoscenza, bisogna dedicarsi solo a pochi di loro. (...) Ho vissuto al loro fianco mentre lavoravano, ho visto nascere le loro opere». Mai un contratto, perché «in Italia solo le gallerie commerciali lavorano con contratti». La sua, invece, era un laboratorio di cultura e il loro rapporto «si basava sulla stima reciproca; tutto si è svolto sulla base di una grande libertà. Libertà, fedeltà e lavoro, tanto lavoro».
Chi fossero quegli artisti è presto detto; erano i giovanissimi torinesi che Germano Celant di lì a poco avrebbe riunito nell’Arte povera: Anselmo, Boetti, Calzolari, Fabro, Kounellis, i Merz, Paolini, Penone, Pistoletto e Zorio, oltre a Parmiggiani, Uncini e Lo Savio. A loro si sarebbero aggiunti i più giovani Domenico Bianchi e Remo Salvadori e gli stranieri Kiefer, Baselitz, Penck, Schütte, Förg, Gilbert&George, Serra, Oldenburg, Wall e altri. Ma nella sua collezione c’erano anche opere magnifiche di Fontana, Melotti, Manzoni, Castellani, Ettore Colla e De Dominicis. Tra i poveristi, possedeva anche molte opere di Calzolari, anche se non gli dedicò mai una mostra.
E poiché lei (scomparsa nel 2003 nella sua casa galleria di piazza Vittorio Veneto a Torino, poi diventata una sorta di casa museo) amava offrire proprio una «casa» alle opere dei suoi artisti, dopo via Teofilo Rossi, a Torino si trasferì nei grandi appartamenti di piazza San Carlo e appunto di piazza Vittorio Veneto, dove esponeva e abitava. Aprì una galleria anche a New York, con Barbara Gladstone, e nel 1985 ne inaugurò una a Milano in via del Lazzeretto, poi una casa galleria in via Amedei e infine la galleria nell’attuale sede di corso Monforte 23: queste tutte gestite, e da subito, da Gianfranco Benedetti, che è stato al suo fianco («con una disponibilità e un’onestà eccezionali», dettò lei all’intervistatrice francese) sin dal 1971, portando poi avanti con esemplare rigore il suo lavoro, e che nel 2007 ha aperto anche la vasta sede di Pero, appena fuori Milano, per presentare le opere di grande formato: l’accesso prima era limitato ai collezionisti, poi, dal 2014, con una mostra di Boetti, al pubblico.
Gianfranco Benedetti, la cui riservatezza è diventata una sorta di leggenda tra gli addetti ai lavori, non ama rilasciare dichiarazioni: preferisce esprimersi con il suo lavoro e per i 50 anni della galleria ha presentato una personale di Giulio Paolini, interlocutore prediletto di Christian Stein («Ho un legame molto forte con Paolini. Ho la stessa stima per tutti i miei artisti ma Paolini è uno di quelli che vengono da me più spesso. Apprezzo molto anche quello che scrive»). La mostra è stata inaugurata il 10 novembre, lo stesso giorno in cui mezzo secolo fa si apriva la prima sede torinese e proseguirà sino al 29 aprile 2017. Curata da Bettina Della Casa, s’intitola «Fine» e occupa i due spazi di corso Monforte a Milano e di via Vincenzo Monti a Pero. Qui sono esposti suoi lavori di grande formato dagli anni Settanta a oggi, scelti e disposti dall’artista secondo una sua personale geografia, oltre a tre interventi inediti. A Milano, c’è invece un’unica, grande installazione, quella che dà il titolo alla mostra, nella quale Paolini (Genova, 1940, vive a Torino), facendo riferimento all’«Imbarco per Citera» (1717) di Watteau, mette in scena una grande «zattera» carica di oggetti del suo studio, sia opere sia strumenti d’uso. La commenta in uno dei suoi testi limpidi ed evocativi a un tempo, chiuso da poche, ferme parole: «Guardare, vedere, dimenticare… Andata, ritorno, fine». Un testo che sarebbe certo molto piaciuto a Christian Stein.
Altri articoli dell'autore
Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori
Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese
10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare
Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate