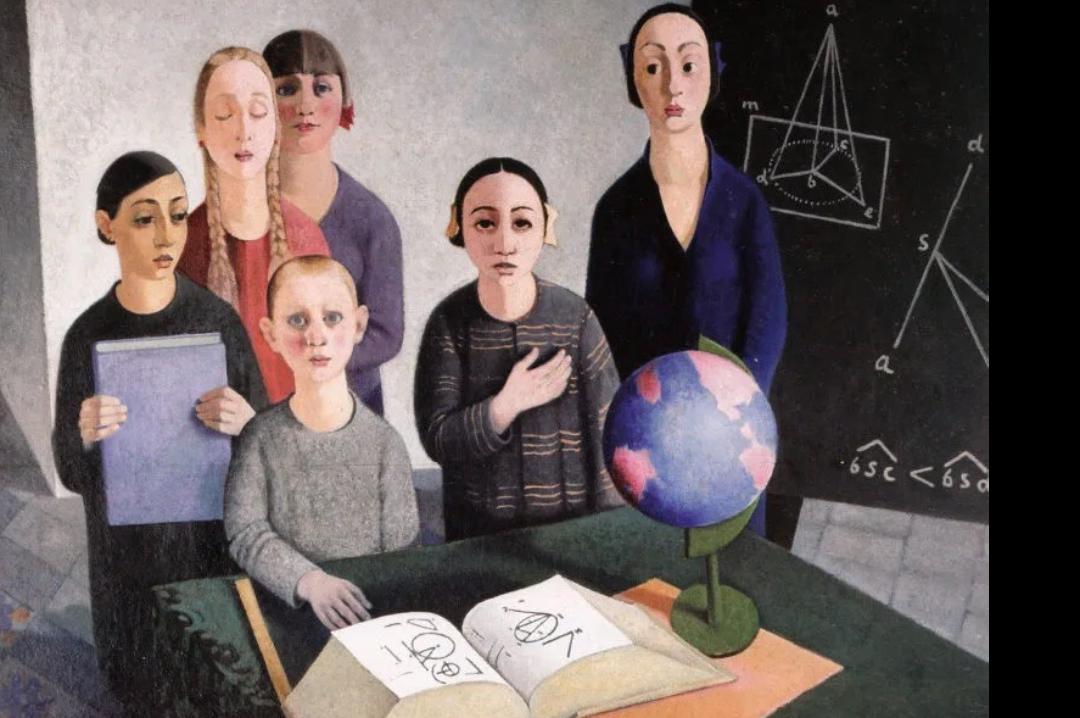Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliA distanza di sessant'anni dalla prima fondamentale e pionieristica monografia su Francesco Solimena, di Ferdinando Bologna (1958), viene pubblicata una nuova, straordinaria e monumentale monografia, in due volumi (oltre millecento pagine e sette chili di peso), diretta e in gran parte scritta da Nicola Spinosa con la collaborazione di un team di studiosi, che si sono dedicati ai disegni, all’architettura, alla scultura alla musica del Settecento napoletano intorno a Solimena.
Sessanta anni di studi, sistematici e non, hanno prodotto una mole imponente di ricerche, scoperte e non è stato certamente semplice anche il loro riordino. Spinosa sottolinea che i due volumi non costituiscono in realtà il catalogo dell’intera produzione del pittore, che dipingeva a getto continuo, replicava ed era copiato nella sua bottega e da altri pittori già al suo tempo. Sono invece una selezione precisa che comprende opere note e ignote, documentate o storicizzate. Il curatore ha comunque escluso quadri ritenuti poco importanti o dubbi e d’altra parte la redazione monografica dell’opera di un artista maggiore, non può che essere soggetta a interpretazioni, aporie e conseguenti scelte.
Ma chi fu veramente Francesco Solimena, detto l’Abate Ciccio, pittore (ma anche scultore e architetto) ai suoi tempi celeberrimo? Nato in una borgata del Serino nel 1657 e morto a Napoli nel 1747, fu allievo del padre Angelo. La sua formazione avvenne poi a Napoli, corroborata da studi letterari di alto livello, che ne fecero un artista del tutto singolare, versato nella filosofia, nella storia e nella poesia, tanto che fin da giovanissimo gli fu profetizzato (dal futuro papa Benedetto XIII) che egli sarebbe diventato «la meraviglia delle arti». Solimena elaborò assai presto uno stile proprio, scenografico e arioso, ricco di retorica barocca magniloquente, sostanziato da una bravura e una facilità di resa pittorica incredibili. Lavorò per le maggiori chiese di Napoli, in un crescendo di qualità e di potenza immaginativa.
Ben presto la sua fama lo fece ricercare e le sue opere suscitarono vasta eco fuori del mondo partenopeo. Imperatori e re (i Borboni in testa) richiesero i suoi quadri che egli eseguì e spedì senza spostarsi quasi mai dalla sua città e che andarono a «ingioiellare» (come gli scrisse in una lettera laudativa il Principe Elettore di Magonza) le migliori collezioni di tutta Europa. Vittorio Amedeo II, suo committente, rimase letteralmente ipnotizzato dalla sua arte tanto da dover confidare al pittore di non poter passare nella sala del Palazzo Reale di Torino dove erano quattro suoi dipinti senza fermarsi ad ammirarli «forzato dalla bellezza di essi».
Tra i molti pregi del Solimena è quello di essere stato ottimo insegnante: attorno a lui si strinse infatti una scuola con molti allievi che venivano educati severamente, per diventare pittori ma anche colti «valentuomini» come il loro maestro. Solimena si occupò durante la sua lunghissima vita solo di arte. Preso dal demone della pittura «non diede di se alcuno scandalo, nè in materia di giuoco, nè d’illeciti amori». Unico suo divertimento era l’andare alla sera a casa del suo grande amico Alessandro Scarlatti a sentire musica. Fu zio affettuosissimo di molti nipoti che amò come figli e che fece diventare nobili comprando per loro un feudo grazie ai circa duecentomila scudi che il De Dominici afferma che avesse guadagnato con il suo lavoro. Le sue opere avevano infatti prezzi esorbitanti e il pittore non faceva mai sconti, ritenendo di dover difendere così anche l’onore della sua arte.
Si fece costruire una splendida casa ove visse come un gentiluomo d’alto rango. Rimase però modesto e fin da giovane vestì con abiti clericali; di qui il soprannome familiare di Abate Ciccio. In vesti di abate appare anche nell’autoritratto di Capodimonte del 1720 che ne distilla al colmo della maturità il carattere pacato, sereno, le movenze sicure e illuminate dalla viva intelligenza dello sguardo.
I due volumi che ci restituiscono a tutto tondo Solimena e l’impagabile ambiente artistico del primo Settecento napoletano, sono frutto di quattro anni di assiduo lavoro editoriale, con materiali iconografici nuovi e spesso inediti; rendono merito alla sua splendida arte e diventeranno un indispensabile strumento per gli studiosi del settore. Il primo volume ospita il catalogo ragionato dei dipinti, mentre nel secondo si trovano quello dei disegni (Cristiana Romalli); saggi sull’architettura (Leonardo Di Mauro), sulla scultura e le arti decorative (Gian Giotto Borrelli), su Solimena illustratore ( Lorella Starita) e sulla musica al tempo di Solimena (Dinko Fabris).
Chiudono il secondo volume il regesto sul pittore a cura di Tiziana La Marca, la bibliografia generale e gli articolati indici dei nomi e dei luoghi. In Solimena, secondo i suoi biografi, si riunirono «molte delle perfezioni descritte nelle vite di altri pittori celebri, non solo di nostra patria, ma eziandio de’migliori di altre rinomate città»: la nobile magia di quell’arte, la suggestione di un impareggiabile civiltà artistica, la singolarità di un pittore gentiluomo, rivivono ora, per la gioia dei nostri occhie del nostro spirito, in questi nuovi studi.
Francesco Solimena (1657-1747) e le Arti a Napoli, a cura di Nicola Spinosa, due volumi 1100 pp., 400 ill. col., 600 ill. b/n, Ugo Bozzi, Roma, € 320,00

Francesco Solimena, autoritratto (particolare)
Altri articoli dell'autore
A che cosa serve la giornata indetta dall’Unesco e dedicata a celebrare i libri? A far venire voglia di leggerli, of course
Anche i poveri hanno bisogno di arte e ora che Bergoglio non c’è più siamo tutti più poveri
Ma se volete vedere la bella stagione (quella vera) o sentir parlare di lei, andate nei musei o cominciate a leggere un libro di mitologia
Nella Mole Vanvitelliana sono presentati i restauri delle opere di chiese e musei danneggiate dai sismi del 2016-17 e del novembre 2022