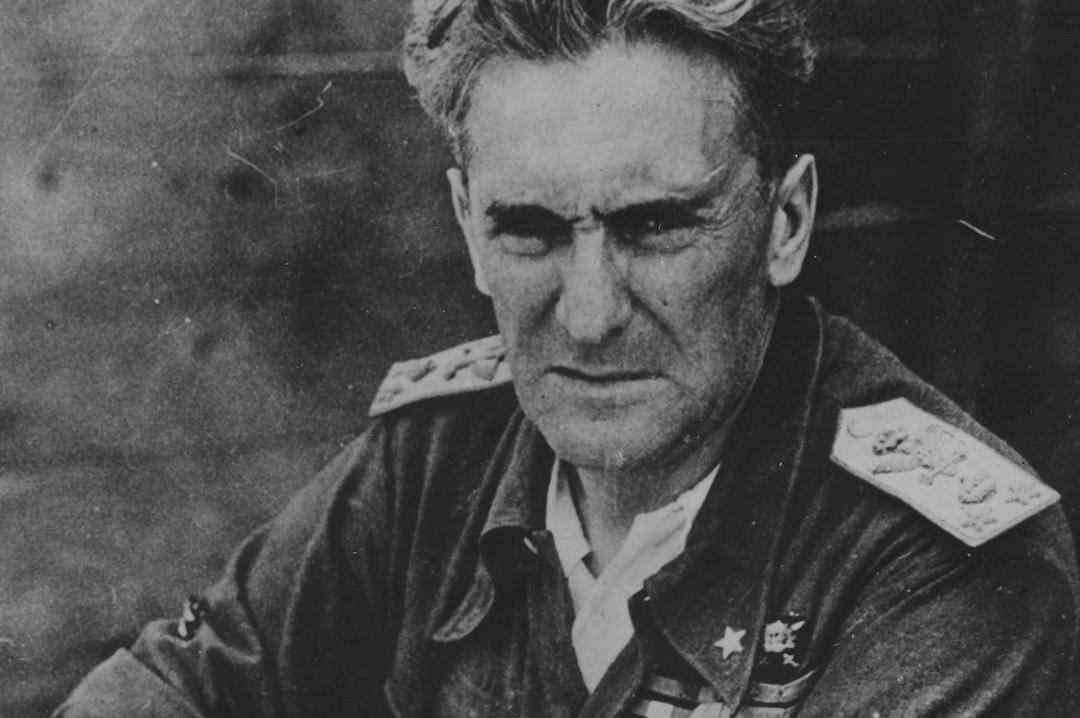Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Edek Osser
Leggi i suoi articoliIl «nuovo Ministero» è opera essenzialmente di Franceschini, perseguita a partire dal 2014 (e nonostante il tentativo di controriforma di Bonisoli). ArtBonus, Soprintendenze uniche, i primi 20 musei dotati di «autonomia speciale» (oggi sono diventati 40) e i direttori «stranieri». Poi le Direzioni regionali Musei e le nuove Direzioni generali come la Digital Library. L’urgenza rimane il personale interno: insufficiente e da qualificare.
Sono passati più di 6 anni dall’agosto 2014, quando il Consiglio dei Ministri approvò la «Riorganizzazione del Ministero dei Beni culturali e del Turismo». Si tratta di quella che tutti hanno sempre chiamato «riforma Franceschini». La sua storia è stata però molto lunga: era iniziata con studi e proposte che risalgono ai decenni precedenti e poi agli anni ’90 con il ministro Antonio Paolucci. In seguito alcune cose al Mibact erano cambiate, ma senza nessuna vera «riforma».
È l’arrivo al Ministero di Dario Franceschini a segnare la svolta. Nel febbraio 2014 uno dei suoi primi atti è l’introduzione dell’ArtBonus: nello stesso anno Massimo Osanna arriva a Pompei e con la sua azione e i fondi dell’Ue salva e rilancia il grande sito archeologico. Per la riforma, perché fosse approvata, c’è voluto un pretesto: è stato la spending review, decisa dal Governo per risparmiare sui costi della Pubblica Amministrazione. Tagli per tutti, anche sul numero dei dirigenti dei Ministeri e, quindi, necessità di riorganizzare le loro strutture burocratiche.
Meno dirigenti anche nei vertici del Mibact a Roma, e Franceschini ne approfitta per attuare il suo progetto di una riforma profonda: prima di tutto, dare più spazio e poteri alle strutture del territorio. Vengono create tra l’altro le discusse Soprintendenze uniche e, vera grande novità, i primi 20 musei dotati di autonomia. Un anno dopo, nell’agosto 2015, tra i direttori scelti con un concorso internazionale (per la prima volta e tra le polemiche) arrivano 7 stranieri. Nei due anni successivi la riforma si amplia. I musei autonomi diventano 30, il budget assegnato alla cultura cresce mentre in fase d’attuazione la riforma mostra limiti importanti e alcune decisioni devono essere riviste. Poi tutto si blocca quando, a settembre 2018, si forma un nuovo Governo (il Conte I).
Alberto Bonisoli è il nuovo ministro dei Beni culturali ma non più del Turismo che passa all’Agricoltura (e il Mibact diventa Mibac). Dopo 10 mesi dal suo arrivo, nell’estate del 2019, annuncia «una revisione complessiva di tutto il funzionamento del Ministero». È una specie di controriforma che prevede un’inversione del processo di decentramento previsto da Franceschini e un accentramento di poteri e funzioni a Roma.
Per questo Bonisoli crea una fortissima «Segreteria generale» e toglie l’autonomia a tre grandi musei (Galleria dell’Accademia, Museo etrusco di Villa Giulia e Parco dell’Appia Antica). Ma il Governo cade e nell’agosto 2019 al Ministero torna Franceschini. Le decisioni che caratterizzavano il progetto di Bonisoli vengono presto annullate e il Turismo torna al Mibact.
La riforma viene perfezionata e si va completando. I musei autonomi diventano 40, aumentano di numero le Soprintendenze, con poteri rafforzati e i Poli museali, poco efficienti, diventano Direzioni regionali Musei con tracce di autonomia. Al centro nascono nuove Direzioni generali, mentre cresce e diventa importante la Direzione generale della Creatività contemporanea della quale fa parte l’Istituto per la Digitalizzazione del Patrimonio (la «Digital Library») che svolge un ruolo cruciale durante la pandemia e sarà domani una delle strutture chiave per il Mibact.
Oggi l’attuazione della riforma è in fase molto avanzata anche se serviranno altri interventi per farla funzionare al meglio. Difficile dire quanto ci vorrà per mettere a regime l’intera struttura e assumere il personale necessario: il virus ha bloccato anche i concorsi. Più che dal Mibact, il futuro dei musei dipende ora dall’andamento della crisi sanitaria, dai vaccini e dal recupero dell’economia in Italia e in Europa.

Altri articoli dell'autore
Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane
Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi
L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?
Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis