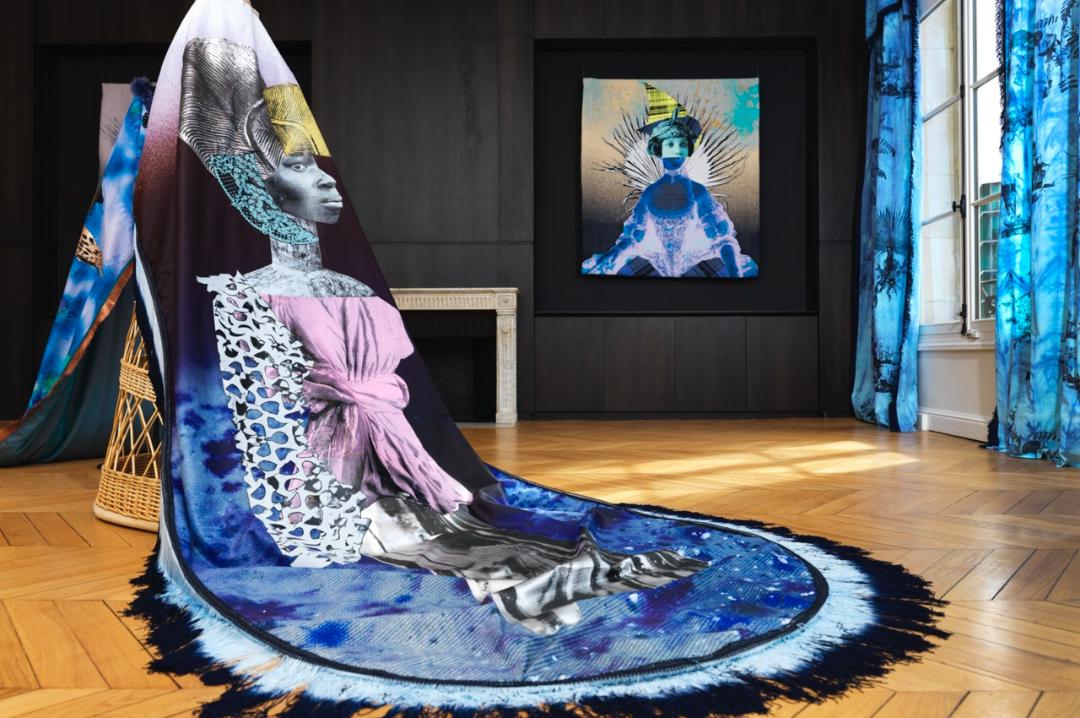Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliBrassaï a Milano, Tina Modotti a Parigi, Robert Capa e Gerda Taro a Torino: scorrendo la programmazione delle mostre di musei e centri d’arte non si può non constatare come la fotografia in bianco e nero, con la sua forza simbolica, carica di nostalgia, continui ad affascinare.
«Credo che l’essenza della fotografia sia il bianco e nero. Il colore non è che una devianza», diceva la fotografa Ruth Bernhard. Il collega Peter Lindbergh riteneva a sua volta che il bianco e nero fosse «collegato alla verità più profonda dell’immagine, al suo significato più nascosto». E forse non è un caso che lo scatto che ha battuto tutti i record sul mercato dell’arte sia «Le violon d’Ingres» (1924), venduto all’asta da Christie’s a New York nel 2022 per 12,4 milioni di dollari. Una fotografia, in bianco e nero ovviamente, in cui Man Ray espresse nel modo più estetico e sensuale l’amore per la sua musa, Kiki de Montparnasse.
Probabilmente una delle mostre più attese di questa stagione è «Brassaï. L’occhio di Parigi», fino al 2 giugno al Palazzo Reale di Milano, dedicata al grande maestro della fotografia umanista. Una mostra antologica in sei sezioni, curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote di Brassaï, che allestisce 200 stampe vintage, oltre che documenti d’archivio e oggetti personali del fotografo.
Come mai il bianco e nero conserva ancora oggi tutta la sua magia, anche nell’era del digitale e della realtà virtuale? Alla domanda ha voluto rispondere la Bibliothèque nationale de France, a Parigi, dove si è chiusa di recente una mostra che farà storia, «Bianco e nero. Un’estetica della fotografia» (17 ottobre-21 gennaio 2024). L’ampia e ambiziosa rassegna, con più di 300 scatti di Man Ray, Ansel Adams, Helmut Newton, Diane Arbus, Mario Giacomelli, Willy Ronis o ancora Robert Frank, attinti dalla collezione della Bnf, un fondo di più di sette milioni di immagini, di cui 10mila fotografie, ha raccontato 150 anni di storia del bianco e nero passando in rassegna la varietà dei generi e delle tecniche, dall’accentuazione del contrasto luci e ombre, che conferisce una dimensione scultorea allo scatto, alla saturazione del bianco spinta all’estremo che crea un’atmosfera surreale.
La Bnf mostra come, malgrado l’invenzione del colore, nel 1904 grazie ai fratelli Lumière, diventato di moda negli anni ’60-70, i fotografi sono rimasti fedeli al bianco e nero: «La sua persistenza fino ad oggi, ha scritto il museo, è dovuta soprattutto al fatto che la fotografia in bianco e nero ha finito con l’incarnare l’essenza stessa della fotografia. Appare portatrice di una dimensione universale, là dove il colore sarebbe la traduzione del solo mondo contemporaneo». «Il colore è descrittivo. Il bianco e nero è interpretativo», diceva Elliott Erwitt.
Sempre a Parigi, al Musée national d’art moderne del Centre Pompidou, sta per terminare (il 25 marzo) «Corpo a corpo. Storia(e) della fotografia», altra mostra colossale, con più di 500 scatti provenienti dagli archivi del Pompidou e dalla collezione privata di Marin Karmitz, con alcune serie classiche della fotografia in bianco e nero, tra cui quella celebre degli anni ’30 sulla metropolitana newyorkese di Walker Evans.
Al Jeu de Paume, invece, fino al 26 maggio, c’è una personale di Tina Modotti (1896-1942), icona della fotografia «pura», dal titolo «L’occhio della rivoluzione», prodotta con la Fundación Mapfre di Madrid. In poco meno di 240 scatti, tra cui «Donna con bandiera» del 1927, l’istituzione parigina ripercorre vita e carriera di Tina (emigrata a 16 anni da Udine negli Stati Uniti, a San Francisco), femminista, amica di Frida Kahlo, musa e amante di Edward Weston, maestro della «straight photography» (fotografia diretta).
Tornando in Italia, il Centro per la fotografia Camera di Torino, dopo le personali di Dorothea Lange e André Kertész, presenta un’altra esposizione in cui protagonista è il bianco e nero. La mostra evento è «Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l’amore, la guerra», fino al 2 giugno, con una selezione di 120 fotografie curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi che racconta la vita e la carriera della coppia di artisti, uniti dal lavoro e dall’amore. Fino al 14 aprile, Camera propone anche «Ugo Mulas. I graffiti di Saul Steinberg a Milano», che ricostruisce la decorazione a graffito dell’atrio della Palazzina Mayer a Milano realizzata da Steinberg nel 1961, e «Michele Pellegrino. Fotografie 1967-2023», un’antologica sintetica, in 50 scatti, altro inno al bianco e nero.



Altri articoli dell'autore
Il Musée Marmottan-Monet ripercorre tutta la carriera dell’artista che al suo allievo più famoso insegnò la tecnica e la passione dello stile tipico degli impressionisti
Le due mostre al Musée d’art moderne de Paris propongono un focus sulla figlia e modella del maestro fauve e sull’espressionista tedesca, che non fu soltanto «la compagna di Kandinskij»
All’Institut du monde arabe sono esposti 130 reperti scampati ai bombardamenti, insieme a foto inedite della Striscia e delle antichità del Libano, perché conservati al Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra
I costumi orientali di Rembrandt, i foulard di Élisabeth Vigée-Le Brun, la «marinière» di Picasso, le camicette huipil di Frida Kahlo, i pois di Yayoi Kusama sono esempi di come si diventa un’icona popolare anche per gli abiti che si indossano