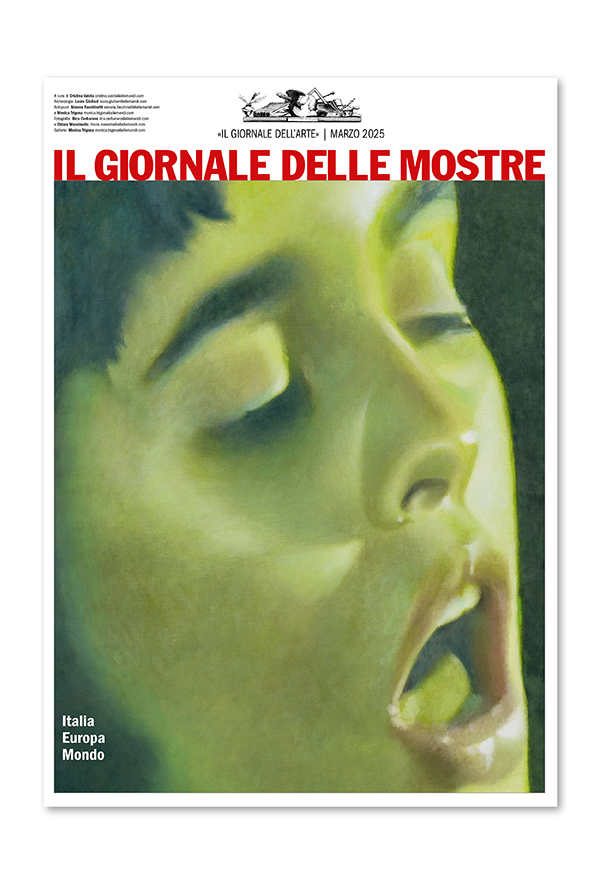Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti
Leggi i suoi articoliPalazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato il 14 settembre la conferenza dal titolo «Patrimonio culturale e transizione ecologica». Il tema ha riunito intorno al tavolo di discussione Massimo Osanna, direttore generale dei Musei, Pascal Liévaux, capo dipartimento per la ricerca del patrimonio culturale, Ministero della cultura francese, Giovanni Brianza, amministratore delegato Edison Next, Simonetta Giordani, segretario generale Associazione Civita, e Davide Usai, direttore generale del Fai - Fondo per l’Ambiente italiano.
Introdotto da Christian Masset, ambasciatore di Francia, e coordinato da Vania Virgili, dirigente tecnologa dell’istituto di scienze del patrimonio culturale - CNR, l’incontro ha toccato i punti nevralgici che ruotano intorno a transizione ecologica e sostenibilità ambientale, soggetti qui declinati nell’ottica del patrimonio culturale. Quali le strategie da mettere in campo, e quali le urgenze? A questi interrogativi ciascuno ha fornito risposte non solo secondo la propria specifica prospettiva, ma ricercando una direzione comune e condivisa. Tutti i convegnisti hanno ribadito la necessità di linee guida, linguaggi e metodologie partecipate, a livello nazionale e internazionale. La transizione ecologica, tra le priorità per i PNRR di Francia e Italia, è difatti un impegno preso a livello europeo, reso sempre più urgente dal cambiamento climatico e dalla drammatica congiuntura storica.
Come ha sottolineato l’ambasciatore Masset, Italia e Francia sono all’avanguardia non solo nella conservazione dei beni culturali, ma anche nella ricerca tecnologica interdisciplinare, ad esempio nel campo del restauro, come dimostra quello in corso a Palazzo Farnese, per il quale è stato pensato un nuovo sistema di isolamento che impiega un materiale ecocompatibile come il sughero. Per la copertura del tetto, inoltre, non sono state utilizzate nuove tegole, ma reimpiegate le originali, opportunamente sottoposte a pulitura.
Per quanto concerne il cambiamento climatico, Osanna ha dichiarato che, in questo momento, fondamentale «è la necessità di censire e conoscere, al fine di elaborare soluzioni preventive. Per questo abbiamo distribuito un questionario a tutti i musei dello Stato per verificare la presenza di requisiti quali i controlli climatici nelle sale, e le squadre di diagnostica sul sito. La situazione è drammatica: il 70% dei musei non ha attività di manutenzione programmata. È assolutamente necessario che essa sia attivata, recuperando risorse non solo da indirizzare ai grandi attrattori ma anche ai piccoli musei. Anche perché, in Italia, ha forse senso parlare di “piccoli musei”? Pensiamo ad autentici gioielli come Sperlonga o Palazzo Farnese a Caprarola».
Il convegno si è svolto in partenariato con Edison, operatore energetico leader della transizione energetica, che collabora con eccellenze culturali italiane quali il FAI, la Fondazione del Teatro alla Scala, e la Biennale di Venezia. Edison, attraverso la società Edison Next, accompagna aziende e territori nei processi di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Ad esempio, la partnership con il FAI ha portato a una riduzione dei consumi di energia di oltre il 90% per Villa Panza a Varese, come ha illustrato Giovanni Brianza: «I risultati che abbiamo ottenuto sono, in questo settore, rilevanti. Abbiamo trasformato la prima del Teatro della Scala in un evento completamente green, lavorando sull’illuminazione delle Corderie alla Biennale di Venezia, abbiamo ridotto i costi del 70%. Dopo la pandemia, e a seguito dell’invasione russa in Ucraina, il mercato energetico è impazzito. È necessario consumare meno e meglio. In ambito culturale abbiamo analizzato i conti economici dei musei pubblici: il 70% dei costi è relativo al solo consumo energetico».
Ha aggiunto Davide Usai: «per noi del FAI, il concetto di ambiente è molto ampio, è tutto ciò che circonda il bene che noi tuteliamo. Ci vogliamo porre, nella gestione dei nostri siti, come modello di comportamento innanzitutto etico. Grazie alla partnership con Edison, abbiamo realizzato, ad esempio, un impianto di geotermia e condizionamento a Villa Necchi Campiglio a Milano, e recuperato la cisterna per la raccolta delle acque piovane a Villa Panza. E ora, sempre con Edison, daremo vita a un nuovo progetto: la valutazione delle emissioni di Co2 in tutte le nostre settanta sedi. È un esempio concreto che ci auguriamo possa essere seguito».
Anche per Simonetta Giordani di Civita l’impegno per la transizione ecologica e per il patrimonio culturale va coniugato in chiave sociale, come pure per Vania Virgili del CNR, che ha rimarcato come alla velocità del cambiamento climatico debba corrispondere un’altrettanto tempestiva risposta da parte della ricerca.
Per Osanna la sfida, oltre che nella rapidità delle soluzioni tecnico-scientifiche, sarà soprattutto il sapere utilizzare al meglio le opportunità offerte dal PNRR, al cui centro è la doppia transizione: verde e digitale. «È una sfida che offre grandi risorse, ma è pur vero che il patrimonio italiano è assai esteso. Una misura specifica sulla quale si andrà in particolare a lavorare sarà l’efficientamento energetico dei musei. Centoventi luoghi della cultura, grazie anche al citato monitoraggio svolto, saranno ripensati nella logica dell’efficientamento. Si partirà dall’impiantistica, nella gran parte dei casi ormai desueta, ma si interverrà anche sulle strutture murarie e sulla climatizzazione».
Anche per Giordani la straordinaria opportunità del PNRR deve divenire uno strumento per coinvolgere i privati, per convincerli a investire in cultura, non una mera iniezione finanziaria che rapidamente andrà ad esaurirsi: «Cogliamo questa opportunità, utilizziamola per lavorare insieme, pubblico, privato e cittadini. Per le sfide che ci aspettano c’è bisogno dell’apporto di tutti».

L’applicazione del Nanogel, un materiale per il restauro sostenibile. Foto Andrea Avezzù
Altri articoli dell'autore
Gli scenari economici svantaggiosi sottolineati dal report di Nomisma nel caso della mancata riduzione dell’Iva riguardano la minore competitività a livello internazionale e il rischio di compromettere il patrimonio culturale delle gallerie con notevoli diminuzione delle vendite
Durante l’evento romano dell’Associazione Gruppo Apollo dedicato al mercato dell’arte è stato presentato uno studio di Nomisma realizzato con Intesa Sanpaolo
È in esame al Senato la proposta leghista di «riduzione dei tempi amministrativi» rendendo (almeno in alcuni casi) non più vincolante il parere degli uffici cui è affidata la tutela dei beni culturali del Paese
Il presidente della Commissione Cultura della Camera, di ritorno dal Tefaf, rivendica di essere stato il primo a proporre l'abbassamento delle aliquote. Dopo la delusione degli operatori per l'assenza di un emendamento ad hoc nel Dl Cultura, annuncia che la sua proposta di legge in aula a maggio conterrà anche proposte sulla notifica e sulla libera circolazione delle opere d’arte