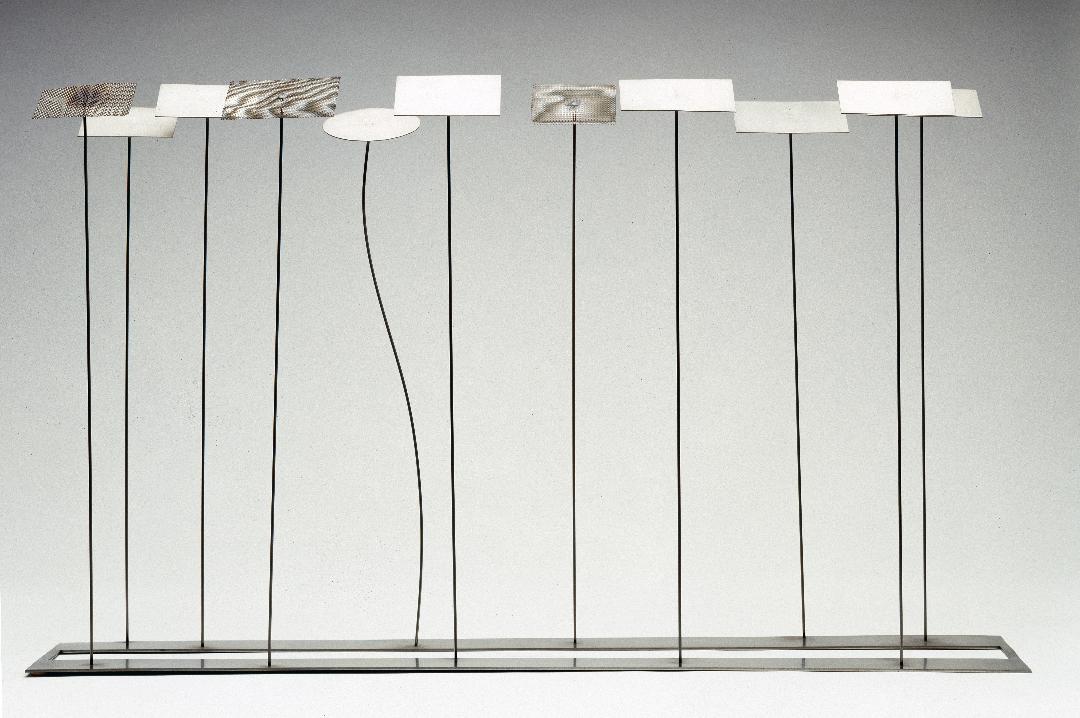Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Franco Fanelli
Leggi i suoi articoliA cavallo degli anni Settanta e Ottanta, quando Roberto d’Agostino a «Quelli della notte» annunciava l’avvento dell’«edonismo reaganiano», conseguenza del famoso «riflusso delle ideologie» e ispiratore di memorabili versi cantati quali «Lo diceva Picasso: io di giorno mi scasso/ma la notte no…», anche il mondo dell’arte si liberò di alcune foglie di fico. Fu allora che alcuni suoi protagonisti diventarono improvvisamente popolari, catapultati nelle case degli italiani dal talk show di Maurizio Costanzo come pittoreschi fenomeni da baraccone.
I critici (lo status di curatore non era ancora sancito) e gli storici dell’arte si dimostrarono più interessanti degli artisti dai quali avevano caso mai mutuato stravaganze comportamentali e guardaroba improbabili. Venne l’ora dei calzini diversi di Achille Bonito Oliva e delle urla di Sgarbi, ma anche della loro penetrazione nella politica, complice la rivincita della destra non necessariamente colta, e dunque della sua necessità di dotarsi di una presentabilità culturale.
Nel 1993, un anno dopo l’elezione di Sgarbi a sindaco di San Severino Marche, Philippe Daverio entrava nella giunta leghista di Formentini come assessore alla Cultura di Milano. Due conservatori, il primo con forti simpatie monarchiche e il secondo, alsaziano di nascita ma milanesissimo d’adozione, figlio di un costruttore, ex gallerista ed editore (sostenitore dell’avanguardia, ma di quella d’inizio ’900) apparvero, come altri loro simili, tra i pochi autentici «eversori», identità rafforzata proporzionalmente allo sbiadirsi del rosso fuoco della sinistra.
Partecipi entrambi del transito che avrebbe portato l’Italia craxiana al berlusconismo, avrebbero percorso vie parallele, aprendone altre ad alcuni imitatori (pensate a Flavio Caroli nel salotto di Fabio Fazio). Daverio, scomparso il 2 settembre a 70 anni, più di tutti ha avuto la capacità di cavalcare diverse stagioni e interpretare ruoli diversi, anche, va pur detto, a seconda di dove tirava il vento dell’economia, della politica e del costume.
Gallerista ed editore raffinato (il primo spazio lo aprì nel 1975 in via Montenapoleone, cui aggiunge, nel 1989, quello a New York), tanto colto quanto commercialmente agguerrito (in fondo, pur senza conseguire la laurea, aveva studiato alla Bocconi), fu tra i primi a capire che l’arte italiana del primo ’900, da de Chirico a Severini, più di altri settori aveva sofferto della scarsità di studi accreditati, della «concorrenza» di altre ricerche coeve ma agevolate dal loro essersi manifestate sul palcoscenico parigino e dell’identificazione, anche inconscia, con un periodo e una cultura da dimenticare: Futurismo e fascismo subivano ancora le loro connessioni; benché già molto falsificato, Sironi scontava la damnatio memoriae arganiana; e sino agli anni Ottanta non era opportuno rivelare in Nietzsche le radici e le ragioni della modernità di de Chirico.
Ma questo gallerista, capace a volte, con molta disinvoltura, di spingersi oltre la spregiudicatezza, ma anche in grado di supportare le sue scelte con una produzione editoriale di prestigio (complice la prossimità di Paolo Baldacci), questo dandy culturalmente onnivoro e poliglotta non ebbe problemi, dopo questi esordi, a unirsi ai «barbari» leghisti della prima ora. Se a Roma il suo omologo socialista Nicolini aveva introdotto nel gusto popolare l’effimero e le luminarie tra le arcate di Massenzio, lui portò tra le Cariatidi di Palazzo Reale stormi di uccelli variopinti per festeggiare il Carnevale ambrosiano, senza dimenticare il restauro del grigio Pac danneggiato da un attentato stragista ordinato dalla mafia.
La mafia, appunto: indimenticabili certe sue invettive, come quando ricondusse alla foggia delle canne della lupara la forma del cannolo. Questo a seguito di questioni di basso profilo (un sospetto di conflitto d’interessi nordista in occasione di un concorso dedicato al «Borgo dei borghi» italiano, quando ribaltò, a favore di Bobbio, in provincia di Piacenza, di cui era cittadino onorario, il voto della giuria popolare che invece aveva premiato Palazzolo Acreide, nel Siracusano) e delle contestazioni subite nel 2010 quando divenne consulente del sindaco di Palermo Diego Cammarata per il Festino di Santa Rosalia.
Altre volte si fece beccare in sortite sovraniste, come nel 2013 quando definì la Biennale di Venezia «un luogo artistico pagato con i soldi degli italiani e comandato da un pool di stranieri», salvo poi, più recentemente e più in linea con la sua anima europeista, lodare il ministro per i Beni Culturali Franceschini per il coraggio di aver chiamato degli stranieri a dirigere i musei italiani.
Al corpulento gourmet e bon vivant con il papillon e i gilet variopinti, che non disdegnava ghette e bombetta, va poi riconosciuto l’intuito di avere identificato nella divulgazione editoriale e televisiva eccellenti canali attraverso i quali «porgere» l’arte a un pubblico che, dati delle mostre alla mano, risultava in forte crescita numerica. «Art’è» e «Passepartout», i suoi programmi televisivi più noti, hanno alfabetizzato alla bellezza un popolo stabilmente piazzato negli ultimi posti delle classifiche mondiali sulla diffusione della lettura.
Se nei suoi libri funziona l’accattivante esca del Grand Tour, nobilitante etichetta per un distratto turismo culturale di massa, se tra le sue molte pubblicazioni e nella stessa rivista «Art&Dossier», il filo conduttore è la rassicurante e fintamente selettiva compilation (Il museo immaginato) o la pedagogia bon ton (L’arte di guardare l’arte, Guardar lontano, veder vicino, Il gioco della pittura), in televisione Daverio diventa l’alfiere degli accostamenti tematici (con buona pace della filologia) e della demolizione delle cronologie nel nome di un eterno e antistorico presente a proposito del quale non è proprio il caso di scomodare il già citato Nietzsche. Più onesto parlare di divulgazione in cui la preziosità di alcune proposte di luoghi «minori» è spesso annullata da grossolane semplificazioni attraverso analogie troppo facili per essere credibili.
E basterebbe paragonare una sua trasmissione ai più «divulgativi» testi e conferenze di Federico Zeri (che finì anch’egli in televisione senza per questo dimenticare di essere uno studioso) per rilevare la debolezza di alcuni prodotti di Daverio, pure abilissimo nel cucire insieme luoghi, nomi e date in piacevoli patchwork.
Non era un connoisseur; ma era curioso e diligente, l’arte amava vederla da vicino, un’abitudine che lo spinse a postulare la sostanziale inutilità dell’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole. Il «ritorno alla pittura» negli anni Ottanta gli aveva aperto qualche varco nell’arte contemporanea (Jori e Cannavacciuolo tra gli artisti trattati), ma come altri della sua generazione e cultura, riuscì ad accettare e ad accostarsi ai leoni del secondo ’900 (Kounellis, tra gli altri) soltanto nel momento in cui la storicizzazione ne aveva apparentemente ammansito la ferocia.
Questa è la ragione per cui i suoi racconti della Biennale di Venezia o addirittura dalla Fiera di Bologna hanno sempre quel sapore un po’ vernacolare (per non dire populista) che lascia intendere quanto il re sia nudo (anche quando non lo è affatto). Era il prezzo da pagare alle esigenze di un copione che pretendeva un progressivo abbassamento di livello, ma anche l’inevitabile destino di un personaggio che non sarebbe dispiaciuto a Gogol, capace di rinnovarsi e mutare continuamente, di riciclarsi ogni volta con estrema abilità, di rinunciare persino a parte di sé pur di svolazzare disinvolto, come le sue mantelline e i suoi papillon, su quasi mezzo secolo di cultura e incultura italiane.

Philippe Daverio
Altri articoli dell'autore
Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale
53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere
Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi
Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)