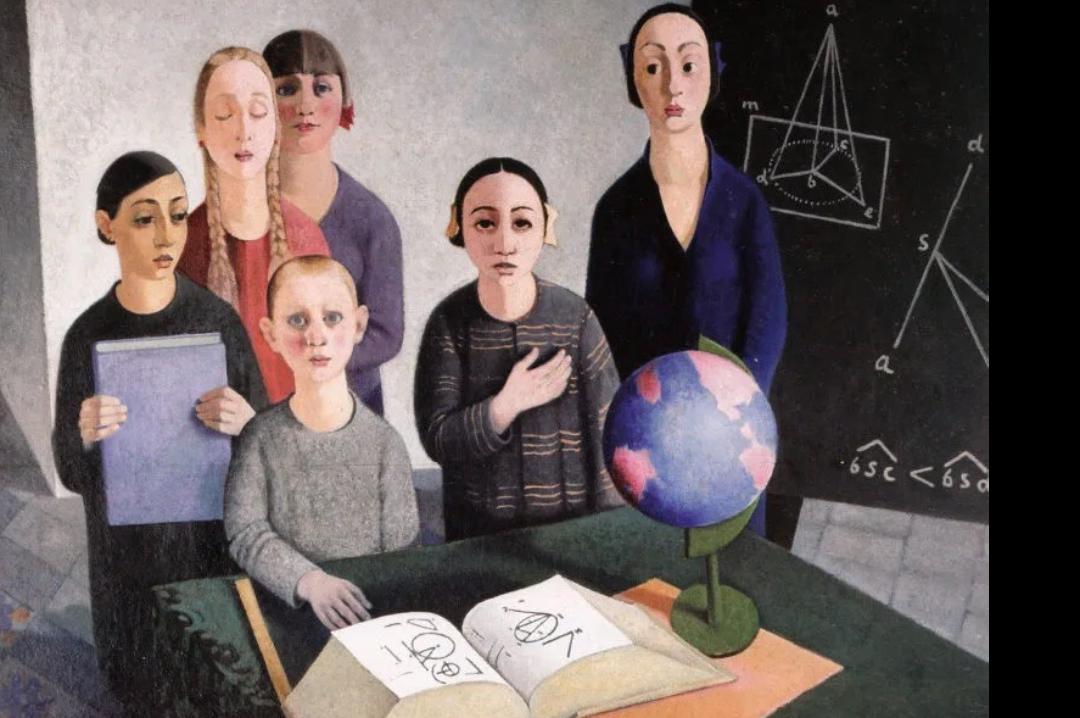Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliI turisti che visitano il circuito delle ville venete sul Brenta, se ben avveduti (sono sgraditi gruppi organizzati vocianti, scolaresche che si comportano come greggi, individui in ciabatte e canottiera), ne ammirano generalmente le superbe architetture palladiane, gli affreschi dipinti dai più grandi maestri della pittura veneta, i dolci paesaggi che si scorgono da logge e finestre. Visitare le ville del Brenta è certamente una delle più belle esperienze che si possano fare in Italia e lascia ricordi indelebili di una struggente bellezza abbinata a un concetto di altissima civiltà.
Vivere in una villa palladiana tutti i giorni è però un’altra cosa. È un problema che riguarda oggi un nucleo molto ristretto di persone, solitamente discendenti delle grandi famiglie che le hanno costruite, e che, per quanto agiate, non si possono certo paragonare ai doviziosi loro antenati.
Queste famiglie fra cui veniva eletto il doge, costituivano nuclei elitari superiori, nei quali tutti si sentivano eguali fra gli uguali e facevano parte di un Libro d’Oro depositato nel Palazzo Ducale di Venezia. Ogni aspetto della loro vita era strettamente sorvegliato e regolato dallo stato che si occupava dei loro comportamenti, legami famigliari, lavoro.
I patrizi veneziani, contrariamente alla nobiltà feudale, avevano nel sangue la vocazione mercantile, il mare e la gloria della Serenissima: un fatto che rendeva queste classi sociali altamente dinamiche e in grado di accrescere enormemente con i commerci i propri capitali, reinvestendone una parte in terre e proprietà agrarie. Questo concetto è alla base della costruzione della fiorita ghirlanda delle ville venete che non erano luoghi di svago (almeno non solo), ma anche tenute agrarie accuratamente amministrate.
Quando a gara, nel Cinquecento, gli aristocratici veneziani incominciarono a costruirne una dopo l’altra, ebbero la fortuna di incrociare sul loro cammino uno dei più geniali architetti mai vissuti: Andrea Palladio.
A una di queste ville, progettata da Palladio nel 1559, una delle più belle, la regale Malcontenta, è dedicato uno squisito libro di Antonio Foscari detto Tonci, che, come denota il cognome, discende da una delle più antiche e illustri famiglie venete. Il libro è stampato con raffinata cura artigianale da Lars Müller ed edito anche in versione inglese; è distribuito nelle librerie e nel bookshop della Malcontenta che è una area territoriale non contenuta del Brenta e soggetta alle esondazioni e non certamente a leggende di fantasmi e di dame infelici.
Abbiamo posto ad Antonio Foscari alcune domande sul suo libro (non certo il primo fra i suoi dedicato a questo genere di argomenti).
La prima cosa che scorrendo il volume è il felice rapporto fra pittura e architettura in Palladio. Che cosa può dirci in proposito?
Il problema della pittura nell’opera palladiana è ampiamente dibattuto. Palladio in realtà non amava pittori come il Veronese che con la loro arte altrettanto potente erano in grado di stravolgere i suoi progetti; alla Malcontenta era stato prescelto come pittore Battista Zelotti, il quale si mostrò invece rispettoso delle idee palladiane assecondandole con i suoi pennelli. Devo tuttavia ricordare che in questa villa sono stati ospiti personaggi straordinari come Le Corbusier che vi venne nel 1934 e che poi sognò di progettare una casa moderna dipinta da Braque e Léger sul filo di quello che aveva qui visto.
Ma come si viveva al tempo del Palladio in ville come la Malcontenta?
Erano considerate case (solo il Palazzo Ducale poteva fregiarsi del titolo di palazzo) e contemporaneamente luoghi di rappresentanza di imprenditori quali erano i patrizi veneziani. Si deve precisare che il concetto di famiglia del tempo era quello di una ditta imprenditoriale. Nelle case vivevano persone di varie età e varie condizioni sociali. Erano edifici molto popolati e vivaci, nulla a che fare con l’idea musealizzata che ne abbiamo oggi. Come case erano decisamente scomode, non vi era alcun concetto di privacy e di igiene. Pochi gli arredi; case minimaliste nel loro rigore architettonico, un rigore che imponeva e segnava anche i comportamenti degli abitanti. Nelle stanze più belle abitava il padrone con i suoi famigliari, nelle soffitte, ma è meglio chiamarle palladianamente «luoghi di sopra», si ricoveravano merci e beni che pativano l’umidità compreso il grano.
Vi era lusso in queste case?
No, gli appartamenti nobiliari erano generalmente composti da tre ampie camere con stanze di servizio collegate; l’ordinamento repubblicano veneziano non apprezzava l’ostentazione del lusso anche in campo edilizio, ritenendo che avrebbe potuto creare competizioni e divisioni all’interno dei ceti dirigenti. In una grande stanza stava la padrona con figli, altre dame e personale di servizio; un’altra stanza era riservata al padrone, che quando desiderava coricarsi con la moglie la mandava a invitar con gentilezza da un paggio.
E oggi come si vive in queste ville?
Si vive normalmente, ma ad una condizione: di rispettare il luogo per quello che è; ma noi tutti in famiglia la sentiamo come vera casa, luogo del passato e del futuro, non certo un luogo di villeggiatura. Non è comunque più la villa cosmopolita e glamour degli anni Venti del Novecento, quando arrivavano frotte di visitatori illustri. Io ci studio e ci lavoro, ma vivere in un capolavoro non è solo una questione abitativa.
Lei ha parlato di visitatori illustri. Ce ne può ricordare qualcuno?
Si va da Sergej Djagilev, a Serge Lifar, a Winston Churchill. Trascorsero qui la loro luna di miele la principessa Margaret d’Inghilterra e il marito Antony Armstrong-Jones, che scattò molte foto degli interni. Fra gli artisti Jannis Kounellis, Andy Warhol, Jean Tinguely, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, per non citarne che alcuni.
Come la videro e la considerarono questi artisti?
Questo luogo è sempre stato apprezzato da studiosi e persone che amano questo genere di cose. Tutti coloro che ho potuto conoscere personalmente ne sono rimasti affascinati e influenzati. Andy Warhol mi disse però che per sapere se gli era piaciuta veramente avrebbe dovuto prima sviluppare le fotografie che vi aveva fatto.
Cosa ritiene si debba fare oggi per ville come questa?
Quest’anno i visitatori sono calati del 78%. È auspicabile che i Governi aiutino i proprietari di queste dimore a tutelarle e a proteggerle. Le ville venete non sono case di lusso, sono un elemento e un volano economico rilevante per il turismo italiano. Noi siamo aperti al pubblico, non viviamo certo in una torre d’avorio, ma avremo bisogno di agevolazioni fiscali, di aiuti; mantenere edifici di questo genere è un impegno continuo, serio e oneroso.
Vivere con Palladio nel Cinquecento, di Antonio Foscari, 128 pp., 71 ill. col. e b/n, Lars Müller, Zurigo 2020, € 25
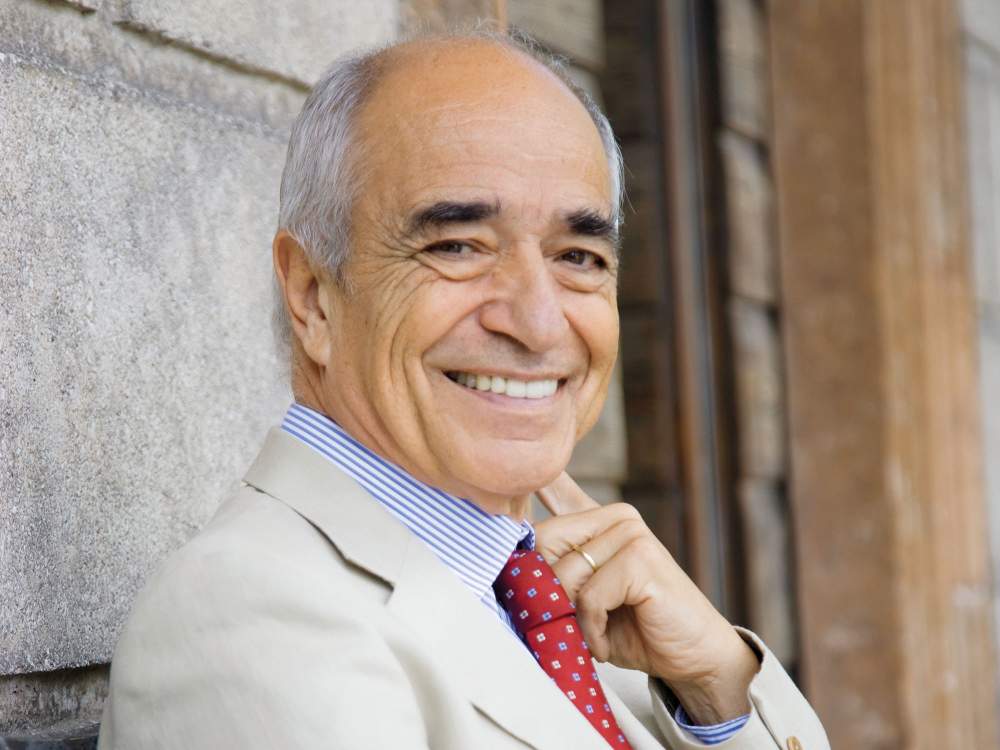
Antonio (Tonci) Foscari

Il vano centrale del piano terra

Villa Foscari
Altri articoli dell'autore
A che cosa serve la giornata indetta dall’Unesco e dedicata a celebrare i libri? A far venire voglia di leggerli, of course
Anche i poveri hanno bisogno di arte e ora che Bergoglio non c’è più siamo tutti più poveri
Ma se volete vedere la bella stagione (quella vera) o sentir parlare di lei, andate nei musei o cominciate a leggere un libro di mitologia
Nella Mole Vanvitelliana sono presentati i restauri delle opere di chiese e musei danneggiate dai sismi del 2016-17 e del novembre 2022