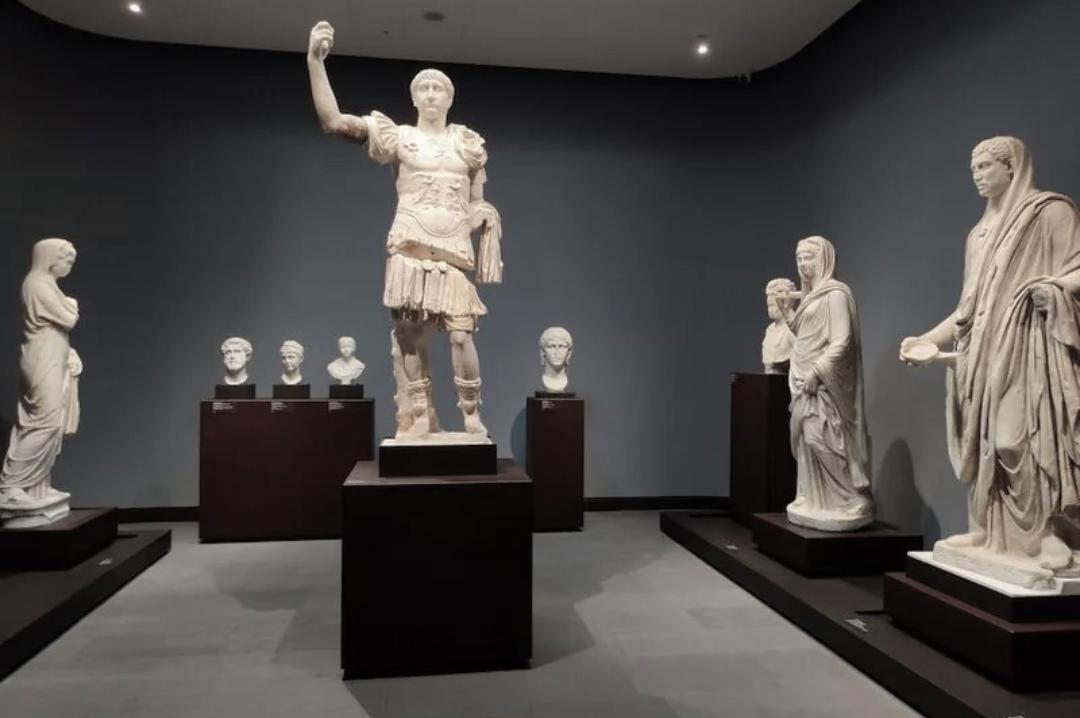Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Tina Lepri
Leggi i suoi articoliIn Italia nei luoghi d’arte ancora si violano le leggi in favore dei disabili, a cominciare dalla Costituzione. Si applicano soltanto parzialmente le Convenzioni Onu del 1993 e 2006 «per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» recepite dall’Italia con la legge n. 104. Si evade la legge Rutelli n. 239 del 2006 e poi la n. 18 del 2009 «che vuole superare i gap sensoriali motori e cognitivi dell’offerta museale», oltre a varie circolari del Mibact e del Miur, rimaste inapplicate. Lo conferma la Regione Emilia-Romagna: «Nel 2015 soltanto la metà dei musei italiani (51,17%) è accessibile alle persone con disabilità». Così lo scorso 7 ottobre ha approvato le linee guida di un provvedimento che permetta «il godimento del patrimonio museale da parte delle persone disabili per superare i loro gap sensoriali, motori e cognitivi» nei 500 siti d’arte della regione. Per disabilità s’intende ancora soprattutto quella motoria, rappresentata dalle persone in carrozzina. Per gli altri, non udenti e non vedenti in testa, il ritardo è maggiore: una recente indagine dell’Unione Italiana Ciechi rileva che su 4mila musei pubblici non arrivano a 100 quelli attrezzati per loro.
E per Icom Italia, Dario Scarpati conferma: «Sul piano legislativo non siamo carenti: il punto è mettere in pratica. Invece è un disastro riguardo alle disabilità cognitive e comportamentali: si fa pochissimo». Gli sforzi del Mibact si concentrano ancora sul prioritario abbattimento delle barriere architettoniche, mentre le altre disabilità ricevono meno attenzione. Anche l’ultimo, importante intervento su 3 chilometri di percorsi a Pompei finalmente accessibili a tutti (cfr. articolo qui accanto) non ha ancora risolto il nodo delle altre disabilità. Anche nella più famosa area archeologica di Roma (Fori Imperiali, Palatino e Colosseo) le barriere architettoniche sono scomparse. Lo stesso è accaduto a Paestum a luglio 2016. Ma non c’è ancora nulla per sordi e ciechi. Un segno di questo ritardo si può constatare anche nei principali musei: tranne poche eccezioni, le attività didattiche per le diverse disabilità sono state delegate a volontari, mentre il personale dipendente specializzato va scomparendo. L’Italia ha per fortuna il record europeo del volontariato: secondo l’ultimo dossier Istat «l’attività gratuita a beneficio di altri» coinvolge 6,6 milioni di persone. Di questi, 4,14 milioni, associati soprattutto in oltre 500 onlus, si occupano anche dei quasi 3 milioni di disabili del nostro Paese: 1,7 milioni hanno disabilità alla vista e all’udito, 189mila sono sordo-ciechi.
Ostacoli sempre L’accesso dei disabili motori in troppi musei non è garantito. Un esempio negativo tra i tanti è Villa Adriana a Tivoli (Roma), dove l’accessibilità del percorso archeologico è molto parziale tanto che alcuni siti web ne sconsigliano la visita. Accade anche che i siti web ufficiali annuncino servizi inesistenti o non funzionanti. Al Castello di Miramare di Trieste (252mila visitatori l’anno) le carrozzine non entrano nel piccolo ascensore nonostante l’accoglienza annunciata dal sito web. Umiliante la situazione alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano: assente ogni servizio per ciechi e sordi, e grave difficoltà per i disabili in carrozzina con gradini disseminati nelle 24 sale; per loro soltanto 12 sono visitabili. Crudele la recente vicenda di Anna e Gino Cardinale all’Ambrosiana: «L’ascensore è stretto, la mia carrozzina elettrica non entra ma nessuno ci ha avvisato. Con Anna abbiamo smontato tutti i pezzi possibili e li abbiamo poi rimontati un volta arrivati al primo piano. Qui altra sorpresa: l’ascensore non arriva al secondo piano». Stessa disavventura (giugno 2016) per Salvatore Allegri, da anni in sedia a rotelle, che ha tentato inutilmente di superare le scale d’ingresso del Museo Archeologico Regionale di Agrigento. I quattro montascale elettrici sono fuori uso. Dopo 5 mesi (dicembre 2016), niente è cambiato. Eppure i soldi non mancano. Proprio il museo di Agrigento nel 2016 ha perso 600mila euro di fondi europei destinati proprio all’accessibilità per i disabili. Ogni museo pubblico dovrebbe applicare le regole della Carta della qualità dei servizi, una direttiva del Mibact del 27 gennaio 1994, che impegna ogni museo a «promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso e la fruizione alle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva».
Qualcosa si muove Non tutto è negativo: negli ultimi anni qualcosa si è mosso. A Torino, dove perfino il Museo Egizio, tra i più visitati d’Italia e da poco rinnovato, non ha alcuna attrezzatura per sordi e ciechi (ma solo una visita guidata «tattile», limitata ad alcune sezioni), da anni il Museo del Cinema li accoglie con tecnologie d’avanguardia, personale preparato e ben organizzato per ogni disabilità. Proprio a Torino nel 2015 è partita la seconda edizione dei corsi gratuiti per 200 operatori delle disabilità finanziati dalle Fondazioni Crt e Paideia. «Contribuiamo ad abbattere le barriere culturali, che sono più ingombranti di quelle fisiche», dice Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt. Le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il più famoso e visitato museo italiano (3 milioni di persone all’anno) è anche il migliore per l’accoglienza dei disabili di ogni tipo. Non serve prenotare, caso rarissimo in Italia. Il percorso tattile in braille, nato nel 2012, sorprende per il numero di marmi originali, ben 16, che i ciechi possono toccare con guanti trasparenti: anche il vero «Cupido dormiente» di Michelangelo e il leggendario «Ermafrodito». Li «leggono» con le mani, come fanno con i calchi a rilievo dei ritratti del Bronzino e della «Venere» di Botticelli, scoprono i pieni e i vuoti e comprendono le forme. L’espositore dei «quadri» è esagonale per una migliore visita tattile, con l’ausilio della speciale audiocassetta. «Per me, ha scritto un visitatore, significa poter toccare i pensieri racchiusi nelle parole. Significa libertà di leggere l’arte senza intermediari, in silenzio come fanno i vedenti. Legare il braille all’arte, al sentimento più bello, è come nascere davvero». Nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino sei dei più celebri dipinti esposti (anche Raffaello e Piero della Francesca) sono accessibili ai non vedenti con riproduzioni tridimensionali in resina oltre a un plastico del Palazzo Ducale, audioguide e un dispositivo smartphone con funzione Nfc (Near Field Communication, letteralmente «Comunicazione in prossimità»). Videoguide e tablet nella lingua dei segni (Lis) per i sordi. Fa parte del progetto «Cultura senza ostacoli», finanziato dal Mibact e attivo dal 2014. La Regione Marche ha in programma anche l’abolizione delle barriere architettoniche in 31 musei dei piccoli centri ora non accessibili, con il sostegno economico di diverse imprese e l’ausilio tecnico del Museo tattile statale Omero di Ancona.
Anche a Milano è in corso un cambiamento. A Brera, museo simbolo della città, stanno partendo i primi progetti. Invece alle Gallerie d’Italia (aperte nel 2012 da Banca Intesa Sanpaolo) si possono prenotare visite guidate gratuite per persone con deficit visivo. Si usano immagini a rilievo «consultabili tattilmente» e affiancate da una scrittura braille: con il sostegno di mediatori culturali i disabili visitano il museo con l’ausilio di tavole a rilievo che riproducono le opere selezionate. Tutto realizzato in collaborazione con il Centro di Riabilitazione visiva dell’Irccs Fondazione Maugeri di Pavia e del Museo Omero. Epocale la rivoluzione avvenuta in 15 chiese di Milano, importanti scrigni d’arte. Dal 21 agosto sono state eliminate tutte le barriere, architettoniche e non a Santa Maria delle Grazie, Sant’Eustorgio, San Lorenzo ecc. grazie all’opera della onlus Tactile Vision e dell’Unione Italiana Ciechi. A disposizione pannelli che integrano la comunicazione visiva, tattile e uditiva, piante a rilievo, didattica storico-artistica: con lo smartphone si inquadra il Qr Code e si accede ai contenuti video con traduzioni dei segni in Lis.
Così all’estero I primi progetti per consentire ai disabili di visitare i musei sono iniziati negli Stati Uniti 40 anni fa. Presto sono seguiti i Paesi Bassi. Si è posto subito il problema di abbattere non soltanto le barriere architettoniche, ma anche di creare programmi permanenti per ciechi, sordi e, più di recente, per chi soffre di handicap cognitivi come Alzheimer, autismo, Parkinson. Tra i musei più attrezzati, antesignano è il MoMA di New York che offre programmi specifici anche per demenza senile e Parkinson. Lo stesso avviene al British Museum, al Louvre, al Kunsthistorisches di Vienna e nei principali musei olandesi, tedeschi e spagnoli. Per i parcheggi riservati basta una telefonata. Nella maggior parte dei grandi musei d’Europa i disabili, per esempio i ciechi, trovano gratis guide specializzate, quasi sempre bilingui, che offrono assistenza didattica. Per i non vedenti sistema braille nelle sale e cuffie di ultima generazione, per i non udenti non soltanto la lingua dei segni ma operatori che usano il sofisticato Is, International Sign Language: un nuovo sistema che ingloba solo una parte dei 1.500 «alfabeti» usati dai sordi nei principali Paesi, selezionati dalla Federazione Mondiale dei Segni. Completano la lettura labiale con gesti vicini alla bocca, adatta soprattutto per i bambini disabili, che si vedono spesso nei musei stranieri mentre da noi sono assai rari. Senza contare che con queste attrezzature i bookshop di questi musei fanno anche buoni affari.
Il ruolo dei volontari Oltre agli Uffizi, altri musei si stanno attrezzando non soltanto per accogliere i disabili motori, ma anche i non vedenti e non udenti. Pesa la diminuzione delle risorse pubbliche ma «non è soltanto questione di soldi», secondo Maria Poscolieri, architetto, vicepresidente dell’Associazione Museum, una delle maggiori organizzazioni di volontari del Paese. «È un problema di cecità culturale che riguarda anche il nostro ruolo. I volontari che si occupano dei disabili vengono spesso visti come persone di buon cuore senza speciali competenze. Ma tra noi ci sono tanti architetti, ingegneri, storici dell’arte. Siamo stati noi a realizzare i percorsi e le strutture per ciechi e sordi dei Musei Capitolini di Roma. Io stessa, come architetto, ho realizzato i grafici per i modelli tattili, le planimetrie a rilievo. Adesso stiamo attrezzando a Roma anche la Galleria nazionale di Palazzo Barberini». Tra i volontari, in prima fila vi sono quelli dell’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) che hanno permesso ai non vedenti di visitare le sale di Palazzo Te a Mantova. A Trento il nuovo Muse-Museo della Scienza progettato da Renzo Piano è efficiente per i servizi ai disabili motori e tutto è pronto per ciechi e sordi anche se manca per loro un’assistenza quotidiana: bisogna prenotare con due settimane di anticipo, come del resto avviene in molti altri luoghi d’arte. Il Muse ha così proposto di creare lo Scup, Servizio Civile Universale Provinciale: un anno di lavoro retribuito per i giovani che scelgono il servizio civile. Titolo del progetto: «Approcci non convenzionali per avvicinare ciechi e sordi al Muse».
Un caso speciale Un volontariato particolare è quello di Felice Tagliaferri, uno scultore cieco che rende possibile ai non vedenti la visita alla Guggenheim Collection di Venezia, una città invasa da turisti anche disabili dove però nulla è stato realizzato per l’accoglienza di ciechi e sordi nei Musei civici (Correr, Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro, l’Archeologico, Palazzo Fortuny ecc). Il Comune distribuisce gratis una carta in braille per l’intera visita di Venezia: ponti, calli, campielli alla portata dei non vedenti. Clamoroso l’evento culturale creato, nel 2011, da Tagliaferri all’Archeologico di Napoli, il più importante del Sud, dove manca qualsiasi attrezzatura per ciechi e sordi: per loro ha esposto nel museo il «Cristo rivelato», una sua copia in marmo pesante 18 quintali del famoso «Cristo velato» della cappella Sansevero (intoccabile da tutti). Il «Cristo rivelato» di Tagliaferri è rimasto a disposizione della esplorazione tattile dei non vedenti. La statua è stata accolta da molti musei italiani con grande successo.
Due musei speciali Oggi trasferito nella Mole Vanvitelliana di Ancona, il Museo Tattile Statale Omero è un'eccellenza del Mibact. Da oltre vent’anni viene considerato il museo modello per ciechi e ipovedenti: espone più di 150 copie di opere d’arte dalla classicità a oggi, tutte «da toccare» (ingresso gratuito e visita guidata a 3 euro). È possibile anche la navigazione vocale gratuita chiamando il numero verde 800202220. «Omero» invia anche gratuitamente a non vedenti e ipovedenti dépliant e schede delle opere in formato audio o braille. Sono molti i giovani dai 18 ai 28 anni che, grazie alla legge n. 64 del 2001 sul Servizio civile, sono a disposizione nel museo Omero per la visita di persone con disabilità visiva. Nel 2007 gli specialisti del museo hanno trasformato la sala Dai di Palazzo Reale a Napoli nel luogo della «accessibilità universale», percorso tattile guidato da operatori, video con la storia del Palazzo Reale in lingua dei segni e cartoon per chi ha deficit cognitivi. Un secondo museo tattile dedicato ai non vedenti è l’Anteros di Bologna (dove, ad esempio, il MAMbo non è attrezzato per accogliere i ciechi). L’Anteros espone una serie di «traduzioni» tridimensionali di celebri dipinti dal Medio Evo all’età moderna e fornisce un servizio didattico gratuito basato sui principi di una particolare psicologia della percezione ottica e tattile che comprende sia la tiftologia (scienza che studia i problemi delle persone con disabilità visiva) sia la speciale teoria dell’arte e della pedagogia destinata a chi soffre di minorazione visiva. Questo per educare «all’uso integrato dei sensi residui per rafforzare le facoltà percettive, cognitive e intellettuali delle persone disabili della vista», spiega la storica dell’arte Loretta Secchi, responsabile del museo Anteros. Da 22 anni si occupa dell’integrazione di ciechi e ipovedenti e lamenta che allora agivano nei musei «funzionari che conoscevano e applicavano metodi adatti ad accoglierli. Oggi, senza gli specialisti delle associazioni di volontariato, per i non vedenti e per tutti sarebbe il buio totale».
Esistono anche musei che dicono di aver risolto i problemi di ciechi e sordi oltre che dei disabili motori. Non sempre è così. A Cefalù, il Museo Mandralisca, famoso per il suo Antonello da Messina, dal 2015 presenta un percorso tattile per non vedenti con lo slogan «È vietato non toccare». «È un atto di buona volontà ma anche una bugia, dice Peppino Re, della locale Unione Ciechi. Non è un vero percorso tattile: sono in mostra 18 riproduzioni di reperti archeologici da toccare, ma mancano di supporti braille e sonori».
Dunque in Italia i diritti dei disabili sono spesso negati, applicati soltanto in alcuni musei e siti, pubblici e privati. Ci si accontenta di celebrazioni e giornate «speciali». Eppure ogni 3 dicembre dal 1982 la Giornata Internazionale delle persone con disabilità è stata istituita dall’Onu «per allontanare ogni forma di discriminazione ogni giorno dell’anno, perché la disabilità non è un fatto privato che riguarda le persone singole e le loro famiglie ma l’intera comunità che deve rendersi “abilitante” rispetto ai bisogni di tutti i cittadini». Così in Italia ancora non è.
Altri articoli dell'autore
La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria
La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria
La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria
La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria