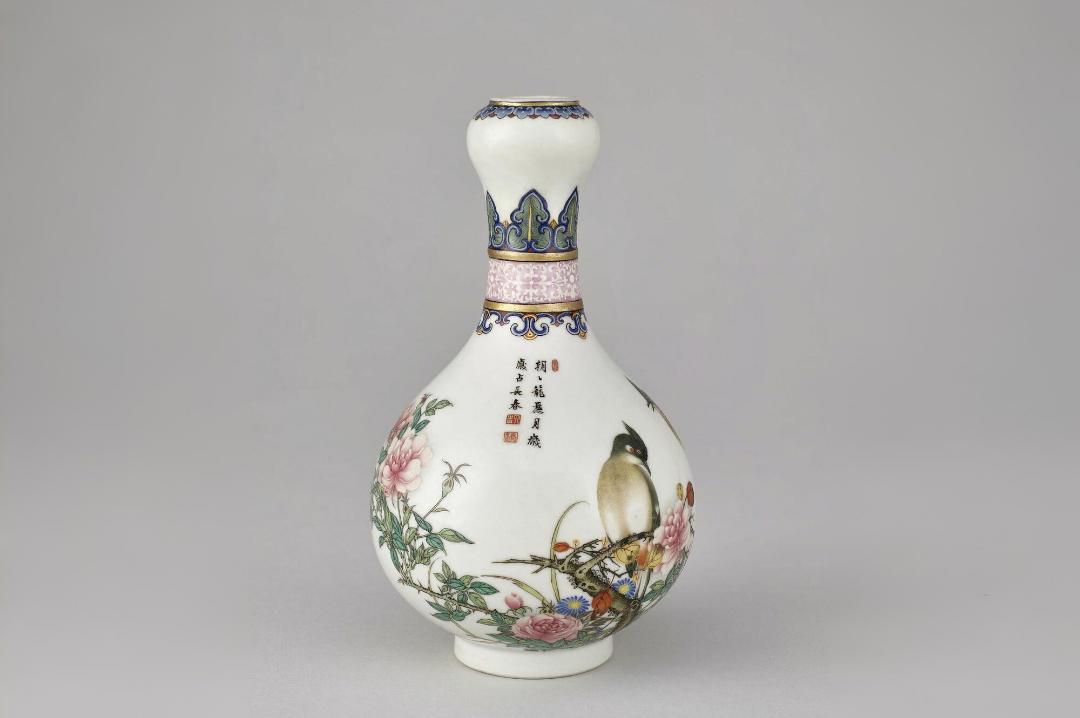Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliAl visitatore che arriva al Louvre con l’idea di percorrere il sentiero più battuto, quello che dalla Nike di Samotracia porta alla Gioconda, ci piacerebbe dire che il museo ha appena aperto delle nuove sale fresche di restauro. Il Louvre si rinnova: per ragioni tecniche di messa a norma, certo, ma anche per invitare i visitatori a uscire da quei sentieri battuti e avventurarsi in altri luoghi. Le ultime sale restaurate sono quelle della scuola olandese e fiamminga, riaperte in febbraio in concomitanza della mostra su Vermeer (fino al 22 maggio). Non venivano rinnovate dai tempi del Grand Louvre. Circa 600 quadri sono stati auscultati e in alcuni casi restaurati, come «Il cespuglio» di Ruysdael. Lungo il percorso, i capolavori di Vermeer, la «Betsabea» di Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Jordaens. Già a novembre, il Louvre aveva portato a termine un altro cantiere, quello delle sale della scuola francese del XVII secolo, chiuse dal 2011. Anche in questo caso è stata effettuata una gigantesca operazione di pulitura e restauro di un migliaio di quadri e delle loro cornici. Sono riallestiti i grandi formati di Le Brun, è tornata la «Madeleine à la veilleuse» di Georges de La Tour. L’ala si attraversa tra i David, Ingres, Géricault, Delacroix. E nuovi lavori sono già in corso nell’ala della scuola francese fino a Poussin. «Da quando le sale francesi del XVII sono state riaperte, sono maggiormente visitate», ha osservato il direttore del dipartimento dei Dipinti, Sébastien Allard, parlando a un gruppo di giornalisti a margine della visita dell’ala olandese e fiamminga. L’attuale interesse per Veermer, grazie anche alla fama della «Ragazza con l’orecchino di perla», potrebbe creare maggiore affluenza anche qui.
Come portare il visitatore verso luoghi e oggetti che non conosce è una delle preoccupazioni dei conservatori del museo più frequentato del mondo. L’altra grande sfida va di pari passo: riuscire a «decongestionare» i punti «critici», come la Sala degli Stati, quella della Gioconda. «Ci pensiamo praticamente tutti i giorni, ma non troviamo la soluzione», confida Allard. Il Louvre «osserva» regolarmente i suoi visitatori. Anne Krebs è la responsabile degli studi socioeconomici al museo: «Il visitatore del Louvre spesso viene per la prima volta, non è abituato al museo e non è competente in storia dell’arte. Allora vuole vedere le icone. I capolavori sono come boe che gli permettono di costruirsi il percorso. Si sentono rassicurati solo dopo aver visto le poche opere che si erano fissati di vedere». Il Louvre ha collaborato con il Mit di Boston per realizzare uno studio dei tragitti di visita, i cui risultati saranno pubblicati a giugno negli Stati Uniti. Si è notato che il visitatore tende a fermarsi nelle sale dove c’è più gente, mentre attraversa rapidamente quelle meno affollate (dove, si ritiene, a torto, che non ci sia nulla di interessante da vedere). Allo stesso tempo, la folla, se raggiunge la «soglia critica», produce l’effetto contrario e lo fa «scappare», anche in presenza di un capolavoro. «L’affluenza gioca senz’altro un ruolo nella sala degli Stati, spiega Anne Krebs. Molto dipende dalla percezione che ognuno ha della folla, che è anche un fattore culturale. Si può dire che c’è un “effetto Gioconda”. In media i visitatori si fermano pochi minuti nella sala e si concentrano quasi esclusivamente sulla contemplazione del capolavoro di Leonardo. Ma è interessante notare che il livello di benessere delle persone è indipendente dal tempo di presenza. Ci si può fermare poco ma essere soddisfatti».
Soddisfatti, ma spesso delusi. Ecco un’altra questione che impensierisce il museo: «Ci siamo posti il problema di come fare per evitare la delusione che si crea nel momento del contatto con l’opera», osserva Allard. Anne Krebs conferma: «Il primo sentimento di chi si trova per la prima volta davanti alla Gioconda è la sorpresa per le sue dimensioni. Il quadro è circondato da una tale aura che le persone se lo aspettano più grande. Talvolta alla sorpresa segue la delusione. Si viene come in pellegrinaggio, ma non si capisce perché». Sui social e nelle chat si leggono commenti di questo tipo: «Per quanto riguarda la Gioconda, ci sono rimasta malissimo. Non vedevo l’ora di vederla e poi mi sono trovata davanti a un quadro piccolissimo!», scriveva una visitatrice su TripAdvisor nel 2012.
Allora, perché la Gioconda delude? Lo abbiamo chiesto al professor Pietro C. Marani, uno dei maggiori esperti di Leonardo: «Stiamo pagando lo scotto dell’uso e abuso che è stato fatto dell’immagine, ma anche della visione romantica che circonda la figura di Leonardo, di cui in un certo senso la Gioconda è la trasposizione fisica». Secondo lo studioso, davanti al capolavoro entrano in gioco «filtri fisici e mentali». Spiega: «Ritengo che l’allestimento attuale contribuisca a rimpicciolirla. Il quadro sembra un francobollo su un’immensa parete vuota. Inoltre il visitatore è tenuto a distanza da un cordone e lo vede attraverso una bacheca. Se si potesse avvicinare forse l’effetto sarebbe diverso. È chiaro però che chi si lamenta perché la Gioconda è piccola, ignora le dimensioni dei ritratti rinascimentali. Ma c’è anche una ragione più intrinseca al quadro, aggiunge Marani. L’effetto è dato anche dalla monumentalità del busto di donna che grandeggia sul paesaggio. Le proporzioni geniali studiate da Leonardo suggeriscono un carattere grandioso che, se emerge da un’immagine al computer, si coglie più difficilmente dal vivo».
Cosa fare? «Per i conservatori e i direttori dei musei, non solo per il Louvre, lo sforzo è immane. Il visitatore non va più nei musei per istruirsi (per questo ci sono le mostre) ma per trovare conferma a ciò che già sa, spesso nozioni elementari. Non vuole fare sforzi intellettuali. La tendenza dei musei è di assecondare questo pubblico impreparato ed esigente, ma non credo che debbano rinunciare alla loro funzione educativa». Tornando alla Gioconda? «Forse si potrebbe fare come a Milano per il Cenacolo. Mentre le persone aspettano per la visita vengono fornite loro brevi informazioni. Per la Gioconda forse basterebbe ricordare le principali interpretazioni, spiegare che Leonardo vi ha concentrato le sue teorie artistiche e scientifiche. La Gioconda non è una pittura romantica, non è neanche una donna molto bella secondo i canoni di oggi. Quando, una quindicina di anni fa, il Louvre mi consultò e ebbi l’occasione di prenderla in mano, di vederla come se fosse viva, per me fu uno shock. Mi dico che se non si riesce a far scattare l’emozione è normale che si resti delusi».
Altri articoli dell'autore
Esposte al Louvre oltre 170 opere della collezione personale del primo presidente della Terza Repubblica francese
Triplice appuntamento nel centro culturale in Provenza: una collettiva allestita da Tino Sehgal, l’Ong E.A.T e l’opera grafica di Maria Lassnig
Attraverso 260 opere il Louvre traccia il ritratto di una civiltà «rimasta a lungo ai margini degli studi accademici», un popolo di soldati, ma anche di commercianti, architetti, scienziati e artisti
A quarant’anni dalla pubblicazione, le fotografie raccolte nel libro «In the American West» vengono esposte, per la prima volta in Europa, alla Fondation Henri Cartier-Bresson