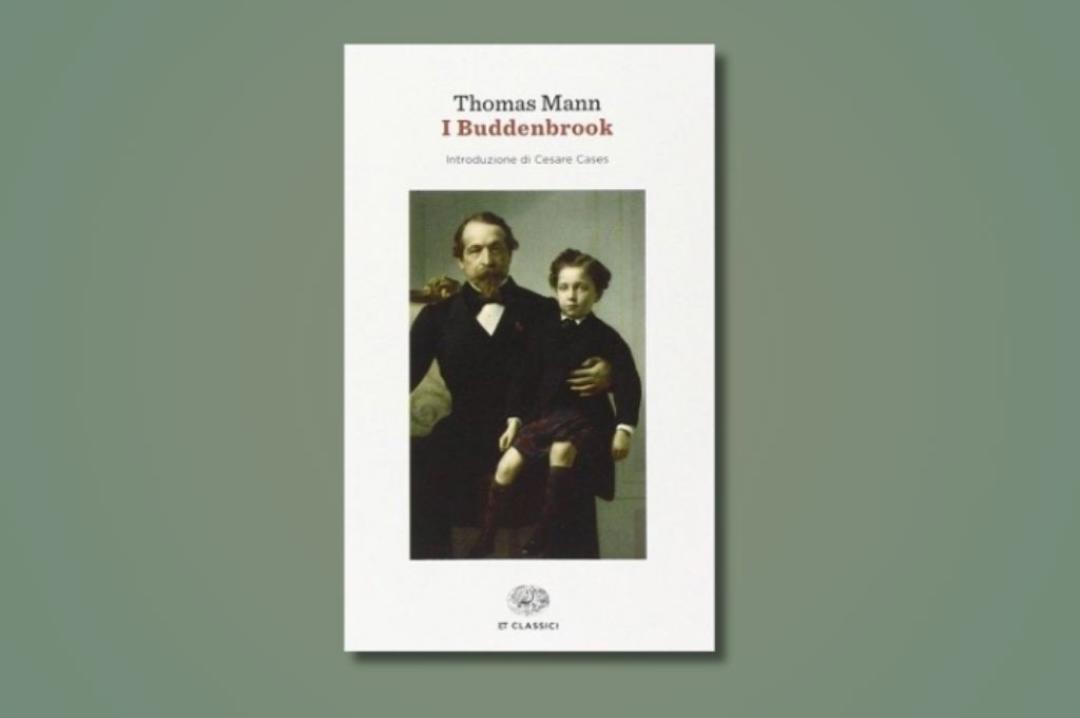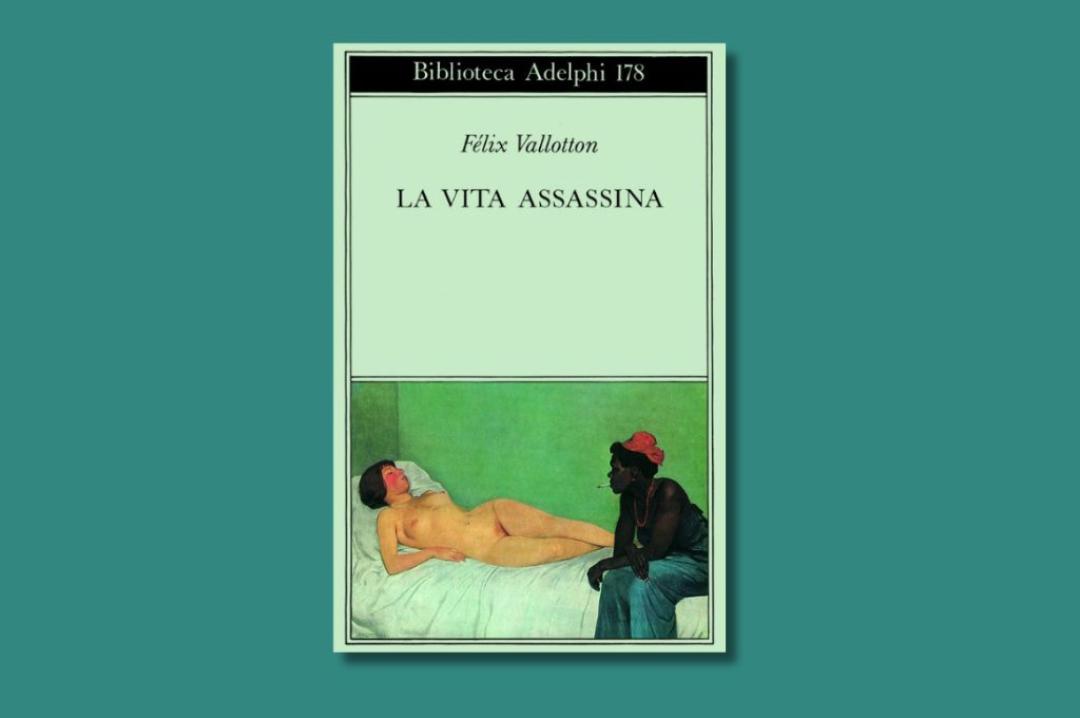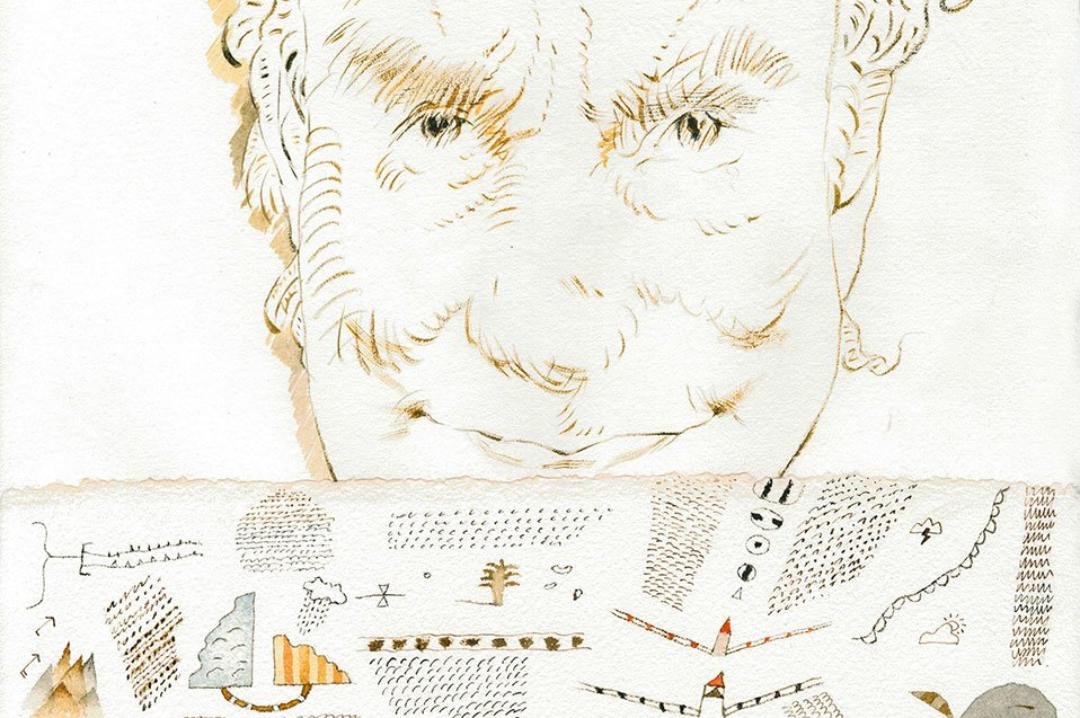Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa
Leggi i suoi articoliIl «Grand Louvre» con le piramidi e i suoi otto milioni e mezzo di visitatori l’anno è un mostro mirabile di cui prendere atto, da accettare e rubricare nello spirito del tempo. Lo abbiamo visto e rivisto e le sue mutazioni hanno accompagnato la salita del mestiere di storici d’arte. Siamo tutti un poco Louvre, molto di più di quanto non siamo Uffizi, Prado o National Gallery. Che cosa resta ancora da dirne? Recuperare, magari, la portata di qualche stecca dal coro. Sono passati quindici anni da quando Pietro Citati, scrittore fiorentino di adozione ligure e torinese, scomparso nel 2022, tirò una bordata contro quello che considerava uno dei musei peggiori della terra.
Fortezza, Bastiglia, lager, industria, stadio, stazione, reggia. E aggiungeva: cittadella e aeroporto. Al Grand Louvre, senza considerare la nuova sede di Abu Dhabi, «si può fare di tutto: mangiare, comprare libri, passeggiare, chiacchierare, amoreggiare, correre, fare jogging, dormire, sognare: mai guardare un quadro». Citati aveva torto perché ragionava da uomo cresciuto nel secondo ’900, con una memoria di carta e un’adesione sentimentale e culturale diversa al mondo dei musei.
E allora come presentare al mondo che converge su Parigi il Louvre del nuovo millennio, dove l’incontro con le opere (l’approccio come si dice nel nostro italiano scortecciato) è il segmento di un braccio esteso dove si combinano, confondendosi, alta informazione, ristorazione, narcisismo, inesausta emissione di selfie, shopping compulsivo, gadget, libri, passioni riaffioranti dinanzi alle opere, erudizione, quadri, arazzi, affreschi, sculture, arti decorative, strascinamento di piedi e fancazzismo?
Come offrire le portate di questo banchetto a un adolescente che il Louvre conosca per sentito dire e avvicini il mondo con la scorta del preservativo cellulare vedendo tutto diaframmato, come a mezzo servizio? Come introdurre il Louvre a chi abbia una soglia di attenzione risicata da ricontattare con aumenti di volume, sputi e schiaffi? E che cosa dire invece a chi lo abbia affrontato migliaia di volte, a morsi e senza venirne a capo come si conviene al Museo per antonomasia, il peggiore dell’universo per il vecchio Citati?
Gli ultimi cui chiedere conforto siamo, senza offesa, noi storici d’arte che, in tema di comunicazione, in Italia, la sappiamo cortissima: per snobismo, educazione visiva fondata sulla strategia dell’attenzione, strenua capacità di imbarcare dati e speculare incapacità nel comunicarli. E per rassegnarsi al fatto che la comunicazione dell’evento sia oggi più importante dell’evento stesso, nessun monumento campione è migliore del Grand Louvre (non certo il «vecchio, amabilissimo Louvre» che piaceva al Citati analogico). Cantante e abile promotrice di sé stessa Beyoncé, che in questi giorni compie quarantatré anni, non aveva bisogno che qualcuno glielo ricordasse: il Louvre non lo batti, è la più grande cassa armonica che esista.
Sei anni dovrebbero essere un tempo sufficiente perché si sedimenti il giudizio su sei minuti di musica e parole. E tanti ne sono passati da «Apeshit», il pezzo suo e del marito Jay-Z, classe 1969, interamente ambientato al Louvre, sotto la direzione di Ricky Saiz, su cui è doveroso rinfrescare le idee tanto il video è più importante e rappresentativo di quanto non sembrasse già nel 2018 (prima dei gilet gialli, del Covid-19, delle Olimpiadi di Parigi e che Marine Le Pen provasse a sormontare senza successo apparente alla guida del Paese).
Al Louvre Beyoncé e consorte sono la musica afroamericana universalmente dominante che dialoga con la civiltà dell’Occidente europeo nel suo nucleo potente, nel suo cuore simbolico. Ma lo fa a modo suo: muovendosi nelle sale e inscenando, dinanzi ai feticci dei museo, dalla «Nike» di Samotracia ai naufraghi caravaggeschi della «Zattera» di Géricault, una diversa commedia umana coi propri simboli e istanze; i propri codici, come si dice oggi. Con beat scurissimo, iterativo e quanto di più lontano si possa immaginare dalla passione cantabile, è questa la potente colonna sonora del Louvre multiculturale.
Con versi ardui da rendere decentemente in traduzione, «Apeshit» elenca le stazioni di una vita inimitabile, con i suoi item e il collante dei soldi a tenerne le fila. Ma questa claustrofobica e poco rasserenante performance di arte contemporanea non è la «Vie en rose» e neanche il sax di Gato Barbieri in «Ultimo tango». Sulla coppia dei Carter in piedi che dà le spalle alla «Gioconda» o che siede, con Beyoncé fasciata di Versace, al principio della Grande Galerie terminano gli ultimi capitoli di quel Mito di Parigi con cui siamo cresciuti e che ci ha aiutato a vivere.
Altri articoli dell'autore
Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti
Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte
Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure
Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso